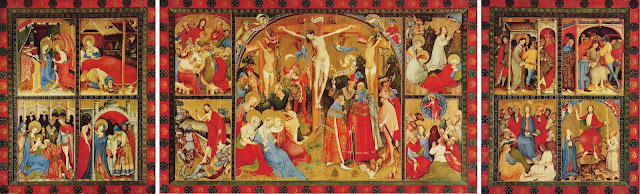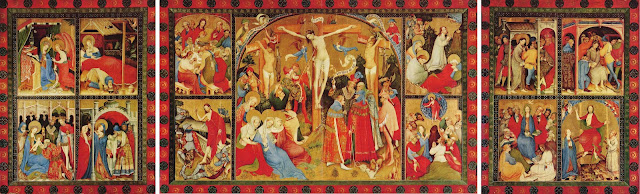Nel Seicento, gli Olandesi diventarono leader nei viaggi marittimi, nei trasporti, nel commercio e nella sicurezza della navigazione. Mentre le loro enormi navi da carico e quelle da guerra attraversavano gli oceani, le loro navi di piccolo tonnellaggio e i pescherecci navigavano invece nell'entroterra e nei corsi d'acqua costieri. L'acqua, croce e delizia per gli Olandesi, fu un elemento fondamentale per i loro successi economici e marittimi, ma era anche fonte di piacere e di divertimento: nei caldi mesi dell’estate, le spiagge coperte di dune offrivano infatti splendide vedute panoramiche, mentre d’inverno i canali ghiacciati fornivano un luogo per pattinare, per giocare e per godersi la vita all'aria aperta per gente di tutte le età. In una nazione di marinai e di pattinatori non sorprende quindi che i pittori olandesi siano stati se non gli “inventori” del genere della “pittura marittima”, almeno i perfezionatori e tanto meno stupisce che questo soggetto sia stato così straordinariamente popolare e praticato, non meraviglia inoltre che i soggetti marini siano diventati i preferiti dei collezionisti e degli artisti del periodo né sorprende infine che questo genere sia stato elevato a nuove vette dai pittori olandesi che avevano un abbondante mercato. Ai tempi di “Hals”, di “Rembrandt” e di “Vermeer”, cioè negli anni di punta dell’arte olandese del Seicento, essi dipinsero opere superlative e appassionanti e, come successe per i paesaggi di terra, fu fondamentale il passaggio alla veduta artificiale soprelevata cioè “a volo d’uccello”, tipica della precedente pittura. Con la pittura olandese il mare diventò dunque un nuovo e grande soggetto d’arte. Le opere che celebravano il loro commercio, che commemoravano le loro vittorie militari e che ritraevano i paesaggi marini diventarono un genere molto popolare al servizio dei gusti della prospera “Repubblica olandese”: mecenati aristocratici e ricchi borghesi commissionarono opere destinate sia al godimento privato sia all'esposizione pubblica. Queste opere furono le prime in cui artisti europei raffigurarono realisticamente ambienti naturali marini, rendendo le atmosfere costiere e quelle oceaniche con straordinaria attenzione e con virtuosistica tecnica. Del resto che cosa può uguagliare il mare come soggetto di rappresentazione per la sua versatilità, per molteplici stati d'animo che è capace di suscitare e per gli effetti ottici di acqua e di luce così coinvolgenti? I maestri olandesi della pittura e del colore, attratti dai paesaggi marini, svilupparono nuovi approcci alla composizione e alla tecnica. Maestri com’erano dell'aria, della luce e dell'acqua, essi usarono il loro talento per trasmettere sulla tela un mondo magico, ricco di allegorie politiche e di allusioni religiose: una nave poteva rappresentare con la stessa forza il progresso individuale di un'anima o il destino unitario di una nazione. Tempeste e naufragi fornivano un ampio e drammatico scenario, allusivo di evidente pericolo da parte di una potenza superiore, mentre rocce seminascoste suggerivano il senso dell’insidia del mistero, dell’incertezza o addirittura del soprannaturale. Affermazioni o sconfitte militari assumevano significati che esprimevano chiaramente la posizione politica o spirituale dell'artista – o quella del suo mecenate – in termini di consenso o di dissenso. Quando gli Olandesi incominciarono a emergere come potenza militare ed economica mondiale, mostrarono attraverso la loro arte un'immagine sempre più fedele del loro paese e del loro stile di vita. Il mare e i vascelli che lo attraversavano avevano un significato ricco di simboli, da cui gli artisti fiamminghi e olandesi traevano naturalmente il linguaggio visivo che i soggetti marittimi offrivano. Le esplorazioni e l'espansione globale dell’Olanda ne animarono la pittura, alimentando un particolare desiderio per le scene tanto scandinave quanto mediterranee e le relazioni commerciali finirono per modificare anche il gusto e l'immaginario degli Olandesi con la rappresentazione di abeti e di ghiacciai del nord e di monumenti e rovine idealizzati del sud. Gli appassionati d'arte cominciarono ad avere familiarità con le ambientazioni italiane e la loro semplice vista evocava piacere, eleganza ed esotismo.
* * *
Di solito, un pittore olandese del Seicento rientrava
in una di quattro categorie, “ritrattista”, “paesaggista”, “pittore di
nature morte” o “pittore di scene di genere”. Per questa ragione la loro
pittura raggiunse un elevatissimo grado di specializzazione e per questa stessa
ragione raramente un artista poteva sperare di raggiungere grandezza e successo
in più di un genere di pittura. Alcuni pittori però e tra loro “Jan van Goyen”
(1596 – 1656) e “Jacob van Ruisdael” (1628/29 – 1682), si sono divertiti a
catturare anche i dintorni marini dentro e intorno alla costa olandese.
Osserviamoli più da vicino. “Jan Josephszoon van Goyen” era un paesaggista di
Leida. Si mosse ad ampio spettro nel genere: dipinse infatti paesaggi
forestali, marini, fluviali, urbani, invernali, scene di spiagge, vedute architettoniche
e anche paesaggi con contadini. Artista estremamente prolifico lasciò circa
milleduecento dipinti e più di mille disegni. Van Goyen iniziò come apprendista
a Leida ma come molti pittori olandesi del suo tempo, anche lui si recò ad
Haarlem e studiò arte con “Esaias van de Velde”. A 35 anni, fondò una sua
bottega all'Aia. I suoi paesaggi raramente raggiungevano prezzi elevati, ma van
Goyen compensava il prezzo modesto dei singoli dipinti aumentandone la loro
produzione, dipingendo in modo sottile e rapido con una tavolozza limitata a
pigmenti più economici. Fig 1
In base alle categorie dell’arte olandese del seicento
Jan van Goyen sarebbe classificato principalmente come un paesaggista, ma con
un occhio anche per i soggetti di genere della vita quotidiana. (fig. 4)
Durante i primi anni Cinquanta, Ruisdael si recò in
Vestfalia vicino al confine olandese-tedesco con “Nicolaes Pietersz Berchem”
(1620–1683), che Houbraken identifica come grande amico di Ruisdael. Tra i siti
che visitarono c'era il castello di Bentheim, che appare nelle opere di
entrambi gli artisti di questo periodo. (fig 11)
Un vero pioniere della “pittura marittima”
olandese fu “Hendrick Vroom” (1562
circa – 1640) considerato se non il fondatore di questo genere in
Olanda, almeno colui che lo ha innovato, allontanandosi dal punto di vista
"a volo d'uccello" della precedente arte marittima olandese e mostrando
nelle sue opere una percezione più ribassata e una rappresentazione più
realistica degli stessi mari.
Vroom era haarlemmer e gran parte di ciò che si sa della sua vita deriva dalla
biografia che il pittore e storico dell’Arte “Karel van Mander” gli dedicò nel suo "Schilder-boeck" e che sembra un affascinante racconto
d'avventura.
Subito dopo il suo ritorno ad Haarlem
ricevette due importanti commissioni per i disegni degli arazzi che furono
poi eseguiti a Bruxelles nel 1592–95.
Dopo la morte di van Mander, Vroom ottenne le sue più importanti commissioni: battaglie grandi e decorative, scene cerimoniali e viste sulla spiaggia introdussero nuovi meccanismi compositivi che furono adottati dai più giovani pittori di marine olandesi.
Haarlem ebbe una folta pattuglia di pittori marini ed Hendrick Cornelisz Vroom fece scuola: Hans Goderis, Cornelis Verbeeck e Cornelis Claesz van Wieringen furono tutti più o meno direttamente influenzati da Hendrick Cornelisz Vroom che, una volta diventato membro della “Gilda di San Luca” di Haarlem, ebbe tra i suoi allievi Aert Anthonisz, Nicolaes de Kemp, Jan Porcellis e gli stessi suoi figli Cornelis Hendriksz Vroom e Frederik Hendricksz Vroom. (Fig 1)
Hans Goderis (1595/1600 – 1656/59) e
Cornelis Verbeeck (1585/91 – dopo il 1637) sono menzionati per la prima
volta nel libro “Harlemias” di “Theodorus Schrevelius” in quanto
dediti alla pittura marina.
Goderis dipinse principalmente opere marine e
secondo l’Istituto Storico dell’Arte olandese, fu allievo di Jan Porcellis. (fig 2)
Anche Verbeeck dipinse principalmente opere
marine e fu direttamente influenzato da Vroom. Alcune delle sue opere
sono esposte alla National Gallery of Art di Washington. (fig 3)
Secondo l’Istituto Storico dell’Arte olandese
era conosciuto come “Smit” per la sua somiglianza caratteriale con un
fabbro noto per le sue diverse risse.
Cornelis Claesz van Wieringen (1576
circa – 1633) (fig 4) nacque e morì ad Haarlem. Era il figlio di
un capitano di navi di Haarlem e disegnò, dipinse e incise con i suoi
amici Hendrick Goltzius e Cornelis van Haarlem. Ricoprì
anche importanti incarichi nella Gilda di San Luca di Haarlem di cui
divenne membro nel 1597.
Si specializzò in dipinti raffiguranti navi e
battaglie navali e ricevette commissioni dai consigli municipali di Haarlem
e di Amsterdam.
Van Wieringen dipinse l'immagine più popolare
della leggenda di Haarlem, mostrando come una nave di Haarlem spezzò il “boma”,
la catena protettiva del porto egiziano della città di Damietta,
ottenendo così un'importante vittoria sull'Islam.
L’episodio sarebbe avvenuto durante
la Quinta Crociata nel 1218/19.
La storia racconta che i cavalieri di Haarlem
e gli innovativi costruttori navali svolsero un ruolo importante nella caduta
di Damietta. L'accesso alla città attraverso il Nilo era chiuso da
una grande e pesante catena portuale, ma una nave Haarlem, dotata di una
sega di ferro fissata lungo la prua e lungo la parte anteriore della chiglia,
segò la catena del porto di Damietta e permise alla flotta di attaccare con
successo. Si tratta di un racconto leggendario, ma ogni sera tra le nove e le
nove e mezza due campane della Chiesa di San Bavone di Haarlem suonano,
per commemorare la conquista della città egiziana durante il suo l'assedio.
Il dipinto di van Wieringen riscosse un
successo tale che fu richiesta la sua riproduzione in forma di arazzo ed
entrambe le opere si trovano nel “Museo Frans Hals” di Haarlem.
Aert Anthoniszoon, noto anche
come Aart o Aert van Antum (1579\80 - 1620) era
di Anversa (fig 5)
I suoi genitori si trasferirono
ad Amsterdam nel 1591 e forse Aert fu allievo di Vroom.
Di lui si sa poco e niente perché la sua vita
e la sua opera furono trascurate o omesse dai biografi dei pittori dell'inizio
del Seicento e del Settecento come nel caso Arnold Houbraken, di solito
sempre prodigo di informazioni.
Anche di “Nicolaes de Kemp” (1574 –
1647) si sa molto poco: era di Haarlem, fu anche lui allievo di Hendrik
Cornelisz Vroom ed era noto per i suoi quadri marini. (fig 6)
Cornelis Hendriksz Vroom (1591 - 1661) era figlio del pittore Hendrick Cornelisz Vroom, fratello maggiore di Frederick e di Jacob, e padre del pittore Jacob Cornelisz Vroom. Diventò membro della Gilda di San Luca di Haarlem dal 1634.
Come suo padre, Vroom è meglio conosciuto per i suoi paesaggi e paesaggi marini ed esercitò molta influenza sul collega paesaggista di Haarlem Jacob van Ruisdael.
Fu un ben noto paesaggista di Haarlem insieme a "Joh. Jakobsz.", che soggiornò in Italia per molti anni, "Nicol. Zuyker", Gerrit Claesz Bleker, Salomon van Ruysdael (fig 7), e Reyer van Blommendael (fig 8).
* * *
Jan Porcellis
(1580/84 – 1632) era nativo di Gand, quindi
era un fiammingo, trapiantato nel nord dei Paesi Bassi. Era figlio del capitano
di nave Jan Pourchelles che portò la sua famiglia a Rotterdam, in fuga dalle
persecuzioni spagnole. Il fatto che sia stato figlio di un marittimo ci dice
molto sulla sua dimestichezza col mare e con le navi.
La sua data di nascita
è sconosciuta, ma deve certamente precedere il 1584, poiché fu in quell'anno che
i suoi genitori si unirono ai protestanti in fuga da Gand, quando la città fu
presa per la seconda volta dagli Spagnoli durante la “Guerra degli ottant’anni”.
A Rotterdam il
giovane artista è documentato per la prima volta solo nel 1605 in occasione del
suo matrimonio.
Secondo Arnold
Houbraken, il biografo degli artisti, Jan Porcellis si formò ad Haarlem con
Hendrick Cornelisz Vroom, ma questo non è stato mai dimostrato, sebbene le sue
prime opere ne ricalchino lo stile.
Quasi certamente Porcellis
iniziò la sua carriera come grafico, probabilmente lavorando per l'incisore ed
editore di Rotterdam Jan van Doetechum,
specializzato in produzione di mappe, di libri illustrati e di raffigurazioni
di navi.
A Rotterdam ebbe
tre figli, tuttavia Porcellis ebbe anche gravi difficoltà finanziarie e nel 1615
subì l’onta del fallimento e dichiarò bancarotta.
Si trasferì allora
ad Anversa, dove per la prima volta è menzionato come pittore. La maggior parte
dei dipinti realizzati in questo periodo era seriale e la sua produzione era venduta
in mercati all’aperto e, siccome non erano firmati, la maggior parte di essi è
considerata oggi perduta. È tuttavia possibile identificarne solo una
decina degli anni dal 1615 al 1620 sicuramente attribuibili a lui, la maggior
parte dei quali raffigurano battaglie, tempeste e vedute di porti.
Nel 1617 era stato
anche accolto come maestro indipendente nella Gilda di San Luca di Anversa, ma i suoi problemi finanziari
continuarono a sussistere finché non decise di stabilirsi ad Haarlem, vedovo
e con tre figli, nel 1622 e fu allora che la sua la sua carriera finalmente
decollò.
Nel 1622 Porcellis ad Haarlem, continuò sempre nel solco della pittura marittima,
ma l'ambientazione dei quadri di questo periodo non era mai precisata e
lasciata sempre in un contesto ambiguo, diversamente dal stile abituale dei
pittori marittimi contemporanei, come Jan
Brueghel il Vecchio o Hendrick Cornelisz Vroom, che tradizionalmente ritraevano i porti ben
distinguibili o vedute ben riconoscibili del fiume Spaarne ad Haarlem.
Qui vediamo una Veduta del porto di Napoli durante una
battaglia navale di Brueghel e la “Veduta
di Horn” di Vroom. 1 e 2.
Ma perché Porcellis è così diverso e si allontana da cotanto affermati maestri?
Il suo stile è molto evidentemente innovativo
già ad Haalem: l'enfasi che gli altri pittori esprimono sulle navi, Porcellis
la esprime sull'atmosfera e sull'acqua. A differenza dei suoi predecessori
che hanno optato per paesaggi marini colorati e pieni di dettagli aneddotici,
Porcellis ha introdotto la coesione nei suoi dipinti e ha reso visibili le
condizioni meteorologiche con le sue nuvole e gli effetti di luce drammatici, riuscendo
a rappresentare le forze della natura in sottili sfumature di marrone e grigio.
I due anni di
Porcellis ad Haarlem videro probabilmente l'inizio dell’ascesa della sua
reputazione e della sua prosperità economica: ottenne maggiore popolarità
grazie ai dettagli atmosferici nei suoi dipinti, in particolare nel ritrarre la Veduta sulla spiaggia di Haarlem, sopra raffigurata, e molti dei suoi quadri sono
stati trovati in vari luoghi e palazzi europei, come “Palazzo Venezia” a
Roma, o nella collezione dell’Imperatore di Germania, a segno della sua fama in
termini di quantità e di qualità di acquirenti.
In questi anni ad
Haarlem fu anche pubblicata da Jan Pietersz una prestigiosa serie di venti delle
sue incisioni.
Nel 1624 Porcellis
lasciò Haarlem e andò a vivere ad Amsterdam e nel 1626 si stabilì a Voorburg
vicino a L'Aia.
Tra il 1627 e il
1629 si trasferì più o meno permanentemente nel villaggio di Zoeterwoude, nei
dintorni di Leida, dove visse i suoi ultimi anni in prosperità e dove
morì ricco e famoso, possedendo grandi proprietà.
Alcuni suoi capolavori
spiegano il motivo per cui Porcellis, già ai suoi tempi era considerato come il
primo vero grande pittore marittimo. Prima di lui la pittura marittima era ancora
ingenua,
aneddotica, colorata, semplice e decorativa. Nelle sue
opere invece il genere maturò rapidamente evolvendo in una forma d'arte
indipendente che poteva già competere con altri campi ben consolidati della
pittura.
Porcellis raggiunse
un livello senza precedenti di verosimiglianza nella resa atmosferica e sicuramente
fu questa qualità che permise a Constantijn Huygens, perspicace esperto d’Arte dell’epoca,
di osservare che Porcellis era molto più avanti di Hendrick Vroom, considerato il
pittore marittimo più rispettato della vecchia generazione.
Porcellis era stimatissimo
anche da molti artisti di spicco del suo tempo che collezionarono avidamente le
sue opere: Rubens ne possedeva una, Rembrandt sei, Allart van Everdingen tredici e Jan van de Cappelle, artista marittimo e celebre collezionista nonché
intenditore d’arte, ne possedeva non meno di sedici e tutti loro lo ritenevano
un pittore straordinario.
Joachim
Oudaan (1628 – 1692), eminente poeta, drammaturgo e
antiquario olandese, ne cantò le
capacità descrittive onorandolo con una poesia. Voglio citarne alcuni versi perché
è bella e mi è costato molto tempo di ricerca e di traduzione.
“Il vento si alza più in alto,
la vela con esso si gonfia più arrotondata.
Attento alla scotta, timoniere,
che ti vanti di averne sottomessi molti di venti.
Chi, con il cuore pieno di orgoglio,
si vergogna di aver preso uno scoglio
quando siamo stati in difficoltà?
Qui le onde sono agitate,
il marinaio e il comandante faticano così tanto
al timone e in coperta
per spezzare le onde che si infrangono sulla prua
se si riesce.
La giacca da marinaio del timoniere è sommersa,
mentre un flutto che batte sull’asta
balza indietro e cade in mille goccioline rotonde,
e rende i capelli del marinaio
come le teste dei cani nell’acqua.
Una nuvola viene dall'alto, che,
spinta avanti e indietro da travi di vento,
inizia all'improvviso a scaricare;
schizza a bordo e perfora tanto più gravemente
il berretto blu da marinaio,
attraverso stivali e giacche antipioggia
un ammollo per la pelle.
A cui non presta più attenzione,
Ma geme mentre il vento ruggisce
tanto che rimbomba
il timone è costretto sottovento,
la nave è su una costa bassa,
Spingi, marinaio, usa la tua forza.
Eppure un tipo simpatico di solito si siede
sul ponte principale e guarda il gioco
anche se il vento lo sferza e gli acquazzoni lo percuotono.
Anche Porcellis si insinua nel castello di prua,
ma considera la tempesta con calma,
nonostante acqua, pioggia, grandine e tuoni,
per esaminare dal vero questo elemento furioso,
e che egli incide nei suoi pensieri.
Samuel van Hoogstraten, il meticoloso pittore della realtà della seconda
metà del Seicento, tanto meticoloso da essere considerato oggi un anticipatore dell’iperrealismo,
definì Porcellis nel 1678 "il grande
Raffaello della pittura marina".
È sintomatico
della sua fama nascente che nel 1628, quando Porcellis viveva già a Voorburg, Samuel Ampzing, lo storico aedo della
città di Haarlem, lo incluse nel suo “Beschrijvinge
ende lof der stad Haerlem”, rivendicandolo come artista di Haarlem.
Il contributo che
ha dato Porcellis alla pittura marina è davvero formidabile. A guardare la sua
vita e il suo tardo successo sembra che a lui si addica il motto “per aspera ad astra”.
Al di là del pur
autorevole giudizio di Huygens, le sue opere hanno avviato il passaggio decisivo
dal primo realismo alla fase tonale, promuovendo un nuovo stile nella pittura
marina, uno stile concentrato su cieli nuvolosi e su acque agitate, una rottura
radicale dalla precedente attenzione dell'arte marittima dedita per lo più alla
narrazione della grandiosità delle navi incontesti reali.
Si osservi questo
capolavoro. 4
In questa scena
della tempesta c’è il potente senso del dramma, la travolgente illusione dello
spazio, l'espressività, il trattamento della luce e dell'oscurità che irrobustiscono
il genere come mai prima d’allora.
Pochi artisti
furono in grado di instillare un realismo così avvincente nel soggetto
tradizionale delle navi in pericolo su un mare agitato.
Numerosi pittori
di marine più anziani di lui avevano già trattato questo tema come una metafora:
fallimenti umani, orgoglio eccessivo, amori infelici, affari di stato avversi. Ma
Porcellis fu il primo a rendere così palpabile lo spettacolo.
Colpisce di questo
dipinto la relativa facilità e la gestione tecnica, affermate da pennellate
vivaci e dallo fondo che luccica in particolare nell'acqua e nel cielo, con cui
Porcellis ha evocato una tempesta così complessa e così pienamente convincente.
Questa notevole caratteristica
richiama alla mente un aneddoto che Hoogstraten racconta a proposito di una
gara tra Francois Knibbergen,
pittore di paesaggi uniformi, Jan van
Goyen e Porcellis.
Ognuno di loro
doveva eseguire un dipinto in un solo giorno. Knibbergen iniziò
a dipingere, dettaglio per dettaglio, e ogni dettaglio sembrava completato
subito. Van Goyen iniziò in un modo completamente diverso, il suo naturalmente:
prima coprì la sua tela con aree scure e più chiare e poi completò il dipinto
senza sforzo, aggiungendo una grande varietà di motivi paesaggistici.
Porcellis, invece, sembrava perdere tempo prima di cominciare effettivamente a
dipingere, ma di fatto stava componendo il quadro nella sua mente. Esattamente
come dice il poeta Joachim Oudaan.
Porcellis completò
il dipinto prima della fine della giornata e Hoogstraten racconta che il suo
lavoro era superiore per la sua disinvolta naturalezza e per
qualcosa di straordinario che non si era mai visto nei quadri che non erano
nati dalla sua mano.
In effetti, anche
questo dipinto dovette essere stato attentamente studiato prima. In primo
luogo, l'oscuro baldacchino di nuvole torreggianti, così efficacemente in
contrasto con i raggi della luce solare che provengono da sinistra, impone allo
spettatore l’allerta. Solo allora l’autore comincia a guidare lo sguardo
dell’osservatore verso l'azione sull'acqua.
La scena è piena
di dettagli attentamente osservati e ognuno ha uno scopo preciso nel raccontare
una storia: i gabbiani che volteggiano come avvoltoi intorno alle navi
aumentano il livello tensione drammatica, ma indicano anche il cambiamento
della direzione delle raffiche di vento e migliorano l'illusione di profondità.
L’imbarcazione alla deriva evoca poeticamente i disagi che le navi hanno dovuto
già sopportare. Il
barile nell’acqua.
Senza dubbio
quest’opera risale all’ultimo periodo dell'artista, quando Porcellis aveva
raggiunto il massimo delle sue possibilità espressive.
Il suo realismo è così
avanzato che, pur mantenendo il colore dell’acqua verde scuro, esso alla fine
tende a scomparire lasciando il posto a una narrazione monocromatica e
pienamente convincente del mare agitato di una burrasca.
Questo raro e
tardo capolavoro di Porcellis è un culmine della pittura marina olandese del
Seicento e uno dei più netti avvicinamenti dal pittoresco al sublime.
Questo stile che nutre
l'arte marittima, con la maggior parte della tela che mostra mare e cielo, pose
le basi per le opere successive di questo genere.
Il suo stile
diventò ben presto riconoscibile grazie all'uso di mille tonalità di luce
diverse, esemplificate in dipinti come questa Tempesta in mare, che
comprende effetti di luce inediti.
L’itinerario
artistico di Jan Porcellis si è sviluppato nel solco della pittura
marittima olandese. Henrick Vroom, che secondo Houbraken era stato il
maestro di Porcellis, era stato sicuramente abile nella raffigurazione di navi,
trattando anche lui soggetti come pesci, pescatori e altri barcaioli.
I primi dipinti di
Porcellis risalgono al 1612 dimostrano che padroneggiava già bene lo stile di
Vroom, un maestro che all'epoca godeva di molta popolarità.
Degna di nota di
questo primo periodo è anche l'interpretazione di una Battaglia navale di notte che
presenta una battaglia navale in notturno, con navi nemiche appena visibili e
un graduale riconoscimento dei soggetti.
Una battaglia navale notturna fino a quel momento era la prima nell'arte olandese. 5
Jan Porcellis sa rappresentare le forze della
natura in toni presumibilmente marroni e grigi, dal bianco argento al buio
minaccioso. In questo dipinto si può quasi sentire l'atmosfera del mare in
tempesta, con le onde alte e un cielo tempestoso.
Queste due opere fanno parte di una serie di
tre dipinti di mare, che illustrano una tempesta. Il loro formato suggerisce
che originariamente fossero state realizzate come soprapporte. Le due opere
superstiti della serie sono le prime, le più antiche sopravvissute fra le opere
di Porcellis: devono essere state dipinte forse prima del 1612. Lo mostrano le
opere realizzate nel preciso stile aneddotico tipico dell'illustrazione di
navi, che aveva appreso da Hendrick Cornelis Vroom. La luna fa capolino in un
cielo nuvoloso; numerosi vascelli illuminati dalle loro lanterne in primo
piano; quello al centro con banderuola giallo-blu-giallo all'albero di
trinchetto; ai lati, pescherecci che calano in mare le reti.
Altri pittori di marine seguirono l'esempio e
negli anni Venti del Seicento anche i pittori di paesaggi e di nature morte
iniziarono anch’essi a realizzare dipinti monocromi.
Nonostante tutti i
pericoli che ritrae, Porcellis non pone mai troppa enfasi sulla distruzione
spettacolare lo dimostra il fatto che non è mai rappresentato direttamente nessun
grande relitto di navi.
L’osservatore è
piuttosto invitato a capire che cosa succede gradualmente, ma si ferma sempre
un attimo prima della tragedia. Le sue navi hanno una solida presenza
nell'acqua e l'atmosfera grigia e nebbiosa contrasta e offusca l'orizzonte e le
navi in lontananza. La screziatura del cielo è proiettata
dal sole sulla terra bruna che diventa verde alla luce.
Questi effetti non
erano stati furono mai tentati da Vroom o dai suoi contemporanei, e davvero in
Porcellis sono molto avanzati per la sua epoca. Questi esperimenti sarebbero
sempre portati avanti nella preoccupazione per tutta la sua vita per le
sottigliezze atmosferiche.
È noto che all'epoca
di Porcellis la nave era considerata una metafora e il viaggio per mare era un
simbolo della vita, per questo i temi marini come la tempesta in mare o il
naufragio ricordano allo spettatore la fragilità umana e il potere
divino. Ma non so se ai dipinti di Porcellis si possa attribuire un
messaggio morale.
Nove opere su
dieci di Porcellis prima del 1620 ritraggono navi della flotta olandese, che
rappresentano battaglie, tempeste o vedute del porto argomenti familiari anche
ai primi pittori di mare, ma la prima opera datata del 1620 segna un
cambiamento nel suo stile.
Il dipinto ritrae
piccole navi da trasporto che navigano in una fresca brezza. 7.
Questo è stato il
primo dipinto olandese ad essere ambientato in un paesaggio marino non
identificabile con i famosi porti. La magistrale disposizione e
stilizzazione degli elementi formali indicano che Porcellis aveva raggiunto la
maturità della sua opera nel momento in cui questa tavola fu dipinta.
Il periodo di
Haarlem di Jan Porcellis, 1622-1624, fu l'inizio del suo periodo prospero in
cui produsse dipinti nello stile delle vedute della spiaggia, una specialità
locale. Questo periodo lo vede anche produrre opere di cielo quasi
monocromatiche, caratterizzate da efficaci manipolazioni di luci e ombre.
I cieli di
Porcellis sono stati rivoluzionari sotto molti aspetti come l'ambientazione, i
sottili cambiamenti nel paesaggio e gli stati d'animo mutevoli come i cieli
nordici. La maggior parte delle sue opere mature ritraggono il mare come
ospitale, anche se scomodo o pericoloso.
Il contributo di
Porcellis all'arte olandese risiede anche nella sua enfasi sugli effetti
drammatici della luce, pur avendo una composizione generalmente contenuta.
Jan Porcellis ha elaborato
un modo originale di pittura marina incentrato sugli effetti tonali,
promuovendo atmosfere vivide e paesaggi marini in modo monocromatico. Come
si vede in questo dipinto Navi in una tempesta vicino a una costa rocciosa.
8.
Questi elementi
stilistici furono poi visti tra i suoi contemporanei come Jan van
Goyen, Pieter de Molijn e Salomon van Ruysdael che, il più delle
volte, seguivano Porcellis nelle sue raffigurazioni di navi anonime circondate
da vaste distese di mare e cielo.
Piuttosto che
essere commissionati, questi dipinti erano solitamente realizzati per la
vendita sul mercato aperto, il che può riflettersi nella fluidità degli
elementi stilistici non tradizionalmente caratteristici della pittura marina.
I suoi seguaci
includevano suo figlio Julius, così come il fratello di sua moglie, “Henrick van Anthonissen” e “Simon de Vlieger”.
Le
sue opere più famose sono esposte in importanti musei di tutto il mondo non
solo nei Paesi Bassi, ma anche in Russia, Germania, Regno Unito, Francia e Nord
America.






















.png)







_-_A_Sea_Battle_by_Night_-_RCIN_402744_-_Royal_Collection.jpg)
_-_A_Storm_at_Sea_-_RCIN_402633_-_Royal_Collection.jpg)