Dopo le vacanze natalizie, desidero aprire
questa racconto di oggi andando in un luogo speciale, la “Bibliothèque
Nationale de France”, uno di quei posti magici per gli studiosi, di quella stessa
magia che un luna park sprigiona su un bambino.
Una biblioteca con cui ebbi a che fare tanti
anni fa, all’inizio della mia carriera di studioso a causa di un codicetto in
marocchino rosso che Carlo VIII, ai tempi della sua garbatissima visita a
Napoli a conclusione del suo tour in Italia, aveva fatto portare a Parigi
insieme a quasi tutta la celebre “Biblioteca aragonese” per arricchire la
collezione reale francese. Ma da Napoli, quasi come per una nemesi storica, si
portò anche qualche altro “souvenir”, ma molto meno dotto.
Il primo nucleo di questa eccezionale
biblioteca, parlo di quella francese, fu costituito da Carlo V – al tempo degli
eventi che stanno guidando questo mio viaggio –, ed ebbe sede in alcuni locali
della “Torre della falconeria” del “Palazzo del Louvre” che il sovrano aveva
fatto ristrutturare trasformando la fortezza e dandole l’aspetto di palazzo di
residenza. Quella torre conteneva un migliaio di manoscritti, forse anche un
po’ meno, ed erano il nocciolo originario di una collezione che si sarebbe
arricchita nel corso dei secoli fino a raggiungere oggi i quaranta milioni di
opere e parlo solo di volumi. Per avere una misura della grandezza di questa
collezione si pensi che una grande biblioteca italiana, la Nazionale di Napoli
che è quella che meglio conosco, ne contiene appena due milioni e la più grande
in assoluto in Italia, la Biblioteca Centrale di Roma di volumi ne possiede
solo sette milioni.
Perché sono voluto partire dalla
“Bibliothèque Nationale de France” per raccontare la storia della miniatura
francese? La ragione è che in questa prestigiosa istituzione francese si
conservano molti codici di Filippo l’Ardito e dei suoi fratelli, Carlo V e il
duca di Berry, opere naturalmente dei più grandi miniaturisti di cui quei
signori furono splendidi mecenati.
Le opere più importanti sono “Les Petites
Heures” di Jean de Berry, commissionato a “Jean Le Noir” e completato da “Jacquemart
de Hesdin” tra il 1372 e il 1390 e appartiene alla “Bibliothèque Nationale de
France”.
“Les Très Belles Heures de Notre-Dame”, realizzate
sempre per Jean di Berry tra il 1389 e il 1404, in particolare dai “fratelli di
Limburgo” e poi dalla “bottega dei fratelli Van Eyck”, un codice molto presto smembrato,
per cui il “Libro delle ore” è conservato presso la “Bibliothèque Nationale de
France”, il “Messale” è conservato al “Museo Civico dell’Arte” di Torino,
e un libro di preghiere, ora distrutto di cui restano solo quattro fogli che attualmente
si trovano al “Museo del Louvre” e un foglio al “Getty Center”.
Ancora “Le bellissime ore del duca di Berry”, completata nel 1402 da
“Jacquemart de Hesdin” si trova “Bibliothèque Royal du Belgique”, a Bruxelles.
“Le grandi ore del duca di Berry”, prodotto tra il 1407 e il 1409, da “Jacquemart
de Hesdin” alla “Bibliothèque Nationale de France” e al “Louvre”. “Les Belles
Heures du Duc” de Berry dei fratelli Limbourg al “Metropolitan Museum of Art”
di New York. Infine, le “Très Riches Heures du Duc de Berry”, le più famose,
commissionate ancora una volta ai fratelli di Limburgo, ma alla loro morte e a quella
del loro committente nel 1416 il manoscritto rimase incompiuto e così com’è oggi
è conservato al “Museo Condé” di Chantilly.
Ma chi furono i miniaturisti che hanno
lavorato per questi prestigiosi collezionisti? “Jean le Noir”, quel tipaccio di
“Jacquemart de Hesdin”, i “fratelli di Limburgo”, la bottega dei “fratelli Van
Eyck”. E già da questa piccola rassegna potremmo farci un’idea. Ma per
comprendere più a fondo la loro importanza e quella del loro mecenate
spendaccione penso che sia necessario prima accennare brevemente alla
situazione della miniatura gotica in Francia, sperando di riuscire ad essere
nello stesso tempo essenziale e soddisfacente, due qualità che quasi mai si
riescono a coniugare.
Dunque siamo a Parigi, nella sede della
prestigiosissima “Bibliothèque Nationale de France” e quindi attingiamo ai più
importanti esemplari che appartennero alla collezione reale privata di Carlo V
perché attraverso questa scelta mi è possibile riuscire a tracciare una storia minima
della miniatura gotica francese (fig 1).
Ma partiamo dall’inizio della sua collezione privata, ottimo campionario della Storia della miniatura francese.
Nella pittura francese, di solito, si fa incominciare la miniatura gotica con i manoscritti degli inizi del Duecento. Quindi parecchio più tardi rispetto all’architettura e alla scultura gotiche, risalenti in pratica a più di mezzo secolo prima, con la costruzione del coro della chiesa abaziale di Saint-Denis da parte dell’abate Sigieri.
In Francia, come sappiamo, mancava la cultura della pittura a fresco e di quella su tavola, mentre si era fatto largo l’uso della pittura su vetro e in vetro: la funzione di “Bibbia” dei poveri e degli analfabeti in Francia, svolta altrove dalla pittura su tavola e a fresco, era affidata qui alle vetrate, che oltre a svolgere una funzione educativa, introducevano una luce fantasmagorica nelle cattedrali di Francia i cui cieli già nordici erano spesso grigi, diversamente da quelli luminosi del Mezzogiorno.
Entrare in una cattedrale gotica non era e non è solo una visita in chiesa, ma un’esperienza spirituale e intellettuale profonda e incisiva: gli archi ogivali, così tesi verso l’alto, innalzano l’animo dalla terra al cielo. Lo sguardo vaga verso l’alto e gli snelli pilastri polistili lo conducono a un’ascesa vertiginosa verso quelle volte, soffuse della luminosità delle vetrate policrome che proiettano fra le navate straordinari effetti di luce e di colori: dal blu profondo al rosa opaco, dal verde al giallo. Luci iridescenti che simulano un’epifania del divino.
Secondo Sigieri quelle vetrate assolvevano
meglio al compito di onorare la divinità se rifulgevano di luce, che penetrando
attraverso di esse si riflettesse sui metalli preziosi e sulle gemme poste
nelle sfarzose decorazioni delle suppellettili. Per Sigieri, che era pure mezzo
neoplatonico, Dio è Luce, pertanto le nuove cattedrali devono essere costruite
in modo da poter ospitare la luce divina.
Il mistero e la bellezza di queste vetrate,
capaci di conservare la luce anche di notte, eseguite con una misteriosa
tecnica di lavorazione del vetro ci è tuttora del tutto ignota come insondabile
è il mistero che esse rappresentano.
Purtroppo maggior parte di esse non è
originale perché fino al secolo scorso la Francia ha subito danni di guerra,
un’attività per la quale non si è mai risparmiata nel corso della Storia per
affermare o mantenere la sua “grandeur”. Ma si sa, erano altri tempi e poi il
vetro di per sé è un materiale delicato.
Per conoscere quindi la pittura gotica
francese con qualcosa di simile a un pennello, ma su supporti più piccoli,
dobbiamo rivolgere la nostra attenzione a un’altra arte “applicata”: la
miniatura. È stata infatti la decorazione dei manoscritti a fornirci la rassegna
più completa della pittura gotica francese, attraverso lo sviluppo di un gran
numero di espressioni artistiche in luoghi, le biblioteche, dove nessun lavoro
monumentale sarebbe altrimenti riuscito a sopravvivere.
Nel settore miniaturistico, il Gotico fu il
momento in cui si realizzò il progressivo distacco dalla sacralità espressiva
del Romanico per rivolgersi a un’Arte che faceva un più̀ largo uso di “valori”
a dimensione “umana” piuttosto che a quella “divina” e dell’espressione dei
sentimenti che, sul piano stilistico, si tradusse nell’ammorbidimento e nello
snellimento della linea, in opposizione alla ieraticità e al formalismo
plastico e ancora “primitivo” degli artisti romanici.
All’origine di questa trasformazione ci
furono profondi cambiamenti culturali come l’evoluzione del pensiero della
filosofia “scolastica” nell’ambito della Sorbona con le importanti voci
di Sant’Alberto Magno e di San Tommaso d'Aquino ma, più
materialmente, anche con trasformazioni sociali ed economiche, queste ultime
riguardanti la vita quotidiana e l’organizzazione stessa del lavoro.
Il sistema di produzione del libro era
infatti profondamente cambiato e si basava ora sulla parcellizzazione dei
compiti che permetteva una maggiore produzione che prima invece, negli “scriptoria”
monastici, erano invece compiuti unitariamente e a ogni codice lavorava un solo
miniaturista, ovviamente dopo che il copista aveva svolto il suo compito.
Ora il libro, come in genere la cultura, era
uscito dal monopolio di produzione del monastero ed era entrato nel circuito
produttivo cittadino.
Dal Duecento Parigi era diventata la capitale
dell’editoria europea, ma non solo: nel resto dell’Europa cristiana, gli altri
centri di produzione si erano costituiti sul suo modello.
A Parigi poi la miniatura non si limitava più
solo alla clientela dei professori della Sorbona e degli studiosi: i
miniaturisti cominciavano a dover soddisfare anche i bisogni della corte reale,
delle maggiori corti feudali e della borghesia, sempre più poderosamente emergente
e competitiva, con libri di devozione, ma anche con testi profani.
Per queste due categorie sociali,
aristocrazia e ricca borghesia, si sviluppò una produzione di lusso.
La Francia e l’Inghilterra per i loro
formidabili contatti, prima che cominciassero a litigare, giocarono un ruolo
guida nell’evoluzione stilistica della miniatura del Duecento e la Francia
attinse a larga mano ai continui scambi con l’Inghilterra che, dal 1066, era
normanna, quindi per tre secoli molto francese.
Tra i manoscritti menzionati negli inventari di
Carlo V redatti "post mortem" compare l’opera più̀ antica in cui il Gotico si
evidenzia nella miniatura francese.
Si tratta del “Salterio di Ingeburge”
realizzato non dopo il 1236 e oggi conservato al “Museo
Condé” di Chantilly.
Questo manoscritto è importante per la
novità̀ del suo stile e perché́ è la più̀ antica testimonianza dell’alba del
Gotico, in epoca ancora miniaturisticamente dominata dal Romanico, e
soprattutto il segno dell’alba di un’arte di corte di una certa qualità̀.
Sono state proposte diverse date per la
produzione del manoscritto, ma nessuna più convincente di un’altra: di certo si
sa che alla morte della regina nel 1236, il manoscritto rimase probabilmente
nelle collezioni reali infatti è menzionato nel 1380 nell'inventario dei beni
di Carlo V.
Il manoscritto è composto da 197
fogli, di cui i primi 27 comprendono 51 miniature, fu realizzato quasi
sicuramente per Ingeburge di Danimarca, la sfortunata regina consorte di
Filippo II Augusto.
Di queste miniature ventisette sono su fondo
oro, di queste quattro sono a piena pagina, ventidue a due scomparti e una a
tre scomparti e ognuna è accompagnata da una didascalia in francese in lettere
d'oro.
I fogli raffigurano scene dell'Antico
Testamento. Il quattordicesimo foglio raffigura l'”Albero di Jesse”, altri
fogli raffigurano scene del Nuovo Testamento. Un paio di fogli rappresentano
scene della vita di San Teofilo.
Nelle miniature del libro si distinguono
generalmente due miniaturisti: un artista di stile più antico e un altro di
stile più moderno, la cui mano si ritrova particolarmente nella miniatura della
“Pentecoste” in cui è già ravvisabile un disegno più̀ flessuoso, meno teso, e
soprattutto caratterizzato da una moltiplicazione dei drappeggi con pieghe più̀
serrate.
Quest’ultimo elemento è all’origine dello
“stile pieghettato”, il cosiddetto “Muldenfaltenstil”, una formula stilistica
che godette di ampia fama internazionale, per la sua capacità di risolvere il
panneggio non soltanto graficamente, ma anche plasticamente, perché conferisce
spessore e profondità ai solchi e ai piegoni che i drappi formano, aderendo
enfaticamente ai corpi. L'effetto è quello di una veste bagnata che sottolinea
la ricca corporeità della figura e ne accentua la dignità monumentale e la
bellezza vitale.
Lo stile di questi due maestri è vicino a una
delle più belle e maestose opere di oreficeria medievale, il “Reliquiario
dei Re Magi” della “Cattedrale” di Colonia e a un “Evangeliario”
della “Chiesa di San Martino” sempre a Colonia.
Si potrebbe quindi dedurre che questi due artisti potrebbero essersi formati come orafi a Colonia, quindi dall’area renana, e in seguito sarebbero venuti a lavorare in Francia, in particolare a Soissons o a Noyon, intervenendo in diversi manoscritti in queste città e a Parigi.
Si confrontino ora il più arcaico “Albero di Jesse” con la più moderna “Pentecoste”
La più̀ importante espressione di questo stile dal carattere molto più̀ monumentale, è la “Bibbia del cardinale Maciejowski” all’incirca del 1250 oggi alla “Pierpont Morgan Library” di cui qui sotto vediamo il foglio che illustra “Il quinto giorno della creazione” e “La cacciata degli Israeliti dalla terra di Canaan” (figg 7,8,9)
Questo nuovo stile conquistò ben presto anche i manoscritti liturgici, come testimoniano parecchi evangeliari della “Sainte Chapelle” e fu usato nel terzo quarto del Duecento in salteri di lusso, come nel “Salterio di San Luigi”, appartenuto alla collezione di Carlo V e oggi custodito nella “Bibliothèque Nationale de France”. In quest’opera si riscontra un’arte animata da figurine graziose, ma che rasentano talvolta il gesto lezioso e sdolcinato.Il cosiddetto “Salterio di San Luigi” era ad uso della Sainte-Chapelle di Parigi.
Una vecchia menzione nel manoscritto indica che apparteneva a Luigi IX il Santo, anche se oggi, gli storici dell'Arte lo vedono piuttosto come un'opera commissionata per Maria di Brabante, nuora di Luigi IX in occasione del suo matrimonio con Filippo III di Francia.
Il salterio in cui si distinguono da quattro a cinque mani diverse di miniaturisti, contiene tutte le feste che vi si celebravano ma è incompleto: mancano uno o due quaderni all'inizio e le preghiere e le litanie alla fine. Inizia con una serie di settantotto miniature a piena pagina che illustrano scene dei primi libri dell'Antico Testamento, da Caino e Abele all'incoronazione di Saul. Le scene sono tutte accompagnate da un’inquadratura architettonica ispirato alle costruzioni gotiche dell'epoca come vediamo nelle due immagini riportate di sotto che raffigurano “Il sacrificio di Isacco” e “Gedeone conquista Madia”.
Qui sotto vediamo i “Sacrifici di Caino e Abele”, “La distruzione di Sodoma” e “Il sacrificio di Isacco”.
Alla fine del Duecento, il miniaturista “Maître Honoré́”, ai tempi molto celebre, era ancora dipendente da questa corrente stilistica. A lui si possono attribuire alcune delle opere più̀ raffinate della fine del secolo: un breviario miniato probabilmente per il re Filippo IV il Bello e le miniature del “Somme le Roi”, un trattato didattico e moraleggiante commissionato per il sovrano da frate Laurent, suo confessore, di cui qui sotto vediamo alcune pagine: “le quattro virtù cardinali”, e più sotto “La bestia a sette teste dell'Apocalisse” venerata da un ipocrita e che schiaccia un santo.
Le composizioni sottilmente ritmate, il
disegno molto morbido sviluppato in begli arabeschi, non perdono però mai il
contatto con la realtà̀ che il miniaturista descrive.
2.
Jean Pucelle
Dopo il racconto dei manoscritti del Duecento
della collezione privata di Carlo V oggi racconterò che cosa succede nel
Trecento nella miniatura parigina e saremo ancora ospiti nella “Bibliothèque Nationale de France”. “Hic stabimus optime”.
Ma prima di questo voglio raccontare la
situazione generale a Parigi dall’inizio del secolo, quando il nostro bibliofilo
collezionista Carlo non era ancora nato e ci volevano ancora quasi quarant’anni
perché nascesse, il Louvre era ancora una fortezza e la “Torre della
falconeria” non era stata ancora adibita a biblioteca.
Per questo, prima rivolgere
di nuovo attenzione alla sua collezione, è opportuno pensare alla Parigi del
1328.
Il Trecento è di solito considerato uno dei secoli
negativi o meglio un “secolo di crisi”
nella Storia, come il Seicento
e il Novecento. Uno di quei “secoli di transizione” in
cui l’uomo annaspa per trovare nuovi equilibri e in questo forse consiste il loro fascino.
Il Trecento, al di là del collasso delle
grandi istituzioni medievali, si era presentato fin da subito come un momento di
severe congiunture negative per l’Europa che
durarono per vari decenni, con una certa ripresa, ma moderata, e solo a partire
dalla seconda metà del secolo.
Dal Mille al
Duecento si erano verificati tre secoli di grande sviluppo e di prosperità
nel continente europeo, il Trecento fu invece un secolo di
rottura, con una brusca interruzione dei fenomeni di crescita che avevano
caratterizzato i secoli precedenti che avevano visto lo sviluppo
demografico, l'ampliamento di antiche e la creazione di nuove città, lo
straordinario aumento dei traffici in termini di quantità e di qualità.
Questo regresso del
Trecento fu forse causato da un cambiamento climatico, cioè con la fine del
cosiddetto “periodo caldo del Medioevo”
che aveva permesso abbondanti raccolti, agevolati da piogge scarse ma regolari
e da primavere tiepide. Ora invece si tornava a una “piccola glaciazione” con inverni lunghi ed estati brevi. Questo
trend climatico piuttosto ostile fu punteggiato dalla carestia
del 1315\17, che ne fu un effetto, dalla conseguente stagnazione economica,
dalla “Peste nera” del 1348\50 e
dalle sue conseguenze “devozionali”
che si manifestavano in crisi di fede in Dio e in cosa lo rappresentava sulla terra,
dalle frequentissime rivolte contadine e dalla mina vagante delle compagnie di
ventura.
Per la Francia, nei secoli precedenti impegnata
con la dinastia capetingia nel poderoso sforzo di creazione di uno Stato
nazionale, gli eventi furono particolarmente negativi.
Nel 1302, la “battaglia di Courtrai” quella degli "Speroni d'oro" oppose il re Filippo IV il Bello alle truppe
delle città fiamminghe, insorte contro il dominio della Francia e ne erano uscite
vincitrici. Nel 1309 iniziò la Cattività Avignonese. Nel 1314 la morte del
ferreo Filippo IV fu seguita nell’arco di quattordici anni dalla morte di tutti
e tre i suoi figli maschi: Luigi X morì nel 1316, Filippo V nel 1322 e Carlo IV
nel 1328 e tutti senza eredi maschi.
Era stata forse la romanzesca maledizione di “Jacques
de Molay”, il Gran Maestro dell’Ordine dei Templari, che stava colpendo?
Non credo nelle maledizioni, ma sta di fatto che
solo un mese dopo l’atroce morte di de Molay sul rogo, papa Clemente V de Got, che
lo aveva scomunicato per eresia, morì cinquantenne, stroncato da un tumore
all’intestino, e qualche manciata di giorni dopo morì anche Filippo il Bello che
lo aveva condannato a una morte così atroce e che fra l’altro aveva rubato gran
parte del tesoro dei Templari: il re aveva solo quarantasei anni ed era in
ottima salute quando durante una battuta di caccia, fu colpito da un ictus mortale.
Ma la maledizione non si era fermata lì: nella generazione successiva, la
maledizione, che era estesa a tutti i discendenti diretti di Filippo il Bello, continuò
a colpire con l’estinzione diretta della dinastia dei Capetingi e con la
nascita di quella un po’ meno diretta dei Valois. Questi eventi, rafforzarono nell’opinione
pubblica di allora che alle maledizioni credeva l'idea che “Jacques
de Molay” fosse
caduto vittima di un'ingiustizia e che le maledizioni da lui scagliate si
fossero avverate, ovviamente con il consenso di Dio.
A questo si aggiungeva la profanazione della
“sacra” figura di papa Bonifacio
VIII, schiaffeggiato da Sciarra Colonna e arrestato da Guillaume de Nogaret che
erano entrambi emissari di Filippo il Bello. Al di là di maledizioni, vere o
leggendarie che siano, la “legge salica”
rese la successione del regno di Francia molto problematica.
Fra tre contendenti in corsa per il trono di
Parigi prevalse "Filippo VI di Valois", l'erede più vicino in linea maschile al ramo principale dei
Capetingi perché era nipote di re Filippo III, che era suo nonno,
e di Filippo
il Bello che era suo zio paterno, pertanto non era suo discendente
diretto e di conseguenza poteva sentirsi al riparo dalla maledizione. Ma non dai
cavilli che l’antica “legge salica”, risalente
al re merovingio Clodoveo, era capace di suscitare. Un breve passaggio: “de terra vero nulla (salica) in
muliere hereditas non pertinebit, sed ad virilem sexum qui fratres fuerint tota
terra pertineat. E come se il concetto fosse poco chiaro, subito
dopo aggiungeva “In terram salicam mulieres ne succedant”. In altri
termini e in parole povere, nessuna donna poteva succedere al trono. Una brutta
legge, ma si sa “dura lex sed lex”.
Naturalmente fu una successione contestata, perché esistevano
sì figlie di Filippo il Bello non aventi diritto, ma c’erano anche figli di
figlie che rivendicavano con un po’ di forzatura il diritto alla successione,
come nel caso di Edoardo III di Inghilterra, e questo causò fra le numerose
turbolenze anche lo scoppio della “Guerra
dei cent’anni” nel 1337.
Nel 1346 infatti Edoardo III di Inghilterra, uno dei tre pretendenti al
trono, era il figlio della principessa Isabella di Francia, quindi suo nonno
era il re della maledizione: Edoardo invase inconcludentemente la Francia e con
la sua cavalleria saccheggiò rozzamente la campagna piuttosto che tentare di
occupare il territorio. Ad agosto dello stesso anno le forze francesi
guidate da Filippo VI
affrontarono Edoardo III
nella “battaglia di Crécy” che però si concluse con una
sconfitta devastante e umiliante per la Francia. Nonostante la vittoria
però, il meglio che Edoardo III riuscì a rivendicare fu la conquista della
piazzaforte di Calais sulla Manica.
Nel 1350 Giovanni II il Buono succedette al padre Filippo VI sul trono
di Francia e nel 1356, Edoardo detto il “Principe Nero”, primogenito ed
erede al trono di Edoardo III, guidò il suo esercito a cavallo in Francia.
Giovanni II inseguì il principe inglese, che
però cercò di evitare uno scontro diretto con le superiori forze del re di Francia. I
negoziati intrapresi fra i due comandanti in capo però fallirono e si giunse
alla “battaglia di Poitiers” a
settembre del 1356 in cui i francesi subirono un'altra cocente sconfitta: il
loro re, il buon Giovanni II, fu catturato e portato come ostaggio a
Londra. Su quest’episodio tornerò in un prossimo racconto perché esso è
molto importante per la conoscenza del duca Filippo di Borgogna, il
protagonista, anche se per ora assente, di questi miei racconti.
A quel punto con il re prigioniero il
principe Edoardo poteva sperare in una vittoria completa, invadendo la Francia
e facendosi incoronare direttamente a Reims, un luogo sacro per i re di
Francia dove, a partire da Ugo Capeto, erano stati unti e incoronati re di
Francia. Ma il nuovo capo degli eserciti francesi, il principe ereditario
Carlo, reggente al trono di Francia, evitò un'altra battaglia campale e la
città di Reims resistette all'assedio sfibrando l’esercito inglese. Grazie alla
mediazione papale, sempre cappellano del re di Francia, si giunse al “trattato di Brétigny” del 1360, in cui
la corona inglese otteneva un'Aquitania allargata in tutta la sua sovranità, ma
rinunciava al ducato di Touraine, alle contee di Angiò e di Maine, alla
sovranità sulla Bretagna e sulle Fiandre, nonché al suo diritto al trono di
Francia.
La reggenza di Carlo e poi il suo grande
regno furono difficilissimi non solo per la logorante guerra contro gli
inglesi, i cui eserciti misero a dura prova il potere dei Valois e l’unità
stessa del Regno di Francia, ma anche per altre vicende che si verificarono in
seno stesso alla Francia.
Con la prigionia inglese di Giovanni II, il
principe Carlo allora diciottenne si trovò a
dover contrastare non solo le pretese dinastiche inglesi, ma anche le mire
espansionistiche del re di Navarra, l’infido e sleale cugino Carlo II il
Malvagio, solo in teoria suo alleato; il principe Carlo perse inoltre ogni
controllo sulla nobiltà feudale, sempre riottosa contro un potere centrale,
mentre numerose regioni e dipartimenti del paese erano in preda di bande di
mercenari senza padroni, più che altro predoni dediti al saccheggio e a
estorsioni nei confronti dei contadini e dei piccoli fittavoli.
A Parigi Carlo dovette
fronteggiare gli “Stati Generali”
della capitale che, guidati da “Étienne
Marcel”, ricco drappiere e capo di numerose corporazioni, che esercitava
sulla città un ruolo simile a quello di un sindaco. Gli “Stati generali” si erano spinti a reclamare il potere di
autoconvocazione, quello di delibera sulle imposizioni fiscali e infine rivendicavano
il diritto di eleggere propri rappresentanti nel “Consiglio del Re”.
Era un insieme
di pretese che attraverso la “Grande
Ordonnance” del 1357, se accettata, avrebbe posto le basi affinché gli “Stati generali” potessero imporre una sorta
di controllo “parlamentare” sul Re.
Incomprensibile per un sovrano medievale e di
mentalità ancora feudale, ma anche in questo vediamo la Francia sempre un passo
avanti rispetto al resto d’Europa.
A questa turbolenza parigina si aggiunse anche la “Grand Jacquerie”,
una rivolta contadina scoppiata il 28 maggio del
1358, proprio quando il principe Carlo, con una serie di abili manovre
politiche, era riuscito a sconfiggere le folle cittadine in tumulto e a far
incriminare Marcel.
Niente male per un quasi ventenne.
Salito poi al trono nel 1364 dopo la morte
del padre, Carlo V, in sedici anni di regno, riorganizzò le finanze e
l’esercito della Francia, mentre il principe di Galles, aumentando le tasse in
Aquitania, tentava di recuperare le sue perdite economiche in seguito ad una fallimentare
quanto losca faccenda in Castiglia. Questo spinse i sudditi di quella regione
ad appellarsi al re di Francia: la guerra fu di nuovo dichiarata e i
francesi riconquistarono l’uno dopo l'altro i territori aquitani in mano
agli inglesi, lasciando loro solo il possesso di poche fortezze costiere:
Calais, Bordeaux e Bayonne. Il Principe nero morì in Inghilterra forse di tifo
o di colera nel 1376.
Nel 1378, dopo la partenza dei papi da
Avignone, scoppiò lo “Scisma d’Occidente”, un’ennesima grana internazionale
nella quale furono coinvolti tutti gli Stati europei occidentali. In questo Scisma
il re di Francia prese posizione appoggiando il Papa avignonese Clemente VII
dei conti di Ginevra che invece per la fazione opposta era considerato
un “antipapa”.
Quando
Carlo V morì quarantaduenne nel 1380, lasciò una Francia più forte e tranquilla
di come l’aveva trovata, ma lasciò anche un erede, Carlo VI, un ragazzino deboluccio
di appena undici anni sotto la tutela di un consiglio di reggenza fino al suo
ventunesimo anni di età e con questo giovane e sfortunato principe si giunge
all’ultimo decennio del Trecento.
Principe
e poi re dalla vita movimentata, passato alla Storia come il “Saggio”, Carlo V era
un uomo colto e un attento mecenate che seppe legare le arti al potere, come
abbiamo visto nel racconto sulla sua Parigi: da appassionato bibliofilo qual
era, nel corso della sua vita collezionò un incredibile numero di volumi, come abbiamo
visto nelle opere duecentesche della sua collezione e fra questi libri c’è un’opera
di grande interesse: la “Vita di Saint
Denis”, un manoscritto miniato risalente al 1317 conservato
nella “Bibliothèque Nationale de
France”.
Commissionata
agli abati dell'Abbazia Reale di Saint-Denis per farne dono ai re di Francia, l’opera
contiene la vita di uno dei santi più importanti per l’Olimpo dei sovrani di
Francia e uno dei compatroni di Parigi, e miniature che rappresentano scene
della vita quotidiana del Trecento parigino che sono state oggetto di interessanti
studi dell’École des Annales.
L'esecuzione
del manoscritto fu iniziata dagli abati di Saint-Denis durante il quasi
trentennale regno di Filippo il Bello, quindi dal 1285 fino alla sua morte nel 1314. Alcune
note del manoscritto indicano che fu prodotto da “Yves”, un monaco dell'abbazia, e che fu parzialmente tradotto in
francese da un certo Boitbien. L’opera fu completata dopo la morte di
Filippo il Bello nel 1317 e fu presentata dall'abate “Gilles de Pontoise” al re Filippo V il Lungo, secondogenito di
Filippo il Bello. Il manoscritto rimase in possesso dei re di Francia fino
a Carlo VI, lo sfortunato figlio di Carlo V.
L’opera
in tre volumi più un frammento staccato del terzo, presenta la leggendaria vita
del santo patrono di Parigi e dell'abbazia di fondazione merovingia che da lui
prende il nome. Anche questo edificio come la “Cattedrale di Reims” è sacro per i re di Francia che lo
considerarono il loro sacrario. Allo stato attuale il manoscritto contiene settantasette
grandi miniature tutte racchiuse in una cornice architettonica dorata,
probabilmente ispirata a pezzi di oreficeria dell'epoca.
Qui
sotto vediamo “L’abate che dona il libro
a Filippo V”, poi un “Momento della
vita di Saint Denis” e più sotto, un dettaglio della stessa pagina con un “Mulino sotto un ponte di Parigi”. 1, 2,
3.
Ventitré
di queste miniature, rappresentano nella metà inferiore scene della vita
quotidiana a Parigi al momento della produzione del manoscritto in cui sono
raffigurate attività artigianali e commerciali: mercanti, marinai, medici,
panettieri, in omaggio al buon governo dei Capetingi nella loro capitale.
Un altro importante
esemplare della raccolta privata di Carlo V è il “Breviario di Belleville”, un manoscritto
miniato di poco successivo al precedente e risalente agli anni fra il
1323 e il 1326, oggi conservato nella “Bibliothèque
Nationale de France”.
Si tratta di una mano gentile che ne ha
eseguito le miniature, quella di “Jean
Pucelle” (1300 circa –
1355),
che aveva realizzato le miniature di questo manoscritto per il nobile bretone “Olivier IV de Clisson” come dono a sua
moglie “Jeanne de Belleville”, la
coraggiosissima e vendicativa nobildonna, anch’ella bretone, dalla vita
complicata che diventò corsara per vendicare suo marito. Olivier infatti era
stato accusato di alto tradimento e giustiziato a Parigi nel 1343 e tutti i
beni della sua famiglia, compreso il codice, furono confiscati a beneficio del
re di Francia.
Questo manoscritto ad uso domenicano, del
quale qui sotto vediamo una raffinatissima pagina, era destinato a seguire le
preghiere durante la celebrazione della messa ed è comprensivo di due volumi,
uno destinato alle preghiere durante l'estate, l'altro durante l'inverno. 4.
L’arte di
Pucelle aveva superato di gran lunga la miniatura parigina del suo tempo e
sulla sua stessa lunghezza d’onde e in una loro palese derivazione si pongono “Jean le Noir”, il “Maître du Parement de Narbonne” e
l'Apocalypse de Angers.
 Simone e il suo allievo Matteo Giovannetti avevano esercitato un ruolo fondamentale nella cultura figurativa ad Avignone che, intorno al Palazzo dei Papi, era diventata una scuola per l’Arte di tutto l’Occidente europeo dando una risoluta virata verso il “Gotico internazionale”.
Simone e il suo allievo Matteo Giovannetti avevano esercitato un ruolo fondamentale nella cultura figurativa ad Avignone che, intorno al Palazzo dei Papi, era diventata una scuola per l’Arte di tutto l’Occidente europeo dando una risoluta virata verso il “Gotico internazionale”.










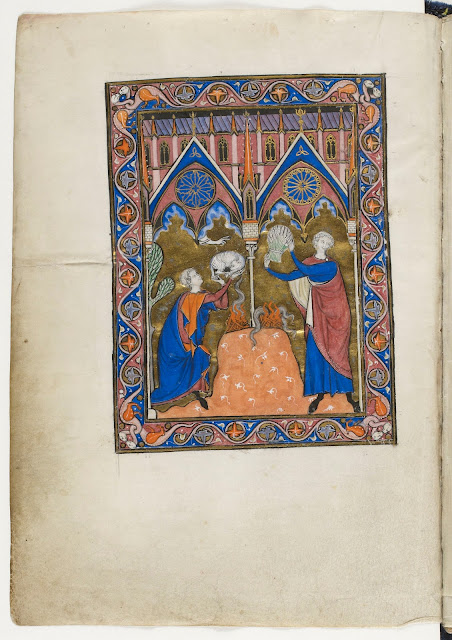













.jpg)










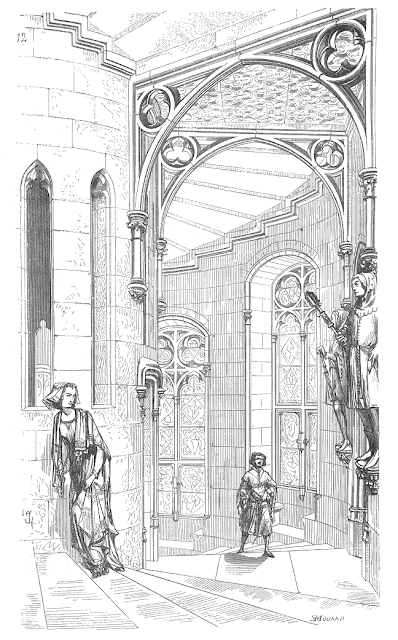


.jpg)

.jpg)










