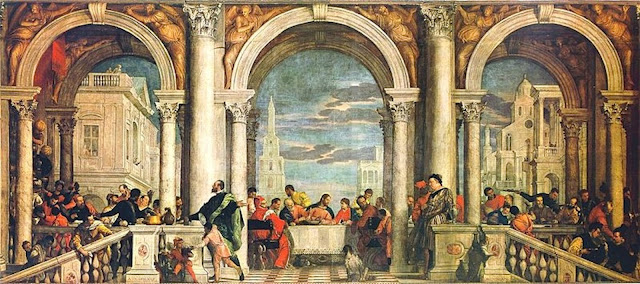Quando furono istituiti i dipartimenti, sembrava solo un
adempimento burocratico, ma pian piano diventò un momento di incontro e di
confronto una felice occasione per parlare di didattica e per scambiare esperienze.
Il nostro mentore era Francesco Patrizio che ha sempre
mostrato di credere in me, in noi, quando le nostre singolarità diventarono un
plurale. Il dipartimento era numeroso. La nostra Filomena Pontecorvo, la cara
Rosalba Mascolo, il compianto Gigi Attianese. Nel corso degli anni tuttavia la
schiera, per non so dire quali lambiccate ragioni oltre ai pensionamenti e a qualche
dolorosa perdita, si è andata assottigliando e questo se da una parte ci diede
un maggiore senso di debolezza, dall’atro ci ha fatto maggiormente stringere le
une alle altre. Poi le schiere si sono di nuovo rimpolpate e accanto a me e
alle mie care Nella Aversa, Pina Castaldo e Anna Limodio si sono aggiunte Maria
Antonietta Zeppetella del Sesto, passata ora alla presidenza, e Rosaria Menditti,
animatrice dell’indirizzo turistico. Poi sono giunte la dolce Rosalba Grosso, la
tenera Luisa Panariello, Giovanna Aspide, dolcissima ma forte, e poi ancora le
vivacissime Antonella Ferrentino e Marica.
A tutte loro dedico questo mio lavoro, faticoso, che spesso
per vicissitudini domestiche e per reali oggettive difficoltà di indagine avevo
pensato di abbandonare. Ma gli incoraggiamenti di Anna e di Nella mi hanno
spinto a continuare.
Non volevo deludere e volevo donare l’unico florilegio
che sono in grado di donare un saggio di arte che spero che accetterete anche
coi suoi vistosi limiti.
Una parola ancora voglio dedicare alle professoresse
Rosanna Larosa che spesso collabora con il nostro dipartimento, mostrando per
noi grande simpatia, e alla professoressa Ida Balì che ha spesso amabilmente apprezzato
i miei scritti.
Incontri importanti che a volte il destino ci dona.
Con stima e affetto
Max
La Chiesa, l’arte e le immagini sacre. Un rapporto affascinante quanto complesso, non privo di tensioni e di contraddizioni durante un secolo, il Cinquecento, percorso da profonde e laceranti lotte religiose.
All’inizio del secolo, i fermenti che avevano
già a lungo agitato la religiosità tardomedievale si coagularono nella Riforma
protestante avviata nel 1517 da Martin Lutero e proseguita da Zwingli a Zurigo e da Calvino a Ginevra. I protestanti accusavano la Chiesa romana di
aver perduto il senso di umiltà e di povertà che aveva caratterizzato la chiesa
delle origini, lasciandosi allettare solo da potere, da ricchezza e da piaceri
terreni.
L’attacco al tradizionale magistero della
chiesa fu destinato a produrre effetti vastissimi a tutti i livelli. L’Europa
occidentale fu spaccata a metà dalla riforma protestante: la parte
centro-settentrionale aderì al Protestantesimo, quella meridionale rimase la
roccaforte del Cattolicesimo.
Le conseguenze di questa spaccatura furono
notevoli non solo sul piano politico, perché in gioco non c’era soltanto un
contrasto teologico-dottrinale, ma uno scontro di potere che determinò un clima
di guerra, combattuta con le armi dell’inquisizione, dello spionaggio e della
caccia alle streghe. Questo clima si arroventò sempre di più con la conclusione
del Concilio di Trento nel 1563. Le conseguenze si riverberarono
profondamente anche sul piano socioculturale, quindi l’arte, il teatro, la
musica, la letteratura e gli stessi stili di vita furono profondamente
influenzati dalla diffusione delle problematiche teologiche e devozionali.
Il Concilio, convocato nel 1545 per tentare
una ricomposizione tra cattolici e protestanti, diventò in realtà il luogo di
elaborazione della nuova ideologia della chiesa romana che, con la sua Riforma,
dava una risposta alla Riforma proposta dai protestanti.
La Chiesa romana non poteva ignorare la sua
eccessiva mondanizzazione, ma il risultato degli interventi conciliari, più che
ravvivare la fede dei credenti, produsse sostanzialmente un clima di maggiore
severità e la risposta al Protestantesimo diventò l’intolleranza: si poteva
essere imprigionati, torturati e condannati a morte per semplici reati di
opinione, instaurando un clima di terrore che serviva ad arginare la diffusione
dello scisma riformistico. Casi notevoli di questa intolleranza furono le
vicende dapprima di Giordano Bruno e poi di Galileo
Galilei: in pratica bastava avere idee diverse da quelle delle gerarchie
ecclesiastiche per andare incontro ad accuse, processi, terrore e morte.
Fra i protestanti e la chiesa romana ci
furono profonde divergenze anche sul piano artistico che produssero potenti
contraccolpi. Allo sfarzo esteriore e all’eleganza tutta umana dell’arte
rinascimentale, propri di una chiesa ormai mondanizzata, la Riforma
protestante contrapponeva una religiosità che metteva in primo piano l’interiorità,
la valorizzazione della fede e il ruolo imprescindibile della grazia divina
nella salvezza dell’uomo. I nuovi edifici religiosi costruiti sotto l’influenza
protestante mostrano, infatti, caratteri di funzionalità e di sobrietà e
lasciano poco spazio alle preoccupazioni rappresentative. Lutero tuttavia,
attento all’assimilazione della sua dottrina della fede, favorì sia il ruolo
catechetico delle immagini, sia il principio della libertà individuale di
utilizzarle e, sebbene non avesse abolito del tutto l’iconografia religiosa, la
piegò alle proprie esigenze, conservando ciò che poteva rafforzare, sul piano
del messaggio visivo, la nuova lettura del Vangelo richiesta dal canone
luterano. La scelta degli artisti andava per lo più verso la raffigurazione
letterale di «storie bibliche», mentre erano del tutto escluse le storie dei
santi, pertanto utilizzò un’opportuna iconografia propagandistica delle sue
idee riformatrici cui non sfuggirono artisti come Albrecht Dürer e Hans Holbein.
Posizioni estreme sulle immagini sacre furono
invece quelle assunte da Huldrych Zwingli che, accusandole di
essere uno strumento di idolatria, ne sosteneva la distruzione. Nell’Europa
protestante non mancarono forme di profonda intolleranza, infatti, diversi
riformatori protestanti, fra i quali il già citato Zwingli, Giovanni
Calvino e Andrea Carlostadio, appellandosi ai divieti del Pentateuco e richiamandosi ai Dieci Comandamenti, incoraggiarono la
demolizione delle immagini religiose: immagini di santi o della Madonna,
vetrate che raffiguravano eventi miracolosi o soprannaturali furono rimosse
dalle chiese e dalle cappelle e spesso furono distrutte. Nel 1559 anche
l’Inghilterra di Elisabetta accettò le tesi iconoclastiche e l’ondata del
fanatismo percorse Svizzera, Germania, Francia, Paesi Bassi e giunse a fino
alla Danimarca. Con la predicazione dei riformatori calvinisti l’impeto si
abbatté sulla Scozia, riducendo in rovine secoli di civiltà. In Francia
importanti edifici sacri come la Basilica di San Martino a Tours,
la Basilica di Notre-Dame a Rouen e la Basilica di Santa
Maria Maddalena a Vézelay furono bersaglio della violenza dei
protestanti. Nel 1566 le Fiandre furono colpite dalla cosiddetta tempesta
delle immagini quando folle inferocite, sobillate da predicatori
calvinisti, in Olanda, Belgio e Lussemburgo demolirono centinaia di chiese
cattoliche, cappelle, abbazie, monasteri e tutto ciò che contenevano; nella
stessa Germania il patrimonio artistico fu talmente smembrato e devastato a
causa dell’iconoclastia protestante, che Luigi I di Baviera nel
1842 scrisse: «Dove sorgeva la Riforma, tramontava l’arte figurativa». Simbolo
di quel periodo di devastazioni fu la "Giornata del falso idolo",
quando nella città di Ulma, nella Germania meridionale, i falò furono così
tanti e alti da intossicare l’aria.
Quest’atteggiamento iconoclasta del Protestantesimo
era in netta controtendenza con la chiesa cristiana che, in generale, aveva
sempre avuto un rapporto fecondo con l’arte. Il Cristianesimo era stato infatti l’unica
religione abramitica, l’unico monoteismo, che non aveva mai rifiutato la
rappresentazione artistica di figure umane e di storie. Già durante l’Alto
Medioevo la chiesa di Roma aveva assunto una posizione molto forte contro
l’iconoclastia bizantina, mostrando un atteggiamento sempre tollerante verso la
creatività degli artisti, anche quando, con l’avvento dell’Umanesimo e con il
ritorno alla cultura classica, i precetti estetici e i miti rinascimentali portarono
l’arte ad approdi eccellenti, ma poco ortodossi dal punto di vista religioso.
Nella vasta e complessa riforma della Chiesa,
il Concilio di Trento nelle sue fasi finali s’interessò anche dell’arte
religiosa, un problema che richiedeva un’urgente soluzione, perché i
riformatori protestanti tendevano a valutare tutte le arti figurative come
idolatre. Particolare rilievo ebbe nella realizzazione del XXV decreto del
Concilio padre Diego Laìnez, successore di Ignazio di Loyola alla guida della Compagnia di Gesù.
Padre Laìnez partecipò al Concilio di Trento fin dalle prime sessioni, dapprima come padre spirituale degli alti prelati, poi come consultore teologico, ed elaborò una vera e propria “teologia delle immagini” di cui rimangono degli importanti appunti che sono alla base del Decreto stesso. Padre Laìnez elaborò il complesso pensiero dei gesuiti riguardo alle immagini sacre ne difese la funzione simbolica, chiarendo che non si adorava l’immagine, ma ciò che essa rappresentava: «L’immagine non è intesa per quello che raffigura, ma in relazione al prototipo in esso raffigurato: Cristo, la Vergine, i santi».
Padre Laìnez partecipò al Concilio di Trento fin dalle prime sessioni, dapprima come padre spirituale degli alti prelati, poi come consultore teologico, ed elaborò una vera e propria “teologia delle immagini” di cui rimangono degli importanti appunti che sono alla base del Decreto stesso. Padre Laìnez elaborò il complesso pensiero dei gesuiti riguardo alle immagini sacre ne difese la funzione simbolica, chiarendo che non si adorava l’immagine, ma ciò che essa rappresentava: «L’immagine non è intesa per quello che raffigura, ma in relazione al prototipo in esso raffigurato: Cristo, la Vergine, i santi».
Secondo Christian Hecht, la
difesa delle immagini dei padri conciliari fu motivata da ragioni storiche e di
tradizione, la cui autorità fu anteposta addirittura a quella dello stesso
Pontefice: furono richiamate, infatti, come precedente storico le decisioni del
secondo concilio di Nicea nel 786 che si era occupato dell’iconoclastia. Ma i
padri conciliari andarono ben oltre: le conclusioni del dibattito in merito a
questo tema furono raggiunte nella XXV e ultima sessione di lavori del Concilio
di Trento, in cui si stabilì il principio che le chiese e gli altri edifici di
culto dovessero essere luoghi in cui risultasse evidente la dimensione divina
attraverso la magnificenza delle strutture e dell’arredo richiamandosi agli esempi
testimoniati nel Vecchio Testamento in merito al Tabernacolo
di Mosè e al Tempio di Salomone. Era stato inevitabile
riallacciarsi a esempi biblici, specialmente perché il mondo protestante
sosteneva che la magnificenza delle chiese fosse invece successiva all’Impero
di Costantino e come tale non fedele all’originario messaggio divino. In quella sessione si era inoltre affrontato
il problema della rappresentazione pittorica della divinità e si erano discussi
i canoni in base ai quali essa doveva essere affrontata e valutata.
Neanche questo problema era trascurabile. I
riformatori protestanti avevano duramente contestato alla chiesa l’uso delle
immagini sacre, perché le consideravano sconvenienti o spesso oltraggiose e al
limite della blasfemia: proprio nel Rinascimento l’iconografia sacra aveva,
infatti, raggiunto un grado di inammissibile sensualità, di principesco
sfarzo e di gravi difformità rispetto alle sacre scritture. Per queste ragioni
i protestanti avevano per lo più assunto un atteggiamento iconoclasta,
considerando la venerazione delle immagini, una superstizione alla stregua di
un’eresia pagana: nei paesi tedeschi si era inoltre diffusa la moda di produrre
immagini, spesso a stampa, di carattere irriverente o addirittura blasfemo nei
confronti del Cattolicesimo. Per questo motivo i padri conciliari dovevano
affrontare il problema per cui si rendeva necessario un rigoroso controllo
sull’ortodossia delle immagini religiose.
Occupandosi inoltre di tutte le
manifestazioni della fede, i padri conciliari ritennero anche necessario
affermare il valore catechetico e devozionale delle immagini sacre
che, in contrasto con il pensiero protestante, potevano essere invece
utilizzate come strumento di insegnamento religioso e di contemplazione. Si
stabilì pertanto che bisognava attribuire onore e venerazione alle immagini
sacre, non certo perché in esse si riconosceva qualche essenza divina, come
facevano i pagani di fronte ai loro idoli, ma piuttosto bisognava utilizzarle
come modelli.
Se il loro valore catechetico consisteva nel fatto che il fedele doveva trarre dalle immagini un insegnamento morale, questo implicava grande attenzione al rapporto fra l’opera d’arte e la devozione del fedele, e si doveva mirare a tre elementi fondamentali: l’educazione del fedele, il rispetto per ortodossia cristiana e lo stimolo del fedele al messaggio devozionale cattolico.
Se il loro valore catechetico consisteva nel fatto che il fedele doveva trarre dalle immagini un insegnamento morale, questo implicava grande attenzione al rapporto fra l’opera d’arte e la devozione del fedele, e si doveva mirare a tre elementi fondamentali: l’educazione del fedele, il rispetto per ortodossia cristiana e lo stimolo del fedele al messaggio devozionale cattolico.
Le conclusioni furono sancite da un decreto
del 4 dicembre del 1563 Della invocazione, della venerazione e delle
reliquie dei santi e delle sacre immagini nel quale la Chiesa riaffermava
gli antichi argomenti in favore delle immagini sacre, dichiarando che le
pitture erano la Bibbia degli illetterati e che l’arte religiosa
doveva essere al servizio della Chiesa, per l’adorazione di Cristo e della
Madonna e per la venerazione dei santi, in netta opposizione al divieto del
loro culto, propugnato invece dal Protestantesimo.
Le decisioni del Concilio, prese nel pieno
del Rinascimento, appaiono come un arretramento alle posizioni della dottrina
medievale e dispongono la necessità di un intervento diretto e rigido della
Chiesa su ogni produzione artistica affinché «niente appaia disordinato, niente
fuori posto e rumoroso, niente profano, niente meno onesto».
I decreti dettarono le norme per la
produzione artistica commissionata dalla Chiesa[1].
Si doveva ritornare a composizioni
semplici e di immediata comprensione quindi si dovevano raffigurare pochi
personaggi che esprimessero tramite gesti chiari particolari atteggiamenti.
Si dovevano rispettare maggiormente le fonti
bibliche e agiografiche perciò furono vietate le invenzioni gratuite e le
immagini di nudi, divieto quest’ultimo che restaurò il pudore nell’arte sacra:
alcune scene di nudo, infatti, furono «rivestite» per indicazione di papi o di
prelati particolarmente zelanti.
Si doveva prestare particolare attenzione nel
rendere l’arte un efficace strumento di propaganda delle dottrine
controriformiste in modo che i contenuti delle opere d’arte toccassero i punti
sui quali il Concilio di Trento aveva insistito, come ad esempio il culto
mariano, il dogma dell’eucarestia come presenza reale di Cristo nell’ostia
consacrata, il pieno risalto all’intervento divino nella vita degli uomini.
Si incoraggiava la rappresentazione o la
descrizione dell’esperienza mistica, che ebbe un periodo di particolare
rigoglio nell’età della Controriforma.
L’arte doveva indurre alla preghiera,
doveva quindi puntare al coinvolgimento emotivo del fedele, ma senza
cadere mai in eccessi drammatici o teatrali.
Si consigliarono espressamente i martiri dei
santi, soprattutto quelli più truculenti, e il tema del martirio diventò uno
dei più ricorrenti fino a tutto il Seicento, quasi a testimoniare una nuova
visione della religione, basata soprattutto sul dolore e sulla mortificazione.
Si raccomandò anche l’uso di colori non
squillanti e di ambientazioni attendibili. In un certo senso, in
quest’atmosfera buia, anche i colori si scurirono: sono sempre più gli artisti
che, sulla scia di Caravaggio, affondano le loro immagini in una cornice di
oscurità avvolgente.
I decreti conciliari introdussero infine il
principio che tutte le opere d’arte destinate alle chiese o ad altri
luoghi sacri, con eccezione delle destinazioni private, dovessero essere
approvate dal vescovo della diocesi e, qualora non fossero conformi alle
attese, potevano essere rifiutate o si poteva richiederne la modifica: qualora
infine ci fossero stati casi dubbi o di controversia con l’artista, si sarebbe
ricorsi all’insindacabile giudizio del Sant’Uffizio.
Padre Laìnez aveva avvertito però con estrema
lucidità che l’uso delle immagini doveva essere corretto soltanto
qualora si trattasse di autentico abuso, fornendo i criteri per comprendere
cosa fosse abuso e cosa non lo fosse per evitare critiche scandalistiche da
parte dei protestanti.
Investiti di questa grande responsabilità, i
vescovi ebbero atteggiamenti diversi che andarono da un’ottusa e oscurantistica
rigidità ad aperture critiche e intelligenti verso lo strumento della pittura.
Lo strumento di controllo furono le Sante visite ossia gli
interventi dei vescovi in visita pastorale per accertare lo stato della chiesa,
del suo patrimonio, della sua anagrafe spirituale, dell’atteggiamento del clero
e del popolo dei devoti con l’istituzione ecclesiastica.
Il controllo ecclesiastico in termini di committenza,
ma anche di norme e pronunciamenti ufficiali di natura teorica e pratica fu
fondamentale sulla natura, sull’uso e sulla forma delle immagini: l’artista non
era più libero di agire secondo il proprio arbitrio figurativo, come vorrebbe
il punto di vista moderno dell’autonomia dell’artista, poiché non produceva
immagini per sé, ma per un contesto specifico e per destinatari con determinate
aspettative, pertanto doveva trovare il sistema più efficace per trasmettere
dei contenuti che gli erano forniti.
In questo modo la gara tra gli artisti si
faceva sulle invenzioni compositive, sullo stile, chiamato a svecchiare e
portare a maggiore verità formule iconografiche note e correnti, senza però
contraddirne il senso, né spiazzare né confondere troppo lo spettatore; il
pittore poteva, per un certo tema/soggetto richiestogli dal committente,
presentargli più di una soluzione tra cui scegliere, ma il limite invalicabile
nell’opera dell’artista era quello fissato dall’ortodossia e dal decoro.
I pronunciamenti in tal senso del Concilio di
Trento furono fondamentali e disciplinarono la produzione delle immagini sacre,
tendendo a correggere o ad eliminare dettagli o impostazioni fuorvianti ed evitando
immagini di natura sensuale o percepite come tali dalla morale dell’epoca o
ritenute sconvenienti, o infine che si riteneva potessero fuorviare il fedele.
Furono eliminate alcune iconografie non più accettabili
sul piano teologico o formale, come l’immagine trifronte o tricefala del Cristo
per rappresentare la Trinità, la cui origine iconografica risaliva ad alcune
religioni precristiane veicolate successivamente nell’arte cristiana, o come la Madonna del Latte, in cui le rappresentazioni di Maria a seno
scoperto erano accusate, per la sensualità del seno nudo, di distogliere i
fedeli dalla preghiera. I vescovi ebbero il compito di valutare le varie
rappresentazioni e di decidere se queste dovessero essere ritoccate, oppure
rimosse. Nella diocesi di Milano, ad esempio, Carlo Borromeo trovò
sconvenienti tali immagini molto diffuse nell’area brianzola e provvide in
molti casi a farle coprire con ritocchi; inoltre alcune chiese intitolate alla Madonna
del latte, cambiarono denominazione.
L’importanza del decoro, inteso
come appropriare una forma a un contenuto o adeguare l’oggetto-immagine al
contesto cui è destinato, si evince da celeberrimi rifiuti come nel caso di
Caravaggio. Nella Cappella Contarelli della Chiesa di San
Luigi dei Francesi, Caravaggio lavorò in due riprese, dipingendo quattro
tele: due sulla Conversione di San Paolo e due sulla Crocifissione
di San Pietro, per il fatto che le prime versioni di ognuna, ritenute troppo
audaci per motivi percettivi, furono rifiutate dai committenti; nella Basilica
di Santa Maria del popolo, il quadro dell’altare della Cappella
Cerasi con San Matteo e l’angelo, Caravaggio realizzò una
prima versione, che fu rifiutata per motivi teologici, infatti, si vedeva san
Matteo con l’aspetto di un popolano quasi analfabeta, al quale l’angelo
dirigeva la mano per farlo scrivere.
Tuttavia, diversamente da quanto avvenne nel
caso della produzione a stampa di libri o di opere scientifiche, in campo
artistico non ci furono atteggiamenti di grave intolleranza o di censura, anche
perché gli artisti, fiutato il mutato clima di morigeratezza, evitarono l’uso
eccessivo del nudo, soprattutto di quello femminile, che, se non scomparve del
tutto, fu usato in modo più castigato e meno sensuale e i soggetti mitologici,
che neppure scomparvero, ma furono riservati solo alle opere laiche per la
committenza privata.
L’unico caso noto di procedimento
inquisitorio nei confronti di un artista fu quello a carico di Paolo
Veronese, per la Cena in casa Levi, ma anche qui non ci
furono soluzioni radicali e il compromesso fu presto raggiunto con qualche
piccola modifica e con il cambio del titolo all’opera.
Nel 1573, Paolo Veronese aveva completato una
colossale tela, oggi presso le Gallerie dell’Accademia, per il Convento
dei Santi Giovanni e Paolo dei domenicani di Venezia, per sostituire un
dipinto di Tiziano andato distrutto nel 1571.
Il tema doveva essere quello dell’Ultima
cena, ma Veronese lo affrontò da un punto di vista molto innovativo e
particolare. La scena si svolge, infatti, con troppa abbondanza di personaggi e
di dettagli, sotto un luminoso portico in stile palladiano. Sebbene fosse uno
dei momenti salienti della vita di Gesù, l’attenzione non è concentrata sulla
tavola, dove si sta compiendo il rito della comunione, ma è
distratta da mille altre scene collaterali che non hanno niente a che fare con
la vicenda biblica, ma che contribuiscono a dare un tono realistico alla scena.
Il tema della transubstanziazione, che è peraltro uno dei
dogmi più attaccati dai protestanti, è trattato dall’artista con leggerezza e
mondanità tutta umana oltre che con inattendibilità storica. Per i dettami del
Concilio tutto questo era inammissibile e Veronese fu convocato davanti al
tribunale ecclesiastico, contattato dal priore della Basilica per dare
spiegazioni. Veronese non accettò le richieste di modifiche al dipinto e,
chiamato a esporsi di fronte al Tribunale del Sant’Uffizio nel
luglio 1573, il pittore difese coraggiosamente le proprie scelte di
artista, dapprima appellandosi alla libertà che gli artisti e i poeti si
prendono per dare libero sfogo al loro potere immaginifico, poi analizzando e
motivando la presenza e la disposizione di alcune figure contestate dall’organo
religioso. Alla fine della contesa, Veronese non fu condannato, ma fu costretto
a modificare il nome dell’opera e ad ascrivere il nuovo titolo sul parapetto
della scala in primo piano, una scelta che comunque il pittore preferì alle
modifiche che gli erano state richieste.
Il nuovo titolo del dipinto divenne La
cena a casa di Levi che ricalca un episodio del Vangelo
secondo Luca in cui Matteo, o più precisamente Levi, ricco
pubblicano noto per i suoi bagordi, prepara una grande festa e organizza un
ricco banchetto nella propria casa per Gesù durante il quale si converte,
prendendo il nome di Matteo.
Il dibattito sulle immagini sacre diede
origine alla nascita di importanti trattati, pubblicati per istruire gli
artisti alle nuove norme compositive e raffigurative.
Il primo in ordine di pubblicazione è il
trattato Due dialoghi degli errori de’ pittori di Giovanni
Andrea Gilio del 1564, che mostra un atteggiamento molto conservativo se
non addirittura reazionario soprattutto nel secondo dialogo, in cui «si ragiona
de gli errori e degli abusi de’ pittori circa l’historie, con molte annotationi
fatte sopra il Giuditio di Michelangelo et altre figure, tanto de la vecchia
quanto de la nova Capella; et in che modo vogliono essere dipinte le sacre
imagini».
Il punto fermo rimane per Gilio l’esigenza
del decorum, inteso però soprattutto come adeguamento e come
rispetto pedissequo dei testi sacri. Da questa esigenza deriva un’approfondita invettiva
contro gli abusi dei pittori e le ormai note critiche al Giudizio michelangiolesco.
Il primato dell’historia, che per Gilio è la storia narrata dalle Scritture e dalla letteratura agiografica, filologicamente riveduta e corretta, non può
dunque essere discusso, anche perché qui si superano i limiti di una libertà
interpretativa che era diventata problematica proprio con la Riforma e proprio
a partire dal testo e dalla storia sacra.
D’altra parte le evidenti necessità di ordine
pratico, derivanti anche dall’analisi di un ampio ventaglio di esempi concreti,
spingono Gilio ad individuare e mediare tra tre diverse categorie di pittore:
lo storico, il poetico e il misto, che poi,
nella prassi, finisce per essere la categoria dominante. Lo stesso Gilio,
infatti, è costretto a riconoscere che talvolta solo scostandosi dalla lettera
del testo si può ottenere quell’efficacia didascalica e psicagogica che per
lui, come per la maggior parte dei trattatisti tridentini, costituisce il fine
morale della pittura religiosa.
L’accoglimento del decreto tridentino
presenta un progetto d’arte cristiana anche da parte dello storico e teologo
cattolico Jan Molanus (1533 - 1585), professore e in
seguito rettore all’università di Lovanio, fra le cui opere figura uno studio
sul diritto sulle immagini con contenuti religiosi il cui titolo è De
Picturis et Immaginibus Sacris, pro vero earum usu contra abusus. Quest’opera,
pubblicata a Lovanio nel 1570, è interessante poiché proviene dai Paesi Bassi
meridionali, quindi da un terreno minato dalle lotte religiose, e fu ben presto
letta avidamente in ambito cattolico. L’opera rappresenta una presa di
posizione verso la contesa iconoclastica del Protestantesimo, ma affronta anche
il problema delle ingenue sconvenienze delle figurazioni popolari, che davano
particolare occasione agli attacchi degli avversari. A tale proposito Molano
stabilisce per ogni santo e per ogni mistero del calendario liturgico la
corretta iconografia: «Le pitture sono dette i libri dei laici e degli idioti;
(...) dunque quello che è proibito nei libri, è proibito anche nelle pitture».
Nell’apertura alla devozione è pure presente un realismo naturalistico e
storico, fedele al testo scritturistico, attento alla memoria corretta della
storia della Chiesa, a rappresentare la natura come disegno di Dio, per la
riforma della vita cristiana.
Siccome le prescrizioni conciliari
sull’architettura erano state alquanto generiche, nel 1577, Carlo
Borromeo, cardinale, arcivescovo di Milano, pubblicò il trattato Instructiones
fabricae et supellectilis ecclesiasticae. Grande difensore del valore
didascalico ed educativo di una pittura ortodossa, Carlo Borromeo aveva già preso
parte attiva al dibattito sulle arti durante il Concilio e redasse il suddetto
trattato sulla costruzione e sull’arredamento dei luoghi di culto. Lo scritto
di Borromeo attesta il controllo episcopale sugli artisti e sul clero: «Ogni
immagine risponda pienamente alla verità della Scrittura, della tradizione,
della storia ecclesiastica e agli usi di santa chiesa».
Le Instructiones furono la
risposta più articolata ed autorevole della Chiesa controriformata a tutte le
accuse e agli attacchi mossi nei decenni precedenti dal mondo protestante in
materia di edifici ecclesiastici e dei loro arredi.
Nel trattato furono enunciati i dettami
di come doveva essere eretta e arredata una chiesa (o altro edificio
ecclesiastico) e i principi fondamentali per la riforma dello spazio sacro. Si
mise in evidenza soprattutto la scansione gerarchica tra navata e presbiterio e
si conferì un ruolo centrale al Santissimo Sacramento, collocandolo
sull’altare maggiore.
San Carlo durante il Concilio, era stato
segretario di Pio IV Medici, ma le sue prescrizioni furono il
risultato di diversi sinodi provinciali che si tennero negli anni successivi
alla chiusura dell’assemblea trentina.
Nel 1582 fu pubblicato il Discorso
intorno alle immagini sacre e profane del cardinale Gabriele Paleotti (1522-1597),
arcivescovo di Bologna nel 1576, la cui figura intellettuale è stata
particolarmente indagata negli ultimi decenni dalla storiografia bolognese.
Ispirato alla precettistica tridentina, il Discorso
intorno alle imagini sacre e profane, si prefiggeva come Gilio di
combattere gli abusi dovuti «all’ignoranza dei pittori circa le realtà
soprannaturali, naturali e umane» e proponeva, inascoltato da Roma, un Indice
delle immagini proibite, con un atteggiamento centralista della Chiesa e
con un dirigismo in tema di forme devozionali. Il compito del pittore per
Paleotti doveva essere «l’imitare le cose nel naturale», in tal modo sarebbe
potuto risultare comprensibile a tutti e assicurare alla pittura un valore
didattico popolare. Il fine irrinunciabile al quale il pittore doveva puntare
era: «la pittura, la quale ha da servire ad huomini, donne, nobili, ignobili,
ricchi, poveri, dotti, indotti et ad ognuno in qualche parte, essendo ella il
libro popolare, dovesse ancor essere formata in modo che proporzionalmente
potesse saziare il gusto di tutti». Ogni artista che nei soggetti sacri non
rispettasse la verità storica era invece da condannare.
Partendo da queste premesse, Paleotti afferma
che l’arte debba «illuminare l’intelletto, eccitare la devozione e pungere il
cuore» attraverso l’ordine, la chiarezza, la semplicità, il controllo della
forma, il rifiuto delle stravaganze del Manierismo.
Il Discorso del Paleotti ebbe una grande
influenza presso molti pittori, in particolar modo per coloro che si formarono nella
Bologna di fine Cinquecento, da Bartolomeo Cesi ai Carracci e ai giovani dell’Accademia degli Incamminati. Nel dialogo che
Paleotti intrattiene con gli artisti del suo tempo, da Bartolomeo Cesi a Camillo Procaccini, dai Carracci a Lavinia Fontana,
prende voce anche l’ineludibile conflitto tra committenza pubblica e privata e
le sue regole si diffusero in tutta Italia e nell’Europa cattolica.
Il punto di partenza per una disamina
dell’arte riformata, sia della trattatistica sia delle rappresentazioni
pittoriche, è inevitabilmente il citato decreto conciliare sulle immagini
sacre. Se il primo obiettivo di tale deliberazione era ribadire il valore
pedagogico e religioso delle immagini di fronte alle critiche riformate, fu
nello stesso tempo l’occasione per porre un freno al proliferare di iconografie
sempre meno ortodosse o dettate da credenze superstiziose.
Intanto occorre ricordare che non fu facile
per gli artisti del maturo Rinascimento abbandonare la cultura paganeggiante e
adeguarsi al nuovo clima controriformista. L’intenso e appassionato dibattito
sull’immagine sacra e la sua applicazione nell’arte fu complesso e dinamico,
fatto di equilibri a volte riusciti e a volte falliti tra esigenze talvolta
molto diverse talvolta addirittura divergenti. C’erano le esigenze del
committente, spesso laico, che poteva fornire indicazioni iconografiche e anche
tecniche, c’erano poi quelle della chiesa – da riferirsi spesso a vari ordini
religiosi con altrettanto varie esigenze, che comunque doveva rimanere custode
dell’ortodossia teologica in un’epoca di violente divisioni. Parallelamente c’erano
le esigenze dell’artista, che oscillavano tra ambizioni e affermazione del
proprio ruolo sociale. Tensioni e instabilità erano dunque inevitabili.
Tra i pittori che mostrarono un più rapido
aggiornamento al dettato tridentino, è significativa la posizione dell’artista
urbinate Federico Barocci, detto il Fiori (1535 –
1612), uno dei più importanti pittori di pale d’altare della sua epoca,
considerato dai contemporanei il degno erede del suo conterraneo Raffaello.
La sua prima formazione era avvenuta presso
la bottega di suo padre Ambrogio, uno scultore di origine milanese che
frequentava la corte di Urbino. Barocci studiò da vicino l’opera di artisti
come Tiziano (1485 - 1576), Raffaello (1483 - 1520) e
soprattutto Correggio (1489 - 1534), che influirono molto su di lui,
sebbene egli sia stato in realtà un riformatore dell’arte, proiettato verso il
futuro e non un semplice manierista cioè ammiratore e puro imitatore del Rinascimento.
Barocci invece, come molti storici dell’arte lo definiscono, è un capostipite
della pittura barocca che seguiva però, applicando alla perfezione il principio
rinascimentale dell’armonia fra natura e idea, senza estremizzare né uno né l’altro elemento. Ciò
che garantiva tale perfezione era soprattutto la minuziosa e organizzata arte
del disegno preparatorio. Come Leonardo, Barocci partiva sempre
dall’osservazione del reale per realizzare i suoi modelli da cui derivavano
composizioni immuni da ogni forma di artificio e dotate di una grazia spontanea
e naturale nonostante la complessa elaborazione.
A Roma Barocci lavorò presso la bottega del
pittore marchigiano Taddeo Zuccari (1529 – 1566) e la sua carriera
fu tanto folgorante da suscitare l’apprezzamento dell’ormai vecchio
Michelangelo, ma anche l’invidia di pittori che operavano in quegli anni a Roma.
Secondo alcune fonti, pare che alcuni di essi, gelosi del successo di Barocci,
abbiano tentato di avvelenarlo. Da questa tragica esperienza uscì fortemente
debilitato e, ritornato a Urbino, non volle più spostarsi. Giorgio Vasari (1511
– 1574) definì Barocci un giovane di grandi aspettative e Gian
Pietro Bellori (1613-1696), il massimo biografo dell’età barocca, lo
considerava il maestro assoluto del suo periodo.
Cronologicamente la formazione di Barocci
coincide con il momento culminante del Manierismo la cui parabola
si colloca fra il 1520 – anno della morte di Raffaello – e il 1527 - anno del Sacco
di Roma - e si può considerare conclusa con il Concilio di Trento, che
nel 1563 chiese agli artisti di raffigurare nelle opere soggetti semplici e di
facile comprensione, il contrario di quanto realizzavano i manieristi.
Il mutato clima culturale aiuta a comprendere
l’originale stile di Barocci, frutto della sua adesione alla Controriforma:
la sua attività si svolse, infatti, tutta all’insegna dell’arte riformata,
un’arte che condizionò la sua lunga e fruttuosa carriera, grazie anche alla sua
familiarità con San Filippo Neri (1515 – 1595) che gli commissionò
una pala d’altare con la Visitazione per la Cappella
Pizzamiglio nella sua Chiesa di Santa Maria in Vallicella.
A questo punto occorre soffermarsi sull’importanza
della committenza nella realizzazione di un’opera nel contesto dell’arte
riformata. Il fervore religioso nato dal Concilio portò anche a una maggiore
attenzione per i cicli iconografici, che dovevano recare in sé un preciso e
chiaro contenuto teologico aggiornato sui decreti conciliari.
Le tele delle cappelle laterali della Chiesa
di Santa Maria in Vallicella, dove San Filippo Neri aveva fondato la congregazione
degli Oratoriani, sono espressione puntuale della predicazione e della
catechesi della Chiesa abituata nei secoli a dipingere i misteri di Cristo
cioè gli eventi della vita di Cristo insieme al loro significato salvifico.
In questo senso i misteri non sono soltanto quelli che i singoli evangelisti
raccontano di un episodio evangelico, ma sono piuttosto quell’evento
considerato alla luce di ciò che Gesù intendeva manifestare operando
quell’evento. Nel termine mistero è implicito, in sostanza, il fatto
reale, storico, unitamente alla significatività salvifica di
quell’evento capace di cambiare la storia e i cuori degli uomini.
Nel mistero dell’Annunciazione, l’angelo Gabriele
mandato da Dio era andato da Maria e le aveva annunciato un figlio, il figlio
di Dio e sempre a lei, essendo ella turbata poiché non capiva come potesse
essere successo, dal momento che non aveva ancora conosciuto uomo, l’angelo
aveva rivelato che anche sua cugina Elisabetta era in attesa, nonostante la sua
età matura e la supposta sterilità ed aveva aggiunto che a Dio nulla è
impossibile. Dopo l’annuncio e dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, Maria
si era messa in viaggio per la Giudea, per andare proprio da Elisabetta alla
quale avrebbe offerto il suo aiuto, almeno fino al momento della nascita del
bambino, suo nipote.
Nella Visitazione Barocci raffigura
Maria che, con tutti quei pensieri per lei incomprensibili, ha finalmente
raggiunto la casa della cugina, che la accoglie in una calorosa stretta nel
portico della sua casa. Nel volto di Elisabetta c’è la percezione di trovarsi
di fronte alla donna che portava in grembo il Messia e loda Maria per essere
stata degna e disponibile al progetto di Dio «Benedetta tu fra le donne e
benedetto il frutto del tuo grembo. A che devo che la madre del mio Signore
venga a me? Ecco appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi il bambino ha
sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Maria riceve in quel
momento la conferma della veridicità delle parole dell’Angelo e come risposta
alla lode di Elisabetta, Maria esprimerà il ringraziamento a Dio attraverso quello
che è conosciuto come il Magnificat riportato dall’evangelista
Luca, un cantico sublime, bello e terribile, denso di reminiscenze bibliche
dove si rende grazie a Dio che preferisce chi lo teme, gli umili e gli
affamati, rispetto ai superbi, ai ricchi e ai potenti.
Soltanto Maria non pare sorridere nella gaiezza generale della scena, forse perché presaga del suo destino, forse perché sta cominciando a intuire la tragedia che si abbatterà su di loro.
In questa tela l’artista propone la stessa atmosfera domestica del testo evangelico e traduce non con magnificenza aulica, ma con tono facile e comprensibile, quella felice occasione che è familiare per le due donne e lo diventa anche per lo spettatore.
Soltanto Maria non pare sorridere nella gaiezza generale della scena, forse perché presaga del suo destino, forse perché sta cominciando a intuire la tragedia che si abbatterà su di loro.
In questa tela l’artista propone la stessa atmosfera domestica del testo evangelico e traduce non con magnificenza aulica, ma con tono facile e comprensibile, quella felice occasione che è familiare per le due donne e lo diventa anche per lo spettatore.
Alla fastosa retorica manierista si
sostituisce un linguaggio semplice e diretto, che sfiora l’animo del fedele
accarezzandolo e commovendolo, guidandolo infine al sentimento più puramente
devoto.
Questa tela, considerata dai contemporanei di
Barocci raffinata per la sua capacità di unire attraverso l’uso del
colore delicatezza e sensualità, fu dipinta tra 1583 e il 1586 in «maniera sì
bella, sfumata, dolce e vaga». Barocci, infatti, non lasciò nulla
all’improvvisazione ne studiò meticolosamente la creazione, secondo le sue
abitudini compositive.
La prospettiva, secondo una bella suggestione
della pittura nord italiana del brano architettonico sotto a un arco, apre lo
sguardo su un paesaggio suggestivo, nella parte retrostante come uno squarcio
di realtà implicito nell’estensione del sistema prospettico fino alla figura
femminile che indossa una veste gialla, che occupa la stessa posizione dello
spettatore che osserva la scena, mentre un’altra figura di un anziano, forse
Giuseppe che raccoglie il suo sacco, si muove fuori della composizione per
collegarsi al pubblico, e ancora Zaccaria, alle spalle del gruppo centrale di
Elisabetta e Maria che appare sull’uscio della casa.
In questo modo Barocci si sposta dalla
superficie del piano unico della pittura manierista e sviluppa la profondità
con la modulazione morbida e cangiante dei colori e degli effetti chiaroscurali
vibranti di emozioni e con figure che trascinano lo spettatore nell’opera, quindi
con le fisionomie gaie e i gesti naturali e spontanei della vita di tutti i
giorni.
Nel dipinto sono bellissimi i dettagli: le
due mani che si stringono calorosamente, la mano anziana di Elisabetta e quella
giovane e delicata di Maria; l’asino spettatore dell’evento e le gallinelle
nella cesta che ci comunicano che questa storia è viva nel presente. Tutto è
intriso di una grazia e di una brillantezza tali che, secondo le parole di Nicholas
Penny, «Barocci non è mai stato superato per le armonie di colori
originali e ricercate, per la dolcezza del sentimento, per le composizioni
irresistibili e vertiginose. Ha reso il sacro nello stesso tempo divinamente
bello e irresistibilmente umano». L’opera era particolarmente cara a san
Filippo Neri la cui spiritualità cercava di ricollegare il regno dello spirito
con la quotidianità della vita delle persone: in questa Visitazione colpisce, infatti, l’ambientazione quotidiana e la particolare resa della luce
che, fin dagli esordi, caratterizzò lo stile di questo pittore i cui colori iridescenti
e delicati riflettono da un lato la cultura artistica in tumultuosa
trasformazione nell’ultimo scorcio del Cinquecento e dall’altro la spiritualità
intensa e gioiosa che caratterizza il fondatore della Congregazione
dell’Oratorio.
Nella Visitazione, Barocci
continua a sviluppare attraverso la poetica del colore una strategia di
coinvolgimento emotivo: utilizzando un sistema di colori atto a creare un
impatto emotivo, usa accostamenti cromatici molto diversi, e una qualità
iridescente, come si osserva con il tessuto giallo svolto nella più ampia
tonalità chiaroscurale.
La pala si allontana dal precedente stile accademico che aveva caratterizzato la Deposizione di Cristo di Perugia, databile fra il 1567 e il 1569, ma segue invece il programma della Controriforma con una connessione mistica alla spiritualità.
La pala si allontana dal precedente stile accademico che aveva caratterizzato la Deposizione di Cristo di Perugia, databile fra il 1567 e il 1569, ma segue invece il programma della Controriforma con una connessione mistica alla spiritualità.
San Filippo Neri amò tanto quest’opera che
secondo la tradizione ne suscitò le estasi. Nel 1593, Barocci realizzò la pala
con la Presentazione della Vergine al tempio, nella cappella
Cesi nel transetto di sinistra della stessa chiesa.
Come molti dipinti della seconda metà del
Cinquecento, anche le opere di Barocci – da molti considerato l’anello di
connessione tra le distorsioni forzate del Manierismo e il dinamismo del
Barocco –, sono piene di figure rappresentate in vigorosa azione, ma Barocci, pur
rimanendo fedele al Manierismo caratteristico della sua epoca, ebbe con
esso un approccio originale, per l’uso drammatico della luce e per una
spiritualità molto esaltante. Dimostrò una sensibilità unica nel rendere con
colori caldi, emozionanti e affascinanti figure realistiche e delicatamente
espressive; aderendo alle nuove regole compositive dettate dalla
Controriforma, la sua arte conserva il ricordo dello stile raffaellesco e
rappresenta una visione aggraziata e soave dell’iconografia sacra, su modello
di Correggio e sull’esempio della lezione leonardesca[2].
In contrapposizione ai temi gioiosi che
caratterizzano il quadro di Barocci, Scipione Pulzone da Gaeta (1540-42
– 1598), ottimo pittore tardocinquecentesco, messo in ombra oggi dall’arte di
Caravaggio, offre un moderato e sobrio senso patetico nella sua Pietà
del 1593, ora al Metropolitan Museum di New York, mentre al suo posto oggi si
trova una bella Deposizione dell’artista bosniaco Safet Zec (1943).
Scipione Pulzone, conosciuto
anche come Scipione Gaetano, o semplicemente come Il Gaetano, è
uno fra i più originali esponenti della pittura nell’età della Controriforma e
fra i più apprezzati artisti attivi nel territorio romano nella seconda metà
del Cinquecento.
Pulzone fu riscoperto da Federico
Zeri, autore del saggio Pittura e Controriforma. L’arte senza tempo di
Scipione da Gaeta, edito nel 1957.
Pulzone probabilmente si formò presso il pittore fiorentino Iacopino del Conte (1515 – 1598), un artista assai vicino alla pittura fiamminga e veneta, soprattutto a quella di Sebastiano del Piombo (1485 – 1547). Sviluppò un linguaggio pittorico alquanto originale ed efficace che si finì in un percorso stilistico in cui erano armonizzate esigenze tradizionali a quelle religiose. Oltre ad essere un abile ritrattista, nell’età della Controriforma Pulzone fu uno fra gli artisti più ricercati dalla committenza religiosa. Fu console dell’Accademia di San Luca e a capo della Congregazione dei Virtuosi al Pantheon un’accademia pontificia nata nel XVI secolo, avente lo scopo di favorire lo studio, l'esercizio e il perfezionamento delle Lettere e Belle Arti, con particolare riguardo alla letteratura d'ispirazione cristiana e all'arte sacra in tutte le sue espressioni, e di promuovere l'elevazione spirituale degli artisti, in collegamento con il Pontificio Consiglio della Cultura.
Pulzone probabilmente si formò presso il pittore fiorentino Iacopino del Conte (1515 – 1598), un artista assai vicino alla pittura fiamminga e veneta, soprattutto a quella di Sebastiano del Piombo (1485 – 1547). Sviluppò un linguaggio pittorico alquanto originale ed efficace che si finì in un percorso stilistico in cui erano armonizzate esigenze tradizionali a quelle religiose. Oltre ad essere un abile ritrattista, nell’età della Controriforma Pulzone fu uno fra gli artisti più ricercati dalla committenza religiosa. Fu console dell’Accademia di San Luca e a capo della Congregazione dei Virtuosi al Pantheon un’accademia pontificia nata nel XVI secolo, avente lo scopo di favorire lo studio, l'esercizio e il perfezionamento delle Lettere e Belle Arti, con particolare riguardo alla letteratura d'ispirazione cristiana e all'arte sacra in tutte le sue espressioni, e di promuovere l'elevazione spirituale degli artisti, in collegamento con il Pontificio Consiglio della Cultura.
Le opere a tema religioso di Pulzone eseguite
in piena autonomia, come ad esempio la Sacra Famiglia, testimoniano quello
che poi fu definito dagli studiosi a proposito della sua pittura, un’arte senza
tempo: uno stile difficile da inserire in uno specifico contesto storico,
basato su un sapiente impiego di elementi arcaicizzanti, che ispirano
sentimenti di pietà e devozione, spingendo il fruitore alla meditazione
religiosa.
La pittura di Pulzone, ad eccezione della sua
consistente produzione ritrattistica, è soprattutto legata al suo periodo e
alla sua particolare committenza (prevalentemente gesuita), e rimane uno dei
punti di riferimento di quel brevissimo e non troppo chiaro periodo artistico.
Vicino ai gesuiti, Scipione Pulzone dipinse la pala d’altare della Pietà per la Cappella della Passione del Cristo nella Chiesa
del Gesù a Roma, quartier generale dell’ordine dei gesuiti. Anche in questo
caso c’è una grandissima attenzione al programma iconografico. Le scene
della Passione, iniziano dalle lunette (Gesù nell’Orto di Getsemani,
il Bacio di Giuda) e proseguono in sei tele, quattro sui pilastri (Cristo
alla colonna, Cristo nel Pretorio, Cristo da Erode,
l’Ecce Homo) e due sulle pareti (la Salita al Calvario,
la Crocifissione) e finivano con la pala d’altare della Pietà di Pulzone.
La pala della Pietà ebbe una vicenda
curiosa. Secondo la tradizione, Pulzone l’aveva dipinta per l’altare della Cappella
di Sant’Andrea, ma poi fu rimossa probabilmente su pressione di Federico Zuccari che aveva curato tutta la decorazione della cappella e fu collocata nella Cappella
della Passione di Cristo; in seguito la pala andò dispersa e infine fu
riconosciuta da Federico Zeri in un’asta di New York nel 1946 ed acquistata dal Metropolitan Museum. Federico Zeri ritiene più verosimilmente invece che
l’opera sia stata eseguita direttamente per la Cappella della Passione quindi
a completamento dell’insieme ideato e diretto da Padre Giuseppe Valeriano,
anzi così strettamente connesso, che un documento segnala un acconto per la
pala versato dai committenti nel febbraio 1590 allo stesso Valeriano.
Il tema del Lamento sul Cristo morto, che
si inserisce fra il momento della crocifissione e quello della deposizione nel
sepolcro, si era sviluppato parallelamente alla sensibilità ispirata alla
devozione dell’incarnazione, messa alla prova della morte.
Il dipinto si inserisce perfettamente nella
produzione artistica successiva al Concilio di Trento, e, anche più vistosamente
di quella di Barocci, esprime chiaramente questo nuovo orientamento, attraverso
una composizione molto semplice, con pochi personaggi, tutti immediatamente
riconoscibili e con un abbigliamento consono alla tradizione, che non dà spazio
ad una possibile ambientazione della vicenda nel presente. La tela di Pulzone è concepita non come una
narrazione, ma come una meditazione sulla morte di Cristo, in linea con gli Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio di Loyola.
Per avere un’idea più precisa della nuova interpretazione dello stesso tema nell’arte riformata, è opportuno l’immediato richiamo al Compianto sul Cristo morto di Rosso Fiorentino. In questo dipinto del Rosso, conservato a Sansepolcro nella Chiesa di San Lorenzo, tutto lo spazio compositivo è affollato da una moltitudine di personaggi, non tutti facilmente riconoscibili, perché alle figure canoniche protagoniste dell’episodio se ne aggiungono altre, alcune delle quali, profondamente inquietanti che emergono dall’oscurità con tratti surrealisticamente mostruosi. L’abbigliamento tanto ricercato e la realizzazione delle acconciature, visibile soprattutto nelle due donne in primo piano, una delle quali è la Maddalena, non trova nessun riscontro nella sobrietà proposta da Scipione Pulzone.
Per avere un’idea più precisa della nuova interpretazione dello stesso tema nell’arte riformata, è opportuno l’immediato richiamo al Compianto sul Cristo morto di Rosso Fiorentino. In questo dipinto del Rosso, conservato a Sansepolcro nella Chiesa di San Lorenzo, tutto lo spazio compositivo è affollato da una moltitudine di personaggi, non tutti facilmente riconoscibili, perché alle figure canoniche protagoniste dell’episodio se ne aggiungono altre, alcune delle quali, profondamente inquietanti che emergono dall’oscurità con tratti surrealisticamente mostruosi. L’abbigliamento tanto ricercato e la realizzazione delle acconciature, visibile soprattutto nelle due donne in primo piano, una delle quali è la Maddalena, non trova nessun riscontro nella sobrietà proposta da Scipione Pulzone.
Nel dipinto di Pulzone tutta la composizione
si articola intorno al corpo di Cristo, adagiato sulle ginocchia della madre e
sostenuto da Giuseppe d’Arimatea, mentre Giovanni regge la corona di spine. Tutti
i personaggi occupano il primo piano, ruotando intorno alla figura di Cristo
che, disteso sulle gambe della Vergine, raccorda le quattro figure principali,
mentre le due donne in piedi sul lato sinistro sono più decentrate. Il pallore
esangue del corpo languido, appena segnato da qualche traccia di sangue
all’interno delle ferite, contrasta con i colori vivi dei mantelli rosso e blu
di coloro che lo circondano. Prima della sua sepoltura, Cristo è in questo modo
offerto alla meditazione dei fedeli che sono invitati a condividere l’emozione
delle donne piangenti o della Maddalena, dai lunghi capelli dorati, immersa nel
suo dolore e assisa ai piedi del suo Signore.
Alle loro spalle, in secondo piano, appaiono
i primi chiarori dell’alba, un’alba che spunta già sotto le nubi, lasciando
sperare nella resurrezione. Si apre un paesaggio montagnoso e lacustre –
delimitato dai due uomini posti ai lati che trasportano le scale – organizzato
in modo tale da indirizzare lo sguardo verso il punto focale della
composizione, grazie alle linee oblique dei profili rocciosi che convergono
verso il centro.
I colori utilizzati, molto luminosi,
contribuiscono a dare maggiore plasticità alle figure, dai cui volti traspare
un’espressione di dolore e di pateticità comunque contenuta che non arriva ed
esplodere in un eccesso di pathos. I rapporti volumetrici e cromatici sono
scanditi da un metro misuratissimo, contro un fondo che non è più unito, ma che
si apre in un calmo e ampio paesaggio, dove lungo un torrente, le capanne dei
pastori sorgono accanto ai ruderi di fortificazioni medievali; e sotto le due
scale parallele (quella a destra sorretta da un vecchio in cui forse si deve
identificare il ritratto del Padre Valeriano) i colori si stendono in zone
piane, aperte, sonoramente pure, dove domina l’azzurro della Vergine. La
vicinanza con le tempestose composizioni di Padre Valeriano ed eseguite da
Gaspare Celio doveva accrescere, per forza di contrasto, il significato di
questa pala, nella quale il momento supremo del dramma si placa in una
cristallizzazione di somma pacatezza, dolcemente rassegnata.
Il pittore ha così realizzato, rispecchiando
le esigenze della Controriforma, a una rappresentazione dalla quale traspare
una forte carica ispirata a devozione e mistica, accentuata dall’atmosfera
soffusa e quieta che pervade l’intera composizione.
Per la sua semplicità straordinaria rispetto
alle lambiccate rappresentazioni del tardo manierismo, il dipinto sembra
rievocare addirittura le atmosfere della pittura quattrocentesca; i personaggi
sono tutti facilmente individuabili, come la Vergine e la Maddalena, e sono
raffigurati con abiti estranei alla moda contemporanea e a eccessi nei colori.
Dopo il Concilio, la pittura sacra doveva
essere rinnovata secondo gli ideali controriformistici, in particolare era
diventato necessario superare l’artificiosità dell’ultima Maniera in favore di
opere più semplici e comprensibili. Non solo, ma il contenuto stesso doveva
rispettare la rinnovata visione religiosa della Chiesa di Roma, più umile e
devota.
Massimo esempio di aggiornamento in questo
senso sono i prodotti di Ludovico Carracci (1555-1619) che, rifacendosi alle
norme di decoro e di semplicità compositiva dettate dal cardinal Paleotti, fu
in grado di esprimere la propria spiritualità appassionata con toni patetici e
ricchi di persuasiva eloquenza.
L’Annunciazione del 1584 di Ludovico
Carracci, oggi conservata nella Pinacoteca Nazionale di Bologna, è esemplare in
questo senso: la raffigurazione si mantiene, infatti, molto vicina al racconto
evangelico e, tramite il richiamo alla quotidianità dell’ambiente, invita il
fedele alla preghiera nella vita di tutti i giorni.
Ludovico Carracci, di nascita e di formazione
bolognese, crebbe sotto lo stesso tetto con i suoi cugini Agostino (1557-1602)
e Annibale (1560-1609), che diventarono i suoi più stretti collaboratori. Probabilmente
nella sua adolescenza Ludovico diventò l’allievo di spicco del pittore
manierista bolognese Prospero Fontana (1512 - 1597). Carlo Cesare Malvasia,
biografo di Ludovico, riferisce che Ludovico approfondì la sua formazione
artistica, viaggiando a Firenze, Venezia, Mantova, Parma e che studiò la grande
arte di queste città. Nel 1578 Lodovico si iscrisse come maestro nella Corporazione
dei pittori di Bologna, e nel 1582 fu nominato nel Consiglio della
Corporazione. Le prime opere note di Ludovico risalgono ai primi anni
Ottanta quando lottava per affermare la sua posizione a Bologna. Entro la
fine degli anni Ottanta Ludovico e i suoi cugini erano molto richiesti da
mecenati locali e stavano acquistando fama anche fuori della città. Ludovico
iniziò una produzione costante di pale d'altare, quadri devozionali, e un minor
numero di soggetti profani per gli utenti privati, produzione che continuò senza sosta
fino alla sua morte. Verso la metà degli anni Novanta i Carracci erano i
pittori preminenti di Bologna, e avevano attirato migliori allievi della
regione, tra i quali Guido Reni (1575 - 1642), Domenichino (1581 - 1641) e
Francesco Albani (1578 - 1660). Intorno al 1582 Ludovico e i suoi cugini
fondarono l’Accademia degli Incamminati, un centro privato di
educazione autoctono che ripropose la conoscenza dei grandi maestri del
Rinascimento, meditati alla luce di una rinnovata coscienza della natura e
della tradizione. L'accento fu posto sull'importanza del disegno come mezzo per
indagare la realtà e la natura così da arrivare a un nuovo modo di dipingere
che fosse scevro degli aspetti convenzionali del manierismo cercando di ridare
spontaneità e immediatezza alle forme, in direzione di un nuovo classicismo.
Ludovico si assunse il ruolo di teorico ed
impose l'indirizzo verso lo studio del vero (prima disegnato e poi ripulito dai
difetti) l'approccio diretto al soggetto raffigurato era il primo passo della
rappresentazione al fine di renderla più naturale.
Altro principio della dottrina carraccesca
era l'aspetto devozionale, il rispetto dell'ortodossia delle storie
rappresentate. Nel far questo i Carracci seguirono le istruzioni contenute
nell'opera dei teorici del tempo come il cardinale Paleotti che nella sua
opera auspicava il controllo da parte delle autorità ecclesiastiche dei
contenuti delle scene sacre e che i santi e i loro attributi dovevano essere
facilmente riconoscibili e rispettosi della tradizione inoltre le storie
dovevano dimostrare fedeltà ai testi sacri, mentre agli artisti rimaneva la libertà di scegliere lo stile più adeguato. Altro punto di
riferimento era l'opera di Giovanni Andrea Gilio in cui
si criticavano gli eccessi di ricercatezza, di allegoria e le invenzioni
bizzarre dell'arte manierista. Le storie e i personaggi resi verosimili
dall'imitazione della natura dovevano poi essere nobilitati dall'esercizio
dell'arte e raffinati sull'esempio dei grandi maestri del passato. Seguendo
questi dettami, l'arte avrebbe svolto un preciso compito di educazione e di
elevazione spirituale, e la scena sacra si faceva più vicina alla dimensione
umana.
L’Annunciazione, eseguita da
Ludovico Carracci non ancora trentenne, fu su commissione di Giulio
Cesare Guerini per la Compagnia del Santissimo Sacramento, arciconfraternita
con sede nella Chiesa di San Giorgio in Poggiale. L’opera era
corredata di una predella, dipinta da Camillo Procaccini (1561 –
1629), perduta durante la Seconda Guerra Mondiale.
In quest’opera si riscontrano strutture
narrative e schemi compositivi molto semplificati rispetto alla pittura
tardomanieristica e tali semplificazioni testimoniano in pieno il significato
intensamente umano della riforma che Ludovico stava compiendo nella Bologna
degli anni ottanta del Cinquecento, raggiungendo un risultato più naturale e
vicino al vero, requisito indispensabile per poter meglio muovere i sentimenti
dello spettatore.
Per rendere al meglio quest’effetto di
naturalezza, Ludovico si ispira e imita Correggio che in passato era riuscito a
indagare la sfera dei sentimenti umani, rappresentando le più sottili forme di
espressività, ma di Correggio il giovane maestro tempera l’ardore con la
sobrietà delle pose dei protagonisti, dei loro gesti e con un composto uso
delle luci e dei colori.
L’opera è impostata su una struttura semplice
e rigorosa di gusto neo-quattrocentesco, la cui prospettiva è messa in risalto
dalle piastrelle che corrono verso il punto di fuga e nello stesso tempo aprono
lo spazio allo spettatore, coinvolgendolo nella dimensione esistenziale
dell’evento.
La scena è ambientata in un interno domestico
essenziale e ricco di uno spirito quotidiano, una quotidianità accentuata dalla
cesta dei panni ai piedi dell’inginocchiatoio e da quei libri posti in cima.
Maria, rappresentata molto giovane coerentemente con il personaggio storico, è
resa secondo un ideale neoraffellesco di verginale purezza che ebbe in seguito
una forte eco: è una giovinetta umile, devota, casta, laboriosa che sta pregando
nella sua stanza ordinata e tranquilla, con i suoi libri di preghiera. Accanto
all’inginocchiatoio, giace a terra il suo cesto di lavoro, più indietro il
letto riassettato con cura. L’evento soprannaturale si inserisce nella sua vita
di tutti i giorni con estrema naturalezza: l’angelo, entrato dalla porta
semiaperta, si inginocchia davanti a lei e comunica il messaggio divino mentre
lo Spirito Santo, sotto forma di colomba, discende con un raggio di sole dalla
finestra.
A questa semplicità ben si addicono la
prospettiva lineare e la sobrietà dei gesti, delle luci e dei colori, anzi è
proprio la luce che assume nell’opera una funzione particolare: l’originale
sperimentazione luministica, sebbene sia in realtà artificiosa perché proviene
da tre sorgenti diverse (quella principale che investe dal primo piano i due
protagonisti, la luce della colomba che cala dall’alto e quella che entra di
striscio da una porta laterale), serve per fare notare gli elementi chiave del
dipinto come il cesto, l’inginocchiatoio, le ali frementi dell’angelo e il suo
ramoscello di gigli.
Lontana dal luminismo spettacolare del Tintoretto, presente nella coeva Annunciazione di San Rocco, l’opera di Ludovico Carracci, per la severità della tavolozza, anticipa il naturalismo di affetti e le ricerche di verità umana e d’ambiente del primo Seicento, compreso Caravaggio.
Lontana dal luminismo spettacolare del Tintoretto, presente nella coeva Annunciazione di San Rocco, l’opera di Ludovico Carracci, per la severità della tavolozza, anticipa il naturalismo di affetti e le ricerche di verità umana e d’ambiente del primo Seicento, compreso Caravaggio.
Anche in questo dipinto si scorge un’applicazione
dei dettami controriformistici, in particolare riferimento a quanto aveva detto
il cardinale Paleotti nel suo Discorso: le immagini sacre dalle
quali si vedrà spirare pietà, modestia e devozione penetreranno dentro di noi
con molta maggior violenza che le parole e con la sua testimonianza la
Vergine Maria ci ricorda che nella vita comune di ogni giorno si accoglie il disegno
di Dio e si realizza la santità cristiana, ma sempre con disciplina spirituale.
La dimensione quotidiana di questa religiosità semplice, diretta e toccante
sembra rispecchiare lo spirito che il cardinale Paleotti aveva espresso nel suo
fondamentale Trattato.
Il filone di studi inaugurato dal libro di Emile
Mâle[3], L’arte
religiosa nel Seicento. Italia, Francia, Spagna, Fiandra del 1932 sull’arte
sacra della Controriforma, proseguito con vivaci sollecitazioni e le aperture
suggerite da Paolo Prodi nella Ricerca sulla teorica delle arti
figurative nella Riforma Cattolica del 1962 e da Bruno Toscano in Storia
dell’arte e forme della vita religiosa[4]
del 1979, aiuta a far luce nella vasta messe di opere prodotte nell’ambito
dell’arte riformata fino allora liquidata come un coacervo di opere
convenzionali.
Il concilio di Trento portò ordine e
disciplina in tutti i settori della Chiesa. Spesso non si considera come
l’assemblea tridentina si sia caratterizzata per un forte taglio pastorale,
assumendo anzi la cura d’anime come prospettiva fondamentale. Le
sue direttive si innestarono e si intrecciarono su un tessuto religioso piuttosto
vivace, cercando di fare sintesi tra le esigenze di ortodossia e di disciplina
richieste dalla degenerazione diffusa in tutto il corpo ecclesiale e la
sensibilità popolare. Ciò avvenne incanalando le manifestazioni popolari verso
alcuni elementi centrali della fede cristiana. In particolare tre: la croce,
l’Eucaristia e, appunto, la Madonna.
Nacquero così molte manifestazioni di culto
mariano – canti, processioni, santuari – che tuttora sussistono e sono sentiti
come attraenti e coinvolgenti perché riescono a coniugare l’insopprimibile
elemento sentimentale della religiosità con la correttezza teologica dei suoi
contenuti e la disciplina ecclesiastica dei comportamenti.
Il collocarsi della devozione mariana accanto
quelle direttamente cristologiche (croce ed eucaristia), in epoca tridentina,
non dipende soltanto dal ruolo centrale di Maria nella storia della Redenzione
e dalla sua vicinanza a Gesù, ma anche dalla opportunità di collocare a fianco
e quasi a custodia della Verità incarnata quella che è da sempre l’immagine
della Chiesa-madre. La mediazione materna di Maria si poneva come efficace e
persuasivo richiamo della ineliminabile mediazione ecclesiastica. L’arte della
Controriforma quindi diffuse ed esaltò l’immagine della Vergine. Ciò avvenne
attraverso la fondazione di numerosi santuari dedicati alla Madonna e la
ridefinizione del modello di pala mariana che nella struttura compositiva fu anch’essa
semplificata e ospitò figure rigidamente e ieraticamente impostate.
Varie devozioni mariane legate all’iconografia di Maria presero vigore: se era stata bandita nella forma
della Madonna del latte, l’immagine della Vergine assurse di volta
in volta a baluardo della lotta antiprotestante o di quella antimusulmana in
particolare la Madonna del Rosario, che ricevette un notevole
impulso in seguito alla battaglia di Lepanto nel 1571, la Madonna di
Loreto e l’Assunta che incontrarono una notevole fortuna
iconografica. Frequente è anche la raffigurazione dell’Immacolata Concezione
che presenta, oltre alla falce lunare e il serpente, anche alcuni attributi
derivanti dall’Antico Testamento come la palma e la scala coeli.
Non mancano poi altre classiche iconografie
mariane come l’Incoronazione e la Madonna della
Misericordia di cui uno splendido esempio è la Madonna del Popolo,
un’opera emblematica di Federico Barocci.
Il dipinto, che rientra nell’iconografia
della Madonna della Misericordia, è un olio su pannello di 359 x 252 cm, dipinto
fra il 1575 e il 1579 e oggi custodito a Firenze alla Galleria degli Uffizi.
Nel 1575 la Pia Confraternita dei laici di S.
Maria della Misericordia di Arezzo aveva commissionato a Barocci la pala
d’altare per la propria cappella che Vasari aveva realizzato per loro nella Pieve
d’Arezzo. Barocci firmò e datò nel 1579 la Madonna del popolo.
Nel dipinto di Barocci, il tradizionale tema
della Madonna della Misericordia è declinato in modo completamente diverso.
Nella raffigurazione tradizionale la Vergine è in piedi, ha grandi dimensioni e
allarga il proprio mantello per accogliervi i fedeli inginocchiati. Anche dopo
la Controriforma il soggetto continuò ad avere un largo seguito, per
le sue evidenti connotazioni devozionali, ma qui la Madonna, dal regno dei
cieli, volge il suo sguardo verso Gesù e mostra al Figlio benedicente il popolo,
esortandolo alla carità e qui l’artista sottolinea l’istante drammatico di
intercessione della Vergine per il suo popolo.
La scena coinvolge lo spettatore in un
vortice di colore e di vitalità creato dalla grande varietà di persone e di
pose in una fusione affascinante fra esperienza quotidiana e passione
trascendente, reso possibile dalla grande varietà di prospettive, di dettagli, di
luci e colori e di effetti atmosferici.
Nonostante questo processo tecnico preciso,
il genio di Barocci conserva le pennellate appassionate e libere, e, sebbene
per lui il popolo assuma un ruolo di protagonista nel dipinto più degli stessi
personaggi divini, una luce spirituale investe tutti i personaggi e sembra
tremolare come il riflesso di un gioiello su volti, mani, tendaggi e cielo. La
profonda devozione e la religiosità di Barocci sono espresse con una gioia spontanea
ed intima: nel dipinto permangono ancora i toni gioiosi e una gamma di
espressioni delicate e in certi casi malinconiche, le pose sono varie e vivaci,
non sono mai scomposte e innaturali e tutti gli elementi sono
equilibrati tra loro.
La composizione è legata ad un rigoroso
schema strutturale che mette ordine anche in una scena intricata come questa e,
mentre i personaggi dei manieristi presentano spesso atteggiamenti caricati e
innaturali deformazioni, le figure di Barocci si mantengono aderenti alla
struttura organica e i loro atteggiamenti esprimono direttamente la loro
condizione sociale e psicologica.
Barocci segue ancora i concetti spaziali
della maniera, infatti, preferisce anche qui una visuale pittorica limitata: la
sua formula usuale consisteva in una prospettiva che, precipita rapidamente in
un primo piano angusto, sale poi rapidamente in alto; ma diversamente dagli
effetti disordinati e illogici dello spazio concepito dei manieristi, quello
del Barocci è calcolato matematicamente e basta non solo a contenere le figure,
ma ad esaurire il loro movimento.
Altra caratteristica del dipinto del Barocci
che egli condivideva con la maniera è l’irregolare quanto capricciosa
sofisticazione del colore, ma, mentre i manieristi usavano per lo più colori
intermedi, in toni molto leggeri, delimitati da linee di contorno caricate in
un tono fumoso e cupo, Barocci invece usa tutti i colori in una gradazione
intensamente satura e li usa per costruire le forme senza servirsi delle linee
di contorno e inoltre usava per le ombre il colore complementare dell’oggetto
che le proiettava con il risultato che nei suoi quadri quasi non ci sono zone
scure, ma essi si presentano come campi continui di colore fluttuante.
Le innovazioni del Barocci per quanto
riguarda la scelta del soggetto non sono meno interessanti delle sue deviazioni
stilistiche dalla maniera. Per la prima volta nella storia dell’Arte egli
rappresenta il misticismo religioso, trasportando la scena in una sfera
completamente distaccata da qualsiasi elemento narrativo, in diretta
comunicazione con la fonte celeste della rivelazione; in ciò è probabilmente
riflessa una semplice, personale esperienza di quel pietismo che costituì un
aspetto di fondo, non militante, della Controriforma nell’Italia centrale e del
nord.
La sua arte ha avuto una notevole importanza
nello sviluppo iconografico europeo dell’età moderna, in virtù del suo uso
realistico delle figure e della luce e di un originalissimo uso del colore. In
notevole anticipo su Caravaggio, infatti, Barocci si servì di tonalità accese e
contrasti chiaroscurali per dare maggior forza espressiva alle proprie figure,
catturandone l’umanità con elegante vigore.
Dopo il Concilio di Trento il culto della
Madonna di Loreto diventò uno dei più popolari del mondo cattolico.
Questo culto era nato alla fine del XIII
secolo quando, secondo la tradizione, espulsi definitivamente i crociati dalla
Palestina, le pareti in muratura della casa della Madonna, la cosiddetta Santa Casa
dove la sacra famiglia aveva vissuto e dove Gesù aveva trascorso la sua
infanzia, fu miracolosamente trasportata da Nazareth a Loreto, dopo una breve
sosta in Croazia.
In un primo momento, la preziosa reliquia fu
sopraelevata e coperta da una volta, poco dopo circondata da portici, poi da
una chiesetta e infine dall'attuale imponente basilica, che nel 1587,
con l'aggiunta della bella facciata rinascimentale, poté ritenersi finalmente
conclusa. L’edificazione della grande Basilica e del Palazzo Apostolico avevano
accresciuto la fama del miracolo e l’ampio afflusso di pellegrini non solo
dall’Italia, ma anche da altri Paesi europei. Nel 1585 il santuario
fu affidato alle cure dei Gesuiti. La fama di Loreto era cresciuta
ulteriormente in seguito alla strepitosa vittoria della Lega Santa contro i
Turchi nella battaglia navale di Lepanto nel 1571 attribuita da papa Pio V
Ghisleri all’intervento miracoloso della Madonna. I reduci vittoriosi,
ritornando dalla guerra, passarono per Loreto a ringraziare la Madonna. In
seguito alla vittoria, i galeotti che erano stati messi ai banchi dei remi
furono liberati: sbarcati a Porto Recanati, salirono in processione alla
Santa Casa, dove offrirono le loro catene come ex-voto alla Madonna. Dalla
fusione di catene e ceppi furono fabbricati i grandi cancelli delle cappelle e
i quattro cancelli della Santa Casa; il comandante della Lega Santa, don
Giovanni d’Austria, sciolse il suo voto alla Madonna di Loreto con un
pellegrinaggio nel 1576. Dinanzi alla Basilica, oggi, la statua dedicata
a Sisto V Peretti ricorda il papa marchigiano che aveva dato un
grande impulso alla diffusione del culto della Madonna di Loreto e aveva
promosso la recita, insieme al rosario, delle Litanie lauretane, supplica
che si cantava originariamente proprio nella Santa Casa.
Negli anni vivaci ed esaltanti, in cui il
papato si preparava a celebrare l'anno santo 1600, con 2-3 milioni di
pellegrini, era stata sconfitta la paura del luteranesimo e il papato aveva riconquistato
il suo predominio. Con le sue ricche committenze papali, Roma era diventata la
capitale culturale d'Europa, popolandosi di migliaia di artisti provenienti da
ogni parte d'Italia e da Spagna, Francia, Germania, Fiandre e Paesi Bassi che
potevano scambiare le esperienze delle rispettive scuole, in un processo di
rinnovamento rapido e coinvolgente. Roma assorbiva inoltre l'arrivo di
nobili casate come gli Aldobrandini, i Barberini, i Borbone, i Chigi, i
Ludovisi, i Pamphili oltre a quelle tradizionali dei Caetani, dei Colonna,
degli Orsini, e le nuove committenze venivano anche da loro: reagendo alla
paura riformista con restauri e arredi finemente decorati era diventata un
cantiere a cielo aperto e vi si contavano 2000 pittori su una popolazione
in aumento dai 50 ai 100 mila abitanti, dopo il sacco del 1527.
Fra questi artisti, due giovani pittori molto
diversi fra loro erano giunti a Roma, Caravaggio (1571 – 1610) nel 1594 e Annibale
Carracci (1560 – 1609) nel 1595: fra il 1604 e il 1605 dipinsero due quadri
raffiguranti la Madonna di Loreto.
Le due Madonne sono assolutamente contemporanee e rappresentano lo stesso soggetto, ma con differenze quasi abissali nell’iconografia e nel modo di dipingere. Due interpretazioni così radicalmente diverse dello stesso tema non potevano essere immaginate: in quella di Caravaggio si osserva uno stile naturalistico talmente spinto da diventare rivoluzionario, in quella di Annibale si osserva la rielaborazione di una pittura classicista di matrice raffaellesca, basata sulla rappresentazione di una realtà idealizzata. Carracci propone una composizione tipica dell'iconografia classica, che esalta la concezione di dogma: prospettiva e telaio prospettico. Caravaggio invece ribalta completamente il processo attraverso il sistema dal basso verso l'alto: la composizione parte infatti dai piedi per poi procedere diagonalmente. Si tratta di una questione non solo puramente compositiva, ma anche legata al messaggio che conferisce una nuova visione della religiosità, legata non alla divinità, ma alla cultura dell'uomo di fronte al fatto religioso.
Le due Madonne sono assolutamente contemporanee e rappresentano lo stesso soggetto, ma con differenze quasi abissali nell’iconografia e nel modo di dipingere. Due interpretazioni così radicalmente diverse dello stesso tema non potevano essere immaginate: in quella di Caravaggio si osserva uno stile naturalistico talmente spinto da diventare rivoluzionario, in quella di Annibale si osserva la rielaborazione di una pittura classicista di matrice raffaellesca, basata sulla rappresentazione di una realtà idealizzata. Carracci propone una composizione tipica dell'iconografia classica, che esalta la concezione di dogma: prospettiva e telaio prospettico. Caravaggio invece ribalta completamente il processo attraverso il sistema dal basso verso l'alto: la composizione parte infatti dai piedi per poi procedere diagonalmente. Si tratta di una questione non solo puramente compositiva, ma anche legata al messaggio che conferisce una nuova visione della religiosità, legata non alla divinità, ma alla cultura dell'uomo di fronte al fatto religioso.
Questo confronto è particolarmente
interessante, perché da questi due giganti della pittura discendono tutti gli
artisti che operarono a Roma nei decenni successivi. Scambiandosi stimoli ed
esperienze, Annibale e Caravaggio in un dialogo puramente visivo spazzarono via
in pochi anni gli stereotipi tardo-manieristi e portarono innovazioni tecniche
e stilistiche che furono percepite in tutta Europa, finché si fusero nel
Barocco appoggiato da Urbano VIII Barberini per celebrare il definitivo trionfo
della Chiesa cattolica.
La cosa veramente interessante di questo
confronto è tuttavia osservare quanto questi due artisti hanno in comune: nati
a undici anni di distanza l’uno dall’altro, Annibale nel 1560 e Caravaggio nel
1571, morti prematuramente a un anno esatto di distanza, Annibale nel luglio
1609 a quarantanove anni e Caravaggio nel luglio 1610 a trentotto, entrambi
nati nell’Italia settentrionale, dove si erano formati artisticamente, entrambi
sono stati ispirati dai grandi maestri veneziani, in particolare da Tiziano,
entrambi sono arrivati a Roma nel biennio 1594-95, nel momento in cui la
Controriforma trionfava, entrambi avevano respinto il manierismo come fenomeno
artificioso e avevano optato invece per una pittura dal vero, ricreando ciò che
avevano visto in natura, entrambi infine avevano un talento per quel gioco di
luci e di ombre chiamato chiaroscuro.
Sebbene ai nostri occhi Caravaggio sia
l’artista più audacemente innovativo, Carracci era anch’egli nella sua epoca
considerato un artista fra i più radicali, in particolare nella sua precoce
attività giovanile. Ma con le severe normative sugli artisti a Roma, sotto
l’austero Papa Clemente VIII Aldobrandini, Carracci diventò abilissimo
nell’attenersi alle norme. Mentre Caravaggio stava diventando sempre più audace
tanto che diversi dipinti erano stati rifiutati dai committenti, Carracci stava
diventando il beniamino del mondo dell'arte. Mentre Caravaggio
notoriamente dipingeva la vita proprio come la vedeva e direttamente sulla
tela, Carracci aveva scelto di catturare il mondo ideale nel modo più naturale
possibile con una cura straordinaria per il disegno. Due diversi approcci
al naturalismo.
La Madonna di Loreto di Annibale, più
comunemente chiamata La traslazione della Santa Casa, è un classico
della sua poetica: l'interpretazione idealizzata del miracolo. Annibale imposta
la scena su uno schema perfettamente simmetrico: due angeli incoronano la Madonna,
serena nelle sue vesti rosse e blu (colori che rimandano rispettivamente al
terreno e al divino), con il Bambino in braccio, seduta su un trono di nuvole poggiato
sulla cima della Santa casa. La casa è piccola con tetto spiovente ed è
sorretta in volo da tre angeli, su un cielo luminoso e tenero. Una "luce
universale", frontale e diretta, illumina la scena mentre in basso c’è un
paesaggio oscuro col suolo squarciato dal Purgatorio. Durante il transito due
angeli incoronano la Madonna regina del cielo e Gesù Bambino versa l'acqua per
alleviare le anime del Purgatorio.
Luigi Spezzaferro ha voluto vedere
nell'immagine di Annibale un'icona: tutti i volti sono idealizzati e così pure
i corpi degli angeli ispirati alle forme classiche nelle vesti e nelle
proporzioni, non mostrano né tensioni né la fatica nel reggere la Santa casa in
volo. La Madonna ricorda la gloria dell'Assunzione: la terra in basso è oscura
e lontana, un altro mondo ben diverso da quello del miracolo.
Il dipinto fu commissionato ad Annibale dal
cardinale Carlo Madruzzo per la chiesa di Sant'Onofrio al Gianicolo dov'era la Cappella
della Madonna di Loreto, starebbe a rappresentare la preghiera della Vergine
per la salvezza delle anime del Purgatorio.
Sarebbe difficile immaginare il papa e il
clero offesi da questo e certamente Annibale non infranse le severe regole che
il cardinal Paleotti aveva codificato nella sua opera, manuale ineludibile
per gli artisti durante la Controriforma. Niente potrebbe essere più
plausibile, più aggraziato e piacevole agli occhi della sua Madonna di Loreto.
La Madonna di Loreto di Caravaggio, meglio
nota come la Madonna dei Pellegrini, fu dipinta per la Cappella
Cavalletti nella chiesa di Sant'Agostino a Roma, su commissione dalla vedova
del marchese Ermete, già membro della confraternita Santissima Trinità dei
Pellegrini, in ricordo di un pellegrinaggio compiuto dal marchese: alcuni,
infatti, vogliono vedere nel pellegrino il marchese e nell'anziana donna, sua
madre.
Nel dipinto di Caravaggio tutto
cambia, la scena è rivoluzionata. Non c'è la Santa casa, che pure nel culto
della Madonna di Loreto, è centrale nella sua venerazione, trattandosi
dell'evento miracoloso. La sua Madonna di Loreto è qualcosa di completamente
diverso rispetto al dipinto di Annibale. La Madonna è appoggiata a uno stipite
della porta sopra a uno scalino, dettaglio che si può ricondurre alla Santa
casa solo perché il titolo del dipinto lo suggerisce: nulla farebbe pensare che
è scesa dal cielo, tanto meno portata da angeli che non vi sono
raffigurati. E non c'è nulla di miracoloso, la luce non è universale,
come nel dipinto di Annibale, ma ci sono quelle tipiche bordate luminose
caravaggesche, che mettono in risalto aspetti realistici e umani dei due gruppi
a sinistra e a destra della composizione, provengono da sinistra lungo una
diagonale che lascia buia la parte centrale.
Caravaggio scelse di raffigurare una giovane
e bella Madonna con in braccio Gesù Bambino ormai cresciuto, poco pulito e
dal ventre gonfio, che quasi le scivola dalle braccia nell'atto di sporgersi in
avanti sulla soglia di una casa ordinaria.
La rappresentazione della Vergine, una
bellezza popolana con un bambino, è straordinariamente umana ed è ritratta
nell'atto di accogliere sulla porta della sua casa due anziani e laceri
pellegrini che, stremati dalla fatica ma sostenuti dalla loro fede, si
inginocchiano in adorazione. Sono scalzi, con i piedi sporchi e gonfi, segnati
dalla fatica di un lungo cammino, il viso della donna sotto la cuffia sdrucita
è rugoso eppure è illuminato dalla grazia della fede.
Il posto del miracolo che ha fatto volare la
Santa casa è preso qui dalla devozione che ha spinto i due pellegrini al lungo
cammino ed essi pregano affinché la Vergine appaia loro: sembra che Ella si materializzi
improvvisamente, sorprendentemente, come se fosse la proiezione del loro stesso
desiderio. Si materializza plasmata da una luce potentissima, la luce della fede
e dell'anima.
Il collo della Vergine è bianco e allungato,
il suo sguardo tenero e dolce, i suoi seni appena sporgenti dall'abito di
velluto rosso e blu. I suoi piedi, delicati e puliti, sono impercettibilmente
sollevati da terra, quasi ad accennare un passo di danza. Uno squisito ricordo
dell’Assunta di Tiziano. Ed è proprio quella posizione dei piedi di Maria che
rimanda all'iconografia tradizionale della Madonna di Loreto, che vuole la
Vergine in volo sopra la sua casa.
Nella preghiera dei due pellegrini e nel capo
dell'umile Madonna reclinato verso di loro c'è tanta umanità: la sua grazia
traspare dallo sguardo pieno d’amore rivolto ai pellegrini. È una madre
che, con dolcezza e trasporto, offre suo figlio per la salvezza
del mondo e non una regina incoronata e portata in gloria dagli angeli. Non c'è
spazio per l'idealizzazione e non ce n’è necessità. Ogni particolare è ritratto
dal giovane maestro con estremo realismo e con eccezionale umanità, nella
stessa misura in cui c'era tanta maestà nella Madonna di Carracci al centro di
una simmetria costruita sui cinque angeli che circoscrivono la composizione,
senza che vi sia alcuna presenza umana , ma tutti è volutamente sovrannaturale.
Questo dipinto di Caravaggio suscitò
comprensibili polemiche fin dall'inizio e non solo per i piedi sporchi e per i
lombi del pellegrino in faccia allo spettatore. Non era la prima volta che
Caravaggio faceva risaltare, nelle sue tele, i lombi di un personaggio: lo
aveva già fatto pochi anni prima nella Crocifissione di San Pietro, dove in
primo piano si offrono all'osservatore le natiche di uno degli aguzzini.
Anche gli stessi pellegrini erano sfrontatamente veri, un troppo vivo ricordo
della loro spiacevole forte presenza in una città già affollata. Oltre a
questo, una delle regole sancite da Paleotti era il divieto di rappresentare
santi impegnati in ordinarie attività quotidiane e non era ammissibile che la
Vergine uscisse sulla soglia di casa come una casalinga, soprattutto se alla
Vergine erano date le sembianze di Lena Antognetti, una ragazza di discussa fama
che aveva posato per Caravaggio e che era frequentata da molti. Servirsi
di lei come modella era un’operazione ardita, poiché a Roma molti conoscevano
Lena e conoscevano la sua bellezza: quindi si può ben immaginare che vederla
sugli altari suscitasse qualche sussulto.
Caravaggio palesemente ignorò il divieto del
Concilio di Trento di rappresentare le figure sacre come persone viventi e
riconoscibili, oltre che sensualmente attraenti, ma in qualche modo vinse la
sua partita proprio con la bellezza: nel senso che gli parve naturale che la
migliore bellezza di Roma fosse destinata a rappresentare Maria e ancor oggi,
guardando quella tela, ci si persuade subito della saggia imprudenza di quella
scelta. Del resto l’idea che Caravaggio si era fatta di Maria, era quella di
una donna sottomessa al Figlio, ma non certo al mondo, semmai era una capace di
tener testa al mondo.
E il risultato? La gente di tutto il
mondo visita Sant'Agostino per vedere la versione della Madonna di Loreto
di Caravaggio come fanno per quella di Carracci a Sant'Onofrio? Perché non è così? La
risposta ce la offre Vittorio Sgarbi quando dice: «Non sono stati il Settecento
o l'Ottocento a capire Caravaggio, ma il nostro Novecento. Caravaggio viene
riscoperto in un'epoca fortemente improntata ai valori della realtà, del
popolo, della lotta di classe. Ogni secolo sceglie i propri artisti. E questo
garantisce una attualizzazione, un'interpretazione di artisti che non sono più
del Quattrocento, del Cinquecento e del Seicento, ma appartengono al tempo che
li capisce, che li interpreta, che li sente contemporanei. Tra questi, nessuno
è più vicino a noi, alle nostre paure, ai nostri stupori, alle nostre emozioni,
di quanto non sia Caravaggio».
La sua Madonna di Loreto affascina e
ipnotizza: ha un impatto emotivo e un'immediatezza maggiore rispetto a quella
di Annibale, perché parla direttamente al cuore. Anche nei riferimenti
religiosi si possono vedere i differenti versanti, quello ortodosso e classico
della chiesa trionfante nella sua gloria in Carracci; quello spiritualista di
ispirazione francescana della chiesa povera che non evoca la gloria dei cieli,
ma l'umiltà e l'umana comprensione in Caravaggio. Occorre, infatti, tenere ben
presente che se nei comportamenti Caravaggio appare un pittore maledetto,
stereotipo di genialità e sregolatezza, le sue opere sono permeate da una
profonda religiosità: il giovane Michelangelo Merisi, orfano di uno dei mastri
fabbricatori addetti ai cantieri delle chiese milanesi, era vissuto nella
cattolicissima Caravaggio ed era stato orientato a una formazione di tipo
cattolico-pauperistica secondo lo spirito devoto di San Carlo Borromeo. La sua
formazione adolescenziale era avvenuta nelle parrocchie, sotto la cura dello
zio sacerdote, lo stesso che lo aveva spinse a Roma dal cardinal Del Monte. A
Milano Caravaggio aveva formato la sua visione del mondo ispirata al pauperismo
e, come ha già mostrato Maurizio Calvesi nel suo saggio Le realtà del
Caravaggio del 1990, il giovane pittore «amava un cristianesimo delle origini
nel solco di San Carlo» e che la sua ideologia si opponeva ad aspetti della
Controriforma troppo dogmatici o troppo lontani dalle esigenze dei più poveri.
Il giovane Caravaggio, vissuto fino alla sua morte sotto l’egida di Costanza
Colonna, marchesa di Caravaggio, doveva aver seguito le lezioni di catechismo
che la nobildonna era solita impartire nei giorni festivi nel borgo e
partecipava con fervore all’adorazione delle Quarant’Ore. Sarebbe un errore
pensare che, con il suo arrivo a Roma, tutta questa formazione si sia dissolta
nel flusso violento della sua vita e della sua pittura. Tutta la sua pittura è
piena di allegorie evidenti: nel luglio del 1600 il significato pittorico della
Cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi con il ciclo delle tre tele su
san Matteo era un’evidente metafora teologica che assimilava l’ombra al peccato
e il fendente di luce alla Grazia.
È interessante notare infine che, mentre
Caravaggio è notevolmente l'artista più popolare oggi, Carracci, per centinaia
di anni dopo la sua morte, fu considerato il più grande pittore italiano a
cavallo del XVII secolo e che, mentre Caravaggio era stato del tutto
dimenticato a soli vent’anni dopo la sua morte, la sua popolarità sarebbe
cominciata a salire di nuovo per buona parte del XX secolo.
Un altro esempio di successo iconografico
mariano ci è offerto da Giovanni Battista Crespi, detto il Cerano (1573 –1632), con la sua Madonna del Rosario del 1612, una delle più
tradizionali raffigurazioni nelle quali la Chiesa cattolica venera Maria.
Dal punto di vista iconografico, l’immagine
della Madonna del Rosario, sconosciuta in oriente, è strettamente legata ai
Domenicani ed è ripresa da quella, più antica, della Madonna della cintola
in cui la Vergine, durante la sua Assunzione al cielo, donò la sua cintola
all’apostolo Tommaso. L’origine storica del tema del Rosario risale invece al
XII secolo, quando i monaci Cistercensi, partendo dalla tradizione di dedicare
alla Vergine una corona di rose, elaborarono una speciale ghirlanda: una
preghiera che essi chiamarono appunto Rosario, essendo essa paragonata a
una mistica corona di rose offerte alla Madonna. La devozione del Rosario fu in
seguito perfezionata e diffusa da san Domenico il quale nel 1214 ricevette,
secondo la tradizione agiografica, il primo rosario dalla Vergine Maria che lo
indicò come rimedio per la conversione dei non credenti, per la salvezza dei
peccatori e per sconfiggere l’eresia albigese. Dopo il Concilio di Trento la
pietà mariana trovò nella recita del rosario una delle sue più peculiari
espressioni. Questa forma popolare di preghiera fu propagandata dalla Chiesa
cattolica per contrastare la riforma protestante. Nel 1569, Pio V
Ghisleri approvò ufficialmente quella pratica e nel 1572 istituì la festa
liturgica con il nome di Madonna della Vittoria a perenne ricordo della
battaglia navale di Lepanto, svoltasi appunto il 7 ottobre del 1571 nella quale
la flotta della Lega Santa aveva sconfitto quella dell’Impero ottomano: i
cristiani attribuirono il merito della vittoria alla protezione di Maria, che
avevano invocato recitando il Rosario prima della battaglia.
Con l’aiuto della pittura la Chiesa
contribuiva a propagare la recita del rosario che fu chiamato anche il Vangelo
dei poveri, che in massima parte non sapevano leggere, perché dava il modo di
poter pregare e nello stesso tempo meditare sui misteri cristiani, senza la
necessità di leggere un testo.
Iconograficamente, nella Madonna del Rosario,
la Vergine è rappresentata tradizionalmente con una veste azzurra e una corona
del Rosario tra le mani di solito accompagnata dal Bambino Gesù in braccio
spesso venerata da alcuni santi domenicani che accolgono dalle sue mani (o da
quelle del Bambino) la corona del Rosario. I santi domenicani che ricorrono più
frequentemente ai piedi e intorno alla Vergine sono San Domenico di Guzmán,
Santa Caterina da Siena e Santa Rosa da Lima. Dopo la Controriforma furono
eseguite molte raffigurazioni della Madonna con la corona del Rosario: le
numerose varianti riportano, solitamente, accanto all’immagine centrale, i
riquadri con i quindici misteri del Rosario.
Cerano, di due anni più giovane di
Caravaggio, è uno dei massimi artisti del periodo tra la fine del Cinquecento e
il primo Seicento. Non più manieristico e non ancora barocco, visse nel
periodo in cui si andò codificando un’arte religiosa direttamente guidata e voluta
dagli uomini della Controriforma. Per la Chiesa di San Lazzaro alle Monache a
Milano, Cerano dipinse questa sua Madonna del Rosario, oggi custodita ed
esposta nella Pinacoteca di Brera.
Quest’opera, comunemente considerata la più
celebre del Cerano per le sue numerose riproduzioni novecentesche in testi
scolastici e divulgativi, è caratterizzata da una grande accentuazione pietistica,
infatti, si nota il tentativo del maestro di fondere le richieste di propaganda
cattolica controriformata con lo stile del pieno Rinascimento, propugnato da
Raffaello e da Tiziano e mediato attraverso Gaudenzio Ferrari e Lorenzo Lotto.
Nel dipinto l’atmosfera è concreta e umana, i
gesti sono misurati ed esprimono veri esempi di virtù cristiana. L’opera
rappresenta da un lato la “pietosa cautela” che il cardinale Federico Borromeo
raccomandava al clero nell’esposizione della dottrina cristiana e dall’altro
l’arte tipicamente conservatrice del Cerano.
Di pregevolissima e finissima fattura, la Madonna
del Rosario con i suoi giochi di colore impostati su contrasti di bianchi, di
rossi e di neri fu un modello fondamentale per gli allievi, dal genero Melchiorre
Gherardini (1607 – 1668) a Girolamo Chignoli, anche per la comparsa
dell’intonazione preparatoria bruno-rossastra che caratterizza la fase più
matura del Cerano.
La critica moderna ha pienamente rivalutato
il Cerano come uno dei massimi artisti della sua epoca. Il pittore, figlio
d’arte, iniziò giovanissimo l'attività nella zona di Novara, fin dalle prime
opere sono evidenti la forza della tradizione drammatica di Gaudenzio
Ferrari e l'interesse per certi spunti realistici di Camillo
Procaccini.
In un clima culturale molto complesso,
caratterizzato dai grandi cicli decorativi del Manierismo internazionale, il Cerano
si orientò verso la corrente pietistica della Controriforma, che trovò in
lui uno dei suoi più severi e alti esponenti, ma a questo unì una resa
pittorica della natura di pura tradizione lombarda. Nel 1601, dopo un viaggio a
Roma con il cardinale Federico Borromeo, tornò a Milano, iniziando un
lungo periodo di attività durante il quale produsse questa Madonna del rosario.
Contemporaneamente alla richiesta di canonizzazione di Carlo Borromeo, il Cerano dipinse i quattro teloni con Storie del Beato Carlo, intelligente teatro sacro popolare per le celebrazioni del giorno anniversario. Nel 1610, per l'avvenuta canonizzazione, Crespi curò tutti gli apparati celebrativi di Roma e Milano, da eseguire con il massimo fasto per il grande santo della Controriforma. I Sei Miracoli di San Carlo del Duomo di Milano, riprendono gli schemi compositivi e i colori sontuosi dei teloni precedenti, fissando un'iconografia da aristocrazia ecclesiastica e nello stesso tempo intimamente sentita dal cuore del popolo.
Contemporaneamente alla richiesta di canonizzazione di Carlo Borromeo, il Cerano dipinse i quattro teloni con Storie del Beato Carlo, intelligente teatro sacro popolare per le celebrazioni del giorno anniversario. Nel 1610, per l'avvenuta canonizzazione, Crespi curò tutti gli apparati celebrativi di Roma e Milano, da eseguire con il massimo fasto per il grande santo della Controriforma. I Sei Miracoli di San Carlo del Duomo di Milano, riprendono gli schemi compositivi e i colori sontuosi dei teloni precedenti, fissando un'iconografia da aristocrazia ecclesiastica e nello stesso tempo intimamente sentita dal cuore del popolo.
Per rinforzare nei cattolici la
consapevolezza della loro fede e per risvegliare in loro la pietà religiosa, i
committenti privilegiarono i temi iconografici più adatti alla meditazione e
alla penitenza, attraverso una produzione artistica che affascinasse e
commuovesse gli animi, stimolasse sentimenti di pietà, educasse alla devozione
e alla condivisione collettiva della fede: perciò gli artisti comunicarono
anche con un linguaggio drammatico e teatrale, adeguato sia a rendere
verosimili le visioni meravigliose di gaudio paradisiaco sia a rappresentare
realisticamente le storie di martirio dei testimoni della fede sia a svelare in
modo struggente tutte le atrocità patite da Cristo sul Golgota, le storie degli
apostoli, le opere di misericordia, i sacramenti, le visioni estatiche dei
Santi.
Nel rilancio dell’arte in questa funzione
propagandistica, catechistica e morale fu rivisitata anche l’iconografia della Crocifissione
per la quale si abbandonò il carattere narrativo a favore di una raffigurazione
iconica concentrata sul dramma di Cristo. Nacquero così i grandi altari che
sembrano costruiti su piani ascendenti, come tanti monti Calvario, con i
Crocifissi al centro o al vertice.
Il Crocifisso ligneo che il cardinale Cesare
Baronio nel 1564 donò alla chiesa di San Bartolomeo apostolo di Sora
rappresenta un mirabile esempio di scultura lignea post-tridentina. Il 26
gennaio 1564 Pio IV aveva promulgato le costituzioni e i decreti tridentini con
la bolla Benedictus Deus e proprio il 26 gennaio 1564 Cesare Baronio scrive in
Roma la lettera con la quale informa lo zio Paolo che il Crocifisso, destinato
alla cappella di famiglia nella chiesa di San Bartolomeo, era pronto. La figura
del Cristo crocifisso, caratterizzata dall’equilibrio compositivo e classica
nelle sue forme anatomiche, si offre alla devozione dei fedeli come nobile
paradigma della perfezione del mondo creato. I segni della passione, senza
sconvolgere la sublime compostezza dell’Uomo-Dio, appaiono trasumanati nella
resa evocativa di un silenzio carico di serena misericordia.
Ancora Federico Barocci dipinse nel 1604 il Crocifisso
spirante, un olio su tela di 374 x 246 cm oggi al Museo Nazionale del Prado.
Questo tipo iconografico di Cristo, con la stessa intensa carica di pathos e di compostezza formale, si riscontra in opere di uguale soggetto e di datazione più tarda, dipinte da Guido Reni, oggi alla Galleria Estense di Modena, e da Anton Van Dyck, oggi al Museo nazionale di Capodimonte, del 1631-32. Pertanto quest’opera di Barocci può essere considerata il loro immediato antecedente.
Questo tipo iconografico di Cristo, con la stessa intensa carica di pathos e di compostezza formale, si riscontra in opere di uguale soggetto e di datazione più tarda, dipinte da Guido Reni, oggi alla Galleria Estense di Modena, e da Anton Van Dyck, oggi al Museo nazionale di Capodimonte, del 1631-32. Pertanto quest’opera di Barocci può essere considerata il loro immediato antecedente.
Nel dipinto di Barocci, Cristo è raffigurato
in croce in primo piano, con lo sfondo della città di Urbino, vista dalla
finestra della casa del pittore in via San Giovanni. Cristo si erge tra nubi tenebrose
che si rischiarano solo alla sommità della croce, proprio ad accentuare la
separazione tra il cielo e la terra, tra lo spirituale e il terreno.
Lo sfondo, costituito dal cielo e dal paesaggio,
è basato su una tavolozza di toni delicatamente cupi, che si staccano
nettamente e decisamente dai colori chiari, a tal punto da creare un notevole
contrasto fra lo sfondo scuro e il corpo di Cristo illuminato da una luce
frontale, tipicamente e volutamente divina.
L'opera fa parte dell’ultima produzione del
pittore e presenta contrasti tonali che dovettero sembrare al Barocci più
efficaci della concordia e unione designate da Gian Pietro Bellori come il
massimo dell’armonia compositiva. Qui la morbidezza dei colori e il giusto
accostamento tra gli stessi si fissano come elementi peculiari e prevalenti
della pittura di Barocci.
La veduta paesaggistica, uno dei primi
paesaggi non idealizzati della pittura italiana, è notevole: è distinguibile il
Palazzo Ducale, in alto il convento di Santa Caterina e in basso il borgo di
Valbona, a mezza altezza c'è il Mercatale e alla destra la chiesa di San Rocco.
È splendido il profilo delicato delle montagne, velate sul fondo dalla foschia
e dipinte con tonalità grigio–azzurre. Basterebbe questa veduta per comprendere
fin in fondo il legame affettuoso e cordiale tra il pittore e la sua città
natale.
Per comprendere meglio questo dipinto è utile
contestualizzarlo nel catalogo delle opere del maestro, quindi confrontarlo con
i lavori precedenti di identico soggetto: la differenza più evidente tra le precedenti
Crocifissioni, confrontandola con quella del Duomo di Perugia, e il Crocifisso
Spirante, è il supremo lirismo di questa tela: l'unica di Barocci in cui
Cristo sia il solo personaggio presente, nessuno è chiamato a partecipare, a
testimoniare il suo sacrificio e la sua sofferenza. Gesù è, infatti, completamente
solo di fronte al mistero della morte.
Se però nelle precedenti crocifissioni Barocci
aveva raffigurato Cristo con il capo reclinato e con gli occhi chiusi secondo
l’iconografia del Christus patiens, nel Crocifisso Spirante il maestro lo
raffigura ancora vivo, con gli occhi aperti levati al cielo, riproponendo in
una chiave assolutamente nuova l'iconografia del Christus Triumphans, ossia del trionfatore sulla morte.
Diversamente poi dalle altre crocifissioni nelle quali la croce, posta in leggera profondità, lascia vedere la base del montante ben piantato nel terreno, qui Barocci ha pensato di non inserire nessun piano prospettico tra Cristo e lo spettatore, omettendo il dettaglio dello stauros conficcato nel terreno, così che il crocifisso sembra innalzarsi senza soluzione di continuità davanti agli occhi dello spettatore. Soltanto il paesaggio orizzontale compensa l’estrema verticalità che creata dalla croce.
Diversamente poi dalle altre crocifissioni nelle quali la croce, posta in leggera profondità, lascia vedere la base del montante ben piantato nel terreno, qui Barocci ha pensato di non inserire nessun piano prospettico tra Cristo e lo spettatore, omettendo il dettaglio dello stauros conficcato nel terreno, così che il crocifisso sembra innalzarsi senza soluzione di continuità davanti agli occhi dello spettatore. Soltanto il paesaggio orizzontale compensa l’estrema verticalità che creata dalla croce.
Sempre considerando il catalogo si può
osservare che questo paesaggio urbinate è l'estrema evoluzione fra i quattro
dipinti dal Barocci: pur essendo le quattro opere accomunate dal medesimo punto
di vista, la stanza del pittore, il Crocifisso Spirante lo presenta in
versione notevolmente più ampia ed estesa oltre che meglio articolata
visivamente.
Durante il suo soggiorno in Italia tra il 1621
e il 1632, Antoon van Dyck produsse una serie di Crocifissi isolati (esemplari
oltre a questo di Napoli sono quello di Palazzo Reale di Genova, quello delle Gallerie
dell'Accademia a Venezia), destinati alla devozione privata, che incontrarono
grande successo e furono per questo più volte replicati con poche varianti
servendosi di un modulo compositivo più o meno identico.
Il Cristo sulla croce di
Capodimonte fu dipinto da Van Dyck fra il 1621 e il 1625 appartiene a questa serie.
Il dipinto, un olio su tela di 123 x 192 cm, raffigura
il momento in cui Gesù, avvertita ormai l’inesorabile fine, grida a gran voce
la celebre frase "Dio mio, Dio mio! Perché mi hai abbandonato?"
Dietro la Croce, come su tutta la Terra, in quello stesso istante, il cielo si
oscurò e un lampo, proprio come quello che compare dietro la mano destra di
Cristo, squarciò le nubi.
Seguendo fedelmente il racconto evangelico,
Van Dyck coglie lo spasimo doloroso di un uomo che sente vicina la morte e si
contrae irrigidendo tutti i muscoli del corpo in un ultimo, inutile tentativo
di resistenza all'ineluttabile destino di morte prima dell'abbandono
definitivo.
I toni cupi del paesaggio e del cielo
squarciato da improvvisi bagliori fanno emergere con enfasi la figura chiara di
Cristo, dalle membra fragili e tese. Le iridescenze grigio-argentee del
perizoma contrastano con il crudo realismo del rosso del sangue che dai chiodi
conficcati nelle mani e nei piedi cola lungo le braccia tese mentre le dita si
accartocciano come artigli, la testa scivola all'indietro e gli occhi si
volgono imploranti a cercare l'aiuto divino.
Sull'elegante corpo affusolato di Cristo
spicca il candido chiarore dell’ampio perizoma riccamente panneggiato che
recinge i suoi fianchi e che appare quasi abbagliante nel contrasto con lo
sfondo cupo e tenebroso.
La drammatica perfezione della Crocifissione di Van
Dyck, sublimazione pittorica di ogni sofferenza, si inquadra nella ricerca di
patetismo e nello stesso tempo di adesione alle Sacre Scritture e di semplicità
rappresentativa che la Chiesa richiedeva all'arte per suscitare nei fedeli
pietà, commozione e senso religioso.
Sempre sulla stessa iconografia della
Crocifissione c’è il Cristo crocifisso di Guido Reni, un olio su tela, di 261 x
174 cm, dipinto nel 1636 su commissione del nobile reggiano Girolamo Resti per
l’altare maggiore del piccolo “Oratorio delle cinque piaghe di Gesù” annesso
alla “chiesa di Santo Stefano”.
Girolamo Resti, uomo di grande pietà e amante
dell'arte e aveva fatto fare per il suo tomba un capolavoro di pittura e di
scultura e avrebbe voluto restasse per sempre nell'oratorio cui lui l'aveva
destinato. Ma, smantellato l'oratorio, trasferita l'ancona in Duomo, il
Crocefisso finì prima negli appartamenti del Duca di Modena e oggi il dipinto è
conservato nella “Galleria Estense” di Modena.
Questo Crocifisso è stato un’icona di enorme
fortuna per tutta l’età moderna: rispetto al coevo esemplare che Reni eseguì
per la basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, dove compare un dettagliato
paesaggio urbano nello sfondo, in questo di Modena invece tutto è lineare ed
essenziale. C’è un Golgota che assume la rotondità simbolica dell'intero cosmo,
c’è la croce che si staglia contro un cielo lunare definito solo dal movimento
delle nuvole nel vento. C’è solo Cristo che squarcia con la sua luce il buio,
una luce proiettata dall'alto come un faro potente che illumina il suo corpo.
Nessun personaggio a corredo, nessun santo in adorazione, nessuna scena corale
con i classici dolenti e i soldati romani.
Anche questo Cristo crocifisso, come già
quello di Barocci, volge la testa al cielo e un breve soffio di vento sembra
l’esalazione del suo ultimo respiro. Il senso di astrazione di questa spazialità
senza tempo e senza luogo è accentuato dalla luce argentea che
eleva la figura dolente in una dimensione metafisica.
Reni mostra qui di aver assimilato quella
rigidità immobile della pittura fiamminga del XV secolo che Denijs Calvaert, il
suo primo maestro, gli aveva insegnato ad apprezzare e traduce l’evento in una
fissità sovrannaturale, come se l’eternità entrasse improvvisamente nella
Storia: metafisico è il lembo del perizoma girato in alto che sembra sovvertire
ogni legge fisica di gravità, per rappresentare l'immobilità del tutto, anche
di quel velo che sembra essersi fermato.
Il solo movimento avvertibile, con il suo
potente richiamo, è nello sguardo del Cristo e nel suo dialogo con il Padre. Il
corpo di Gesù non è più devastato dal dolore, il suo sacrificio si è già
compiuto, ma è colto nell'attimo in cui transita verso la Resurrezione e coglie
l'alba di un mondo nuovo, dove l'eternità irrompe nella Storia grazie alla
redenzione.
In Guido principio ideale e realtà
s'identificano, come stretta conseguenza della teoria classicista, nel mito
stesso della bellezza, per questo il suo Gesù Crocifisso è un'opera
modernissima, lineare, essenziale, dove la luce è irradiata dal Cristo in
croce, come presenza essenziale, quasi metafisica, per incarnare i valori che
il Concilio di Trento, tramite il cardinale Paleotti e grazie a teorici come
Giovanni Andrea Gilio, ha cercato di infondere negli artisti e che trovano in
Guido Reni il maggiore interprete.
Il classicismo di Reni fu la pittura che
piacque Gian Pietro Bellori, infatti, ritiene che Reni, grazie a concetti
fondanti come l’idea e il primato della linea, nel campo del bello ha superato tutti gli altri artisti del […]
secolo e si può dire che abbia influenzato Poussin, e pittori come i
Nazareni e Puristi del XIX secolo.
Il tema della sofferenza e della morte è
suggerito dalla Chiesa nella rappresentazione dei martiri che rappresentano la
forma più elevata dell’imitazione di Cristo, perché il martirio è la suprema
testimonianza d’amore.
Il martirio dei santi diventò secondo i dettami del Concilio uno dei temi più ricorrenti fino a tutto il Seicento, quasi a testimoniare una nuova visione della religione basata soprattutto sul dolore e sulla mortificazione. La necessità di suscitare commozione nel fedele comportò la rappresentazione di scene crudeli e spesso macabre, caratteristica che si ritrova anche nel complesso ciclo di affreschi che Nicolò Circignani dipinse nella chiesa romana di Santo Stefano Rotondo intorno al 1582, con scene del Martirio di vari santi: analitiche e accurate descrizioni delle efferate crudeltà cui erano stati sottoposti i difensori della fede, testo offerto alla riflessione dei novizi gesuiti e momento tra i più indicativi della religiosità e della moralità controriformistica di immediata ispirazione gesuitica.
Il martirio dei santi diventò secondo i dettami del Concilio uno dei temi più ricorrenti fino a tutto il Seicento, quasi a testimoniare una nuova visione della religione basata soprattutto sul dolore e sulla mortificazione. La necessità di suscitare commozione nel fedele comportò la rappresentazione di scene crudeli e spesso macabre, caratteristica che si ritrova anche nel complesso ciclo di affreschi che Nicolò Circignani dipinse nella chiesa romana di Santo Stefano Rotondo intorno al 1582, con scene del Martirio di vari santi: analitiche e accurate descrizioni delle efferate crudeltà cui erano stati sottoposti i difensori della fede, testo offerto alla riflessione dei novizi gesuiti e momento tra i più indicativi della religiosità e della moralità controriformistica di immediata ispirazione gesuitica.
Negli ultimi anni del Cinquecento Caravaggio vantava
ormai committenti celebri: i Doria, i Giustiniani e tra i collezionisti,
intenditori entusiasti delle novità della sua pittura, annoverava anche
Giambattista Marino. Abbandonate così le piccole tele a carattere simbolico, si
cimentava ormai nella pala sacra: di questo periodo sono le bellissime
opere come il Riposo nella fuga in Egitto e la sublime Vocazione di
San Matteo.
In questo momento gli giunsero due grandi
committenze anche grazie al suo potente mecenate Cardinale Del Monte: la
Cappella Cerasi in Santa Maria del popolo e la Cappella Contarelli in San Luigi
dei Francesi.
Nelle due cappelle ci furono le richieste di
due martiri, genere nel quale il giovane maestro si cimentava per la prima
volta e nel quale si distingue per la rappresentazione dei supplizi di santi
apostoli e di martiri cristiani, eseguiti in varie fasi della sua tormentata
esistenza – Martirio di San Matteo, Martirio di San Pietro, Martirio di San
Giovanni Battista, Martirio di Santa Lucia, Martirio di Sant’Orsola per dire
solo di quelli di certa attribuzione.
Il primo di questi supplizi è il Martirio di
san Matteo, un olio su tela di grandi dimensioni (323 x 343 cm) che fa parte
della serie di tre dipinti su San Matteo che Caravaggio eseguì per la
chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma tra il 1597 e
il 1603, ed è ormai assodato che la tela del martirio fu la prima che
Caravaggio realizzò.
La Legenda Aurea di Jacopo da Varagine racconta che san Matteo avrebbe convertito Egippo re di Etiopia e la terra su cui regnava dopo aver resuscitato miracolosamente la figlia Ifigenia. La tradizione racconta che, quando gli successe sul trono suo fratello Irtaco, questi avrebbe voluto sposare Ifigenia che però aveva consacrato la sua verginità al Signore. Poiché Irtaco chiese a Matteo di persuaderla a concedersi a lui, il santo lo invitò ad ascoltare una sua predica che avrebbe tenuto il sabato successivo nel tempio al cospetto di tutti. Quel sabato l'apostolo proclamò solennemente che il voto di matrimonio di Ifigenia con il re celeste non sarebbe potuto essere infranto per il matrimonio con un re terreno. Il santo sarebbe stato ucciso sull'altare mentre celebrava la messa, trafitto a colpi di spada da un sicario inviato dal re.
La Legenda Aurea di Jacopo da Varagine racconta che san Matteo avrebbe convertito Egippo re di Etiopia e la terra su cui regnava dopo aver resuscitato miracolosamente la figlia Ifigenia. La tradizione racconta che, quando gli successe sul trono suo fratello Irtaco, questi avrebbe voluto sposare Ifigenia che però aveva consacrato la sua verginità al Signore. Poiché Irtaco chiese a Matteo di persuaderla a concedersi a lui, il santo lo invitò ad ascoltare una sua predica che avrebbe tenuto il sabato successivo nel tempio al cospetto di tutti. Quel sabato l'apostolo proclamò solennemente che il voto di matrimonio di Ifigenia con il re celeste non sarebbe potuto essere infranto per il matrimonio con un re terreno. Il santo sarebbe stato ucciso sull'altare mentre celebrava la messa, trafitto a colpi di spada da un sicario inviato dal re.
Caravaggio coglie il momento culminante di
questo vicenda per esprimere la violenza dell'azione nell'immagine tragica
di un delitto. Il momento rappresentato è l’istante preciso in cui San
Matteo sta per essere ucciso dal sicario del re ed è trattenuto per un braccio
dall’assassino che sta preparando la spada per uccidere l’apostolo che, scaraventato
brutalmente a terra, è poco visibile, quasi fosse un elemento secondario,
spostato verso la parte bassa del quadro.
La figura che domina la scena e che attira
tutta l'attenzione su di sé è invece l'assassino. Il giovane è seminudo:
la corporatura atletica, la sua capigliatura ricciuta e la fascia in testa
ricordano gli eroi delle statue greche, ma diversamente da questi emblemi della
perfezione morale, il richiamo classico assume una connotazione negativa,
indica la crudeltà, l'ingiustizia, la violenza, il sacrilegio del mondo pagano.
Il suo volto, con la bocca aperta sembra che stia digrignando i denti, in preda
a un furore che sta per abbattersi sul santo.
Dall'alto un angelo irrompe e si
protende per lasciare la palma del martirio nella mano aperta di san Matteo,
trasformando così il semplice evento della sua morte nel momento topico del suo
martirio. Nella scena non è chiaro se San Matteo con il braccio destro stia
cercando di difendersi dal suo aggressore o se stia invece cercando di
afferrare la palma che gli sta tendendo l’angelo.
Il crimine di questo personaggio si svolge in
chiesa davanti all'altare, e interrompe la messa celebrata dal santo: il
sacrificio di san Matteo colpito a morte è un evidente richiamo al sacrificio
eucaristico della messa, e il suo sangue che sgorga, rinvia al sangue di Cristo
sulla croce.
Tutto intorno ai due, vi è un aprirsi
convulso della folla che assiste inorridita a quanto sta avvenendo e che mostra
reazioni diverse davanti a questo evento: i personaggi fuggono dappertutto,
sconvolti, spaventati. C’è chi è terrorizzato, chi è stupito e chi non sa cosa
stia succedendo: sono gesti di stupore, di agitazione, di orrore. Il groviglio
di corpi rimanda ancora a composizioni manieriste, mentre i nudi sono di chiara
derivazione michelangiolesca.
Caravaggio racconta il martirio come un
comune fatto di cronaca, come un volgare omicidio anonimo di quelli che
capitavano spesso per le strade di Roma: San Matteo, sopraffatto dal manigoldo,
non è un eroe sacrificato, ma una vittima indifesa che cade malamente. Un
povero vecchio brutalmente aggredito. Tutte le figure sono poste all’interno di
uno spazio oscuro appena visibile nel quale i soggetti emergono grazie a una
luce la cui sorgente è tutta esterna alla tela, e serve a esaltare i dettagli
mentre tutto è immerso nell'ombra, in un gioco di contrasti che rende l'effetto
della concitazione e del dramma.
Un dettaglio della tela è particolarmente
interessante. A sinistra, dietro lo sgherro c'è un personaggio con la barba
che, mentre fugge, sembra voltarsi per osservare la scena. La sua espressione
sconvolta, contratta in una smorfia di dolore, sembra che stia piangendo: è
l’autoritratto di Caravaggio. Il pittore si inserisce nella scena in mezzo alle
altre figure come se fosse un testimone, coinvolto suo malgrado in un episodio
tragico, quasi a volerci testimoniare la violenza dilagante del suo tempo che
si intreccia con la tragedia della sua vita personale. È una testimonianza
viva, piena di consapevolezza della sua realtà.
Caravaggio era giunto a questa composizione
piuttosto sovraffollata, estremo retaggio del manierismo, dopo diversi
tentativi: dalle radiografie del dipinto sono emerse, infatti, le tre
precedenti versioni, diversissime da questa, sovrapposte prima di giungere alla
scelta finale a dimostrazione dell’estremo travaglio del maestro e delle lunghe
prove e meditazioni. Nella prima, la scena del martirio era collocata in un
ambiente con il fondo chiuso da un tempio e al centro era presente un soldato,
ovvero l’assassino il quale dominava l’intera composizione arrivando
addirittura a coprire San Matteo. Nella seconda versione invece la gestualità
dei personaggi presenti era più vivace e molto simile a quelli presenti nella
versione finale. Nella terza versione infine possiamo ammirare l’opera com’è
ora, nella sua apparente casualità, costruita su un sapiente equilibrio di
pieni e vuoti, masse e piani che si richiamano e che si dispongono in
un'armonia rigorosa impostata sulle diagonali.
L’intera scena è immersa nel buio, come se
tutto stesse avvenendo di notte. Da questo momento Caravaggio userà sempre il
fondo scuro per le sue immagini.
Con la commissione di Monsignor Cerasi dei
due quadri per la Cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo, la già citata
Crocifissione di San Pietro e la Conversione di San Paolo, Caravaggio fu
ufficialmente riconosciuto nel 1600 egregius in urbe pictor.
Caravaggio realizzò fra il 1600 e il 1601 la
Crocifissione di san Pietro, una grande tela di 230 x 175 cm che fa da pendant
con La conversione di San Paolo. Entrambe le tele sono molto interessanti,
perché Caravaggio, ancora nella fase sperimentale della sua ricerca, prosegue
nella definizione di nuovi schemi strutturali in cui colloca i propri soggetti,
e nell'approfondimento della pittura di storia, tenendo conto soprattutto del
luogo dove erano destinate queste opere, che obbligavano gli spettatori a una
visione di scorcio.
Diversamente dalla Conversione di san Paolo
di cui si conosce la prima versione rifiutata dal committente, l’unica versione
della Crocifissione di San Pietro giunta fino a noi è questa esposta sulla
parete sinistra della cappella: anche in questo caso la prima versione fu
rifiutata perché ritenuta troppo realistica. Purtroppo questa non è mai stata
ritrovata, ed è difficile immaginare come potesse essere ancor più realistica,
rispetto a questa splendida seconda versione.
Diversamente poi dalle numerose fonti
relative alla Conversione di San Paolo, riguardo la crocifissone di Pietro
abbiamo solo poche notizie che, stando ai testi biblici, fu perseguitato
durante l’impero di Nerone: solo il libro apocrifo degli Atti di Pietro,
racconta che durante la persecuzione ordinata dall'imperatore Nerone, san
Pietro stava fuggendo da Roma per evitare il martirio, quando sulla via Appia
gli apparve Gesù che camminava nella direzione opposta, verso la città. «Quo
vadis, Domine? chiese l'Apostolo. Eo Romam, iterum crucifigi gli rispose
Gesù».
L'apostolo capì allora che Gesù, con questo segno, gli aveva chiesto di ritornare a Roma e di accettare il martirio e obbedì. Per suo stesso desiderio l’apostolo scelse di essere crocifisso a testa in giù, come gesto di umiltà nei confronti del proprio maestro e per essere inferiore a Gesù che aveva subito la stessa condanna.
L'apostolo capì allora che Gesù, con questo segno, gli aveva chiesto di ritornare a Roma e di accettare il martirio e obbedì. Per suo stesso desiderio l’apostolo scelse di essere crocifisso a testa in giù, come gesto di umiltà nei confronti del proprio maestro e per essere inferiore a Gesù che aveva subito la stessa condanna.
Caravaggio scelse di seguire questa
tradizione, ma ne stravolse alcuni elementi per rendere questa scena
memorabile. Anche in questo caso Caravaggio stupì il pubblico, realizzando una
tela dal carattere antieroico ed eliminò qualsiasi accenno di sacralità
presente nella tradizionale iconografia della Crocifissione di San Pietro: la
scena è infatti ridotta all’essenziale, con i tre aguzzini, che qui però
appaiono come semplici operai piuttosto
che come spietati carnefici, il santo, la croce, la fune, la pala, il mantello
azzurro e una grossa pietra in primo piano. Anche qui, il paesaggio è del tutto
assente e manca qualsiasi riferimento al luogo del martirio, mentre gli
elementi raffigurati contribuiscono alla costruzione della scena,
caratterizzata da un impianto solido e da un’immediatezza fisica inaspettata.
Coloro che stanno legando il santo alla croce
non sono soldati che eseguono una sentenza, ma modesti operai che stanno
lavorando e lo si evince soprattutto dalle loro movenze, oltre che
dall’abbigliamento. Non aguzzini quindi, ma manovali intenti a sollevare
faticosamente la croce sulla quale è stato inchiodato Pietro. Questa visione
induce a pensare che essi siano soltanto degli strumenti inconsapevoli di
quello che stanno facendo, perché stanno eseguendo soltanto gli ordini come se
fosse un qualsiasi lavoro.
Diversamente da come accade in altre opere,
dove la luce illumina solo il corpo e il volto dei santi, in questo caso invece
la luce è concentrata tanto su Pietro quanto sui carnefici, quasi esonerandoli
dalle proprie responsabilità legate alla morte del santo. Di loro Caravaggio non
mostra i volti, come per oscurarne i sentimenti e i pensieri, mettendone invece
in evidenza i corpi, muscolosi e sudici, che scandiscono i tempi dell’azione:
il becchino che, dopo aver scavato nel terreno la buca per issare la croce,
posa l’attrezzo e si abbassa per permettere ai compagni di svolgere il loro
lavoro; poi l’operaio che, legata la corda all’asse di legno, sorregge il
crocifisso; infine l’altro operaio, incurvato e concentrato a tirare la corda
finché si compia l’estremo e definitivo innalzamento che consenta di eseguire
la sentenza capitale. Nonostante non sia visibile la fatica sui loro volti,
Caravaggio rende palpabile lo sforzo dei tre.
Tutta l’attenzione dello spettatore, grazie
all’uso sapiente della luce che si diffonde nel quadro, è concentrata sul
vecchio Pietro che, nonostante appaia stanco, rassegnato e stordito a causa
dell’improvvisa perdita dell’orientamento conseguente al rovesciamento della
croce sulla quale è inchiodato, solleva la testa e volge lo sguardo oltre la
sua martoriata mano sinistra, verso l’altare sul quale è collocata la pala di
Annibale Carracci con l’Assunzione della Vergine.
In questo dipinto si rivela una nuova
padronanza stilistica, basata su una complessa struttura impostata su più
diagonali che si intersecano e sono formate dalla croce e dalla schiena
dell'aguzzino: la prosecuzione degli assi compositivi diagonali conferisce alle
immagini un moderno sconfinamento oltre il limite della tela ed elimina
l'illusionismo prospettico tanto caro al Rinascimento.
Ancora una volta il pittore dedica una
minuziosa attenzione ai particolari, essenziali per rendere realistico il
dipinto e per farne uno dei capolavori di Caravaggio: si può segnalare per
esempio il piede sporco di uno degli aguzzini che solleva la croce con la
schiena, e ancora l’attenzione nella realizzazione della croce con le venature
del legno, e infine il riflesso della luce sulle unghie di San Pietro.
In questa tela l’andamento della luce radiale
svolge un'azione costruttiva sui corpi fortemente plastici, sporgenti dal fondo
scuro. Tuttavia la luce, pur conferendo tridimensionalità alle figure, pur
rendendole concrete, non approfondisce lo spazio perché qui l'ombra (e ancor
più nelle opere successive) è un elemento che si oppone simbolicamente alla luce.
Le forme emergono dall'oscurità impenetrabile: il messaggio rivolto all'uomo di
abbandonare le tenebre del peccato e restare nella zona illuminata
delle virtù che conducono alla salvezza divina.
Anche in questa tela il carattere di
religiosità impegnata procede di pari passo con la rievocazione del
fatto storico in un clima dimesso e popolare.
Con queste prime opere monumentali del
giovane maestro bergamasco si osserva perfettamente il passaggio dal primo
stile romano, luminoso e chiaro, alla nuova maniera del "tenebroso".
Un esempio piuttosto atipico di
raffigurazione di martirio è quello riguardante il martirio di San Sebastiano, uno
dei più raffigurati (da Alessandro Allori a Battistello Caracciolo, da
Caravaggio al Cavalier d’Arpino, da Daniele Crespi al Domenichino, da Paolo
Finoglia a Luca Giordano, dal Guercino a Giovanni Lanfranco, da Carlo Maratta a
Mattia Preti, da Ribera a Massimo Stanzione ad Andrea Vaccaro solo per
ricordare i più noti in Italia). In tal senso la storia dell’arte gli è debitrice
di capolavori assoluti, espressi in un perfetto accordo fra fede e devozione,
fra spiritualità e raffigurazione. In molti di questi dipinti San Sebastiano è
raffigurato solo, protagonista assoluto, modello dell’iconografia della
bellezza e dell’integrità: un giovane bellissimo, nudo, che subisce il martirio
delle frecce, legato a un albero o a una colonna, o sdraiato per terra, tanto
bello che neppure il supplizio riesce a umiliarlo e a sfigurarlo.
Ma perché tanta frequenza nella
rappresentazione di questo santo? Indubbiamente perché si riteneva che il santo
potesse difendere dalla peste, che per millenni aveva flagellato l’umanità: si
pensi alla terribile epidemia del 1348-1353 che uccise almeno un terzo della
popolazione europea e che provocò un mutamento profondo nella società
dell'Europa medievale, o alla pestilenza del 1576-1577, nota come la Peste
di San Carlo, o alla terribile epidemia che si abbatté nel 1630 e che fu
narrata da Alessandro Manzoni ne I Promessi sposi, o si pensi
ancora alla peste del 1656 che produsse nella sola Napoli duecentomila vittime,
o infine alla grande peste di Londra del 1665-1666 e a
quella di Vienna del 1679. Ma accanto a quest’aspetto devozionale e
apotropaico, la frequente rappresentazione del santo è probabilmente dovuta al
fatto che questo giovane seminudo, legato a un albero o a un’antica
colonna, sereno nell’accettazione del suo martirio o contorto negli
spasimi della morte, è una celebrazione della bellezza del corpo umano, che gli
artisti hanno amato esaltare proprio a partire dal Rinascimento.
Questo non spiega tuttavia perché una Chiesa
così intransigente come quella post tridentina abbia potuto tollerare che,
nella maggior parte dei casi, l'immagine di San Sebastiano trasmettesse una
carica di sensualità così forte, che assai poco si attagliava alla spiritualità
che in quel periodo la Controriforma proclamava e faceva veicolare.
Per comprendere più a fondo l’iconografia del
santo, occorre soffermarsi come sempre sulle fonti agiografiche.
Le notizie biografiche su San Sebastiano sono
poche e confuse.
Nato probabilmente a Narbona in Gallia o
forse a Milano nel 263 in una famiglia cristiana, nel 283 Sebastiano si arruolò
nell'esercito dell'imperatore Diocleziano. Giunto a Roma, diventò tribuno della
prima coorte pretoriana e fu stimato per la sua lealtà e intelligenza dagli
imperatori Massimiano e Diocleziano, che non sospettavano fosse cristiano. Il
tribuno, approfittando della sua posizione, aiutò altri cristiani rinchiusi
nelle carceri, durante la persecuzione di Diocleziano. In seguito a una
delazione, Sebastiano fu condannato a morte per non aver voluto rinnegare la
propria fede e, essendo un soldato, gli fu concesso un supplizio 'onorevole'
ossia morire tramite dardeggiamento. Fu portato fuori città, spogliato e legato
a un albero o a una colonna, e i suoi ex commilitoni lo trafissero con così
tante frecce, «ut quasi ericius esset hirsutus ictibus sagittarum».
Ciononostante Sebastiano si salvò miracolosamente e, creduto morto dagli
arcieri, fu lasciato a terra in pasto agli animali selvatici. Secondo l’usanza
dei cristiani, la vedova Irene, nel recuperare il corpo di Sebastiano, si
accorse che il tribuno non era morto, lo curò e inaspettatamente Sebastiano
riuscì a guarire. Quantunque consigliato di fuggire da Roma, Sebastiano, appena
fu in grado di muoversi, andò da Diocleziano al Tempio di Ercole. L’Imperatore,
dopo aver ascoltato i rimproveri di Sebastiano per la persecuzione contro i
cristiani, perse la pazienza e lo condannò questa volta a un supplizio
infamante: essere ucciso a bastonate o a frustate. L'esecuzione avvenne intorno
al 304 nell’ippodromo del Palatino quando Sebastiano aveva appena trentaquattro
anni e il suo corpo fu gettato nella Cloaca Massima, per evitare che i
cristiani potessero ancora una volta recuperarlo, assicurandogli con la
sepoltura la possibilità della resurrezione. La tradizione afferma che il
martire, apparso in sogno la stessa notte alla matrona Lucina, le indicò il
luogo dov’era approdato il suo cadavere per essere seppellito e questa lo fece
seppellire nelle catacombe della Via Appia che da lui presero il nome, vicino all’omonima
chiesa costruita alcuni anni dopo la sua morte.
Il martirio di San Sebastiano fu molto caro
alla cultura popolare, e l’arte assecondò queste istanze: oltre al privilegio
di tanta rappresentazione, il Santo è considerato il terzo patrono di Roma, dopo
i due apostoli Pietro e Paolo.
Nel corso dei secoli l’iconografia di san
Sebastiano è molto cambiata. Intanto occorre ricordare che le vicende del suo
secondo martirio hanno interessato relativamente poco la sua iconografia, che
ha sempre invece prediletto la rappresentazione del supplizio delle frecce.
Inizialmente il santo era stato raffigurato come un uomo anziano con la barba,
vestito alla romana, e aveva come segno di riconoscimento o una piccola croce o
una corona, emblema di martirio e di vittoria sulla morte. Nei ritratti più
tardi del Medioevo compaiono le frecce e Sebastiano è raffigurato con
l’armatura, propria di un militare. Dal XV secolo in poi, il santo cominciò a
essere raffigurato come una figura giovanile e la sua immagine diventò così un
pretesto per celebrare la bellezza del corpo nudo, secondo l’ideale edonistico
del Rinascimento. A mano a mano le sue raffigurazioni si fecero sempre più
sensuali e finirono per provocare scandalo, per questo alcune tele furono
rimosse dalle Chiese e finirono sul mercato d’arte.
La possibilità di descrivere liberamente il
martire come un giovane bellissimo che, quasi nudo subisce il martirio in un
miscuglio di dolore e di piacere,
aumentò il numero delle sue raffigurazioni. Gli artisti si sentivano
così sollecitati a cimentarsi nella trattazione del nudo, che trasformò il
santo nel corrispettivo cristiano di divinità e di eroi pagani: da Apollo a
Eros, da Prometeo legato ad Adone, come del resto Michelangelo, nel Giudizio Universale lo
aveva immaginato nudo e possente come un Ercole, mentre stringe in pugno un
fascio di frecce, beato nella comunione dei beati con Dio.
Anche Guido Reni, pittore profondamente
religioso ed estremamente devoto, subì il fascino sensuale dell’immaginario
artistico legato a questo santo, e dipinse i suoi San Sebastiano come dei
giovani bellissimi dalla pelle di seta e dal volto estatico.
Probabilmente in queste opere Reni dovette
dare voce alle sue ossessioni omoerotiche e misogine come la fobia per le donne
e la sua convinzione che gli portassero sfortuna. Dedicando ben otto dipinti
alla figura di San Sebastiano, di cui cinque soltanto per Roma, Reni sembrò
quasi ossessionato da quel corpo, al punto di raffigurarlo come un’icona sacra
che colpisce per la sua bellezza e per la sensualità della sua posa. A questo
proposito il critico americano Richard Spear, accennando all’omosessualità di
Reni, sostiene che proprio quest’aspetto del pittore si rivela nella
particolare attenzione al corpo nudo del santo. I San Sebastiano di Guido
appartengono però al mondo del pittore, alla sua esperienza visiva di giovani,
visti e frequentati: è pertanto pensabile che Guido in essi avesse messo non
tanto inconfessabili desideri sessuali come sostiene Spear, quanto un'idea di
piacere estatico ed erotico, in modo da poterla trasmettere allo spettatore,
molto più di quanto quei giovani rappresentassero reconditi desideri del
pittore.
Osservando il San Sebastiano della
Pinacoteca Nazionale di Bologna, un olio su tela databile fra il
1639 e il 1640 di 235,5 x 137 cm, è evidente che Guido si sia ricordato del
santo nudo che aveva copiato da giovane quando era all’"Accademia"
dei Carracci e ne abbia ripreso alcuni aspetti. Ma si nota anche che egli abbia
subito l’influsso di altri artisti, in particolare quello di Caravaggio. Quel
piccolo panno che ricopre i genitali è volutamente spostato, per far
intravedere, e per lasciare all’immaginazione. È visibile soltanto una piccola
parte del pube con la peluria nerastra, e il santo non ha sul corpo nudo neppure
una freccia, come se dovesse essere ancora colpito o come se le frecce non gli
fossero ancora arrivate. Tutto il resto si immagina. Ciò che maggiormente
interessa al pittore è mostrare al suo pubblico l'integrità di quel corpo,
senza che niente possa disturbare la vista, frecce o monconi di frecce, o
sangue o ombre marcate.
San Sebastiano è legato ad un albero, come
già in Antonello da Messina, e poggia su di una specie di piedistallo di
roccia, con una gamba rigida e l’altra morbidamente piegata. È chiaro che il
pittore abbia voluto mostrare qualcosa di lascivo senza essere lascivo, per
evitare la censura controriformistica. Ma è altrettanto chiaro che quel corpo è
dipinto per turbare, secondo una precisa volontà esecutiva che forse doveva
tener conto anche del desiderio del committente.
Reni ritrae un giovane qualsiasi, ma che ha
in sé qualcosa di mistico. Un "ragazzo di vita" di caravaggesca
memoria, messo lì come un santo ispirato nel quale i sensuali riccioli neri
contrastano con gli occhi in estasi, rivolti verso l'alto. Seguendo la
precettistica dei gesuiti sulle funzioni pedagogiche dell’arte sacra, i santi
“con gli occhi al cielo” aiutano a sentire emozionalmente, con sangue e carne,
cosa significhi l’afflato mistico che porta alla diretta comunicazione con
Cristo, prerogativa della devozione più profonda. Santità ed eros, dunque,
secondo la lezione del misticismo contemporaneo e attraverso le letture
agiografiche.
Quest’opera nella sua semplicità può essere
considerata una chiave di lettura di tutta la pittura di Reni: essa permette
infatti, di comprendere l’estetica della santità e di conoscere e di capire
meglio ciò che sta dietro la realizzazione dell’immagine, dell’invenzione,
della maniera e della poesia nell’instancabile ricerca della perfezione di
questo colto pittore, anch’egli molto opacizzato dall’attuale moda
caravaggesca.
Reni cerca di rappresentare la bellezza, ma
in un modo opposto a quello di Diego Velasquez: mentre Velasquez, infatti,
rende bello ciò che nella realtà non lo è, e lo fa diventare il bello stesso
dell’arte, Reni invece rappresentava persone belle, immagini belle, episodi
belli in modo bello.
Il corpo di San Sebastiano, bello come un dio
pagàno ed iconograficamente più pagàno di un dio greco, è un ideale di perfetta
bellezza. Ma è anche un modello di bellezza erotica, che anche la Chiesa ha
finito per tollerare in cambio di una maggiore attenzione al Santo. Specie nei
cupi e tragici giorni della peste che furono molti e frequenti durante la
seconda metà del XVI e tutto il XVII secolo, San Sebastiano andava fervidamente
invocato, affinché impedisse il terribile flagello.
La Chiesa, consapevole del potere seduttivo
del Santo, malgrado censure ed interventi più o meno drastici di proibizione e
rimozione, non aveva ignorato il fatto che l'icona di Sebastiano aveva una
presa straordinaria sui fedeli e quindi se da una parte induceva al peccato,
dall'altra attirava, coinvolgeva e questo al di là della sua funzione di Santo
protettore. Per questo si spiega la presenza in chiesa di dipinti che non
avrebbero mai trovato accoglienza in un luogo sacro. A giustificazione di
questa sensualità tollerata ci sono la purezza dell’anima e l’incrollabile fede
che l’una e l’altra si riflettono nella sublime bellezza di questo giovane
corpo, che, pur rimandando alla bellezza pagana, nell’idea del martirio si
riveste di sacralità e di una luce di eternità. Quest’aura di bellezza e di
intimo splendore che avvolge il corpo virile e nudo di San Sebastiano, cattura
l’attenzione di tutti i più grandi artisti dal Rinascimento ai giorni nostri,
che nel desiderio di sperimentare nuove accezioni del nudo maschile, partendo
dai canoni classici, si sono cimentati nella raffigurazione del santo.
Guido Reni fu dunque un pittore molto
ricercato proprio dalla committenza ecclesiastica, perché essa sapeva come il
pittore, meglio di ogni altro, poteva rendere l'immagine di grande e
coinvolgente attrazione. L'unico che poteva creare, in modo eccezionale, lo
spettacolo del corpo.
Quest’aspetto di misticismo-erotico era ben
noto agli artisti di quel periodo: Bernini, scolpendo il gruppo marmoreo di
Santa Teresa d'Avila, realizzato tra il 1647 e il 1653, lo rispecchia in pieno.
Nell’austera oscurità della chiesa
carmelitana di Santa Maria della Vittoria, un’immensa luce si apre nella
Cappella Cornaro, e con essa il rapimento della santa, colta dall’estasi,
trasforma la cappella nel palcoscenico di un teatro.
Gian Lorenzo Bernini, zelante lettore di
Ignazio di Loyola, ricorda un passo che aveva letto sull'estasi
nell'Autobiografia della santa, che racconta: «Un giorno mi apparve un angelo
bello oltre ogni misura. Gli vedevo nelle mani un lungo dardo d’oro, che sulla
punta di ferro mi sembrava avere un po’ di fuoco. Pareva che me lo configgesse
a più riprese nel cuore, così profondamente che mi giungeva fino alle viscere,
e quando lo estraeva sembrava portarselo via, lasciandomi tutta infiammata di
grande amore di Dio. Il dolore della ferita era così vivo che mi faceva
emettere dei gemiti, ma era così grande la dolcezza che mi infondeva questo
enorme dolore, che non c’era da desiderarne la fine, né l’anima poteva
appagarsi che di Dio. Non è un dolore fisico, ma spirituale, anche se il corpo
non tralascia di parteciparvi un po’, anzi molto. È un idillio così soave quello
che si svolge tra l’anima e Dio, che io supplico la divina bontà di farlo
provare a chi pensasse che io mento[5].»
L'angelo dirige in modo molto evidente il
dardo fiammeggiante, sollevando le vesti della Santa: l'estasi è vissuta come
esperienza erotica.
Il dardo-fallo che l'angelo orienta verso il
corpo della Santa – una chiara allusione al simbolismo erotico, messo in
evidenza dalle parole stesse di Teresa, che parla del penetrare e del
fuoriuscire del dardo – sconvolge l'ordine e il rigore. Le vesti, che l'angelo
solleva, sono tutte scomposte, come a porre l’accento sull'ardore, tanto
mistico quanto erotico, che invade la Santa in estasi. Ella è rappresentata con
le vesti scomposte, il corpo esanime e abbandonato, il capo rovesciato
all'indietro, il volto dolcissimo con le palpebre socchiuse, gli occhi rivolti
al cielo e le labbra dischiuse che si aprono per emettere un gemito.
L’angelo, raffigurato come un adolescente
giocoso, ricorda anche per l'abbigliamento l'Eros classico, ha in mano un
dardo, simbolo dell’Amore di Dio, le scosta le vesti per trafiggerla.
Bernini rappresentò l'esperienza dell'estasi
nel momento della sua massima intensità, nel momento culminante
dell’estasi-orgasmo, quello che maggiormente trasmette emozioni, sentimenti e
sensazioni forti in modo dettagliato ma nello stesso tempo con straordinaria
sensibilità.
Cosa che al tempo, non lo escluse dalle
polemiche.
In realtà, superato il crinale del 1600, la
cultura si avvia sempre più profondamente verso il Barocco assetato di
esperienza, da un lato conseguenza del nuovo tipo di approccio con il mondo che
l'indagine scientifica stava affermando, da un altro per l’azione profonda che
la Controriforma stava operando all’interno dell’individuo, scuotendone la
coscienza e accrescendo il senso di responsabilità di fronte al peccato.
L’interiorità del soggetto assume un’importanza nuova, un’importanza diversa:
nel “profondo del cuore”, nei suoi spazi sempre più bui e sconosciuti a mano a
mano che l’uomo del Seicento vi spinge lo sguardo, si ricercano le tracce di
una divinità che pare essersi ritirata nelle pieghe più recondite e oscure
della coscienza.
Centro di questo doppio versante
dell’esperienza è il corpo con i suoi sensi. Di tale rapporto tra esteriorità e
interiorità i sensi sono allo stesso tempo il punto di incontro, strumento e
criterio di indagine. Con i sensi il corpo barocco sprofonda nella realtà,
percependola nella sua densità carnosa e interrogandone il senso sfuggevole e
apparente. Con i sensi la cultura barocca s’immerge nell’interiorità
dell’immaginario e della coscienza a percepire l’emozione e la passione in
tutte le loro sfumature ed ambiguità, ma anche a sperimentare i segni del
divino e i modi della sua presenza. Questa sensualità, infatti, si spinge a
descrivere, a rappresentare e a esprimere anche l’esperienza del sacro.
I corpi dei martiri sono esibiti nella loro
nudità sofferente, mentre sono feriti, lacerati e sottoposti ai più feroci
supplizi; i corpi dei religiosi sono percorsi dall’emozione dell’estasi; i
corpi dei santi, tra schiere di angeli semivestiti, affollano soffitti, pareti
e absidi di chiese e cappelle.
Il linguaggio figurativo e letterario del
classicismo si piega a rappresentare questa nuova sensibilità.
In tale trasfigurazione del classicismo tutta
la vicenda evangelica della passione di Cristo, ad esempio, è messa in contatto
con il mito classico e la sua grande potenza immaginaria. Ne sono accentuati
gli aspetti patetici, ma ne sono anche declinate tutte le risonanze sensuali
come nella meravigliosa Flagellazione di Cristo che Caravaggio dipinta per la
chiesa di San Domenico a Napoli.
Così, mentre la pittura realistica di
Caravaggio cerca il divino nei corpi, la pittura classicista di Guido Reni
reinterpreta la classicità con una nuova sensibilità per la luminosità della
pelle e per il patetismo silenzioso dei gesti, coniugando iconologia classica e
contenuto religioso nei suoi San Sebastiano, sospesi fra tormento ed estasi.
La stessa sensualità investe gli oggetti
della realtà di tutti i giorni, nelle pitture dei grandi maestri fiamminghi,
come nei testi dei grandi mistici secenteschi. Costoro interrogano gli oggetti
nella semioscurità degli interni in cui quotidianamente e ordinariamente si
trovano, cogliendoli nei silenzi profondissimi da cui paiono sorgere e cui
ancora sembrano alludere, mentre si offrono allo sguardo pensoso che li
percorre. La dimensione nascosta della realtà, la sua evidente eppure
sfuggevole ragione d’essere scopre in tal modo la dimensione mistica del mondo,
in bilico tra presenza e assenza, tra attimo ed eternità, tra nulla e qualcosa.
Il Barocco coglie anche questa dimensione della realtà: gli oggetti, percepiti
attraverso i sensi e realisticamente rappresentati, diventano silenziosi
depositari di un’enigmatica verità, vicina al divino.
Un altro tema di grande importanza fu quello
dei santi in meditazione, tema rappresentato da alcuni dipinti tra cui due pale
di Battistello Caracciolo, raffiguranti due eremiti per eccellenza, San
Girolamo e Sant’Onofrio dando il suo contributo a questo tema.
Il San Girolamo è un olio su tela di 93 x 129
cm, databile intorno 1618, appartenente oggi alla Galleria Corsini.
Allievo dei manieristi Belisario Corenzio, Girolamo
Imparato e Fabrizio Santafede, Battistello (1578 - 1635) fu con Carlo
Sellitto, tra i primi ad abbracciare il verbo caravaggesco cui si era
avvicinato quando Caravaggio era giunto a Napoli per la prima
volta verso la fine del 1606, con un impatto immediato e molto profondo
sulla vita artistica della città. Battistello, di pochi anni più giovane di
Caravaggio, fu uno dei primi a testimoniare il nuovo stile e senz'altro fu uno
dei più talentuosi tra i vari artisti che si cimentarono con le tecniche
pittoriche introdotte dal grande maestro bergamasco, improntate al drammatico
tenebrismo di una pittura piana, poco profonda, con figure plastiche in cui la
luce acquistava un’importanza sempre maggiore rispetto alla prospettiva.
La potente opera di Battistello è stata un
fattore decisivo nel rendere Napoli, una roccaforte del caravaggismo. Un gruppo
di dipinti commissionati per le chiese napoletane rivela che egli poteva
interpretare in modo intelligente il realismo di Caravaggio, ma, a differenza
di tanti caravaggisti, guardò oltre gli stilemi di Caravaggio, emulando la
pittura del maestro, ma con profondità di sentimenti propri così come imparò a
padroneggiare l’uso drammatico della luce e dell’ombra.
Nel 1618 partì per Genova poi soggiornò a
Firenze e a Roma. Durante questi soggiorni apprese molto dal classicismo rivisitato
dei Carracci e si incontrò con pittori che condividevano con lui la riforma di
Caravaggio. Insolitamente per un artista caravaggesco, Battistello era anche un
valente pittore di affreschi e, di nuovo a Napoli, tradusse la sua esperienza
in grandiose scene di ampio respiro. Un esempio è il suo capolavoro, la
Lavanda dei piedi del 1622, dipinta per la Certosa di San Martino, che
segna una svolta nella produzione dell'artista, è infatti intrisa di un
profondo naturalismo, rivisitato alla luce dei modelli bolognesi e
toscani conosciuti durante i soggiorni a Roma, a Firenze e a Genova,
o ancora frequentando gli attivi cantieri delle chiese cittadine.
Nel San Girolamo in meditazione il santo
appare immerso in un paesaggio del suo stesso colorito bronzeo. Il suo profilo,
i capelli, la barba e la possente squadratura del braccio in luce sono
costruiti con un fitto reticolo di pennellate. Anche il teschio, sulla sinistra,
appare eseguito con quei risalti che Battistello aveva ammirato nel San Girolamo di Jusepe de Ribera attivo a Napoli di sicuro dal 1616.
La posizione del santo, concentrato nella
lettura del libro e non focalizzato sul teschio e sul crocifisso, è un’altra
citazione del San Girolamo di Ribera, purtroppo perduto e noto solo attraverso
stampe. Nell’opera di Battistello, infatti, compaiono la stessa posa di
concentrazione del santo sul volume; lo stesso restringimento della scena alla
sola figura, o quasi e quasi la stessa distribuzione delle rocce e del brano di
paesaggio. Originale di Battistello è invece la tonalità di azzurro cobalto e di
indaco del mantello del santo, reso con pieghe semplici e di plastica
classicità, così come risponde solo alla sua poetica la scelta di raffigurare
il santo ancora concentrato nella lettura in un’ora ormai notturna, con la luna
rossastra che spunta dal profilo di una roccia, incurante del giorno trascorso,
ancora dominato dalla volontà di apprendere.
Il Sant’Onofrio attribuito a Battistello da
Roberto Longhi e ormai dalla maggior parte degli studiosi è un olio su tela di
180,5 x 116,6, cm oggi esposto alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma a Palazzo Barberini.
Ancora una volta la raffigurazione di un
santo del Cristianesimo antico, ancora una volta un santo che ha preferito
l’isolamento dal mondo.
La vita di Sant'Onofrio è nota solo dal
racconto del suo discepolo, Pafnuzio, che lo incontrò nel deserto egiziano.
Secondo la tradizione agiografica Onofrio, il cui floruit è nel IV secolo, era
figlio di un re, che, appena nato, fu indicato da un demonio come
figlio di una relazione adulterina della regina: sottoposto alla prova
del fuoco, ne sarebbe uscito indenne, ma al suo ruolo di principe egli
preferì quella monastica e si fece monaco in un cenobio nei pressi di Tebe:
desideroso di una vita più solitaria sull’esempio di San Giovanni Battista e
del profeta Elia, lasciò il monastero per dedicarsi alla vita eremitica. Per
60-70 anni, visse da solo nel deserto dei frutti di un albero e di una palma
vicini alla sua grotta, e indossava solo i capelli e un perizoma di
foglie. Il vecchio vescovo Pafnuzio,
desideroso di conoscere la vita degli anacoreti del deserto, lo
incontrò e trascorse con lui gli ultimi giorni di vita di Onofrio, cui diede
sepoltura in una grotta e riportò la sua esperienza nel libro La Vita che
ebbe larga diffusione in Oriente dando l'avvio al culto di Sant'Onofrio che si
estese per tutta l'Asia minore. Fu raffigurato per la prima volta nell’Yilanlı
Kilise nella valle di Göreme, un museo a cielo aperto in Cappadocia.
Dal punto di vista iconografico le immagini
di Sant’Onofrio risultano dalla fusione con quelle del selvaggio dei
boschi, una figura mitica che appare nell’arte e nella letteratura
dell’Europa, infatti, è rappresentato come un uomo selvaggio vecchio
e nudo completamente ricoperto dei propri capelli, con indosso una cintura di
foglie. Ulteriori suoi attributi sono l'angelo, l'ostia e il calice,
il teschio, il cammello e il perizoma di foglie.
Battistello non pone nessuno degli attributi
iconografici, tranne il perizoma di foglie. La figura monumentale del santo, a
dispetto della sua posa apparentemente instabile, è perfettamente bilanciata
nello spazio del quadro. In piedi al centro del dipinto, la posa di Onofrio è
uno studio di movimenti contrapposti. L’uso di Caracciolo della luce non
annulla i dettagli di anatomia, come aveva fatto nel suo lavoro del 1610, ma
abilmente pone l’accento sulla tridimensionalità pittorica con cui l'artista ha
scolpito il corpo del santo. Un bel passaggio, questo nudo è descritto con un
gradevole forza formale, senza l'indulgenza caratteristica di Ribera. Il volto,
intenso e vibrante, è reso con pennellate rapide e senza alcun tentativo di
nascondere i segni della vecchiaia. Invece, il volto si trasforma con un’espressività
nobile che è accentuato solo dal severo, la gestione quasi monocromatica di
colore.
Recentemente è stato proposto un probabile collegamento
tra questo dipinto e l’Isaia di Cosimo Fanzago nella chiesa del Gesù
Vecchio a Napoli, che Battistello sembra aver utilizzato come fonte
compositiva. La figura monumentale del santo, a dispetto
della sua posa apparentemente instabile, è perfettamente bilanciata nello
spazio del quadro. La posa di Onofrio, in piedi al centro del
dipinto, è uno studio di movimenti contrapposti.
L’uso della luce di Battistello non annulla i
dettagli di anatomia, come aveva fatto nelle sue precedenti opere del 1610, ma pone
l’accento invece abilmente la tridimensionalità pittorica con cui l'artista ha
scolpito il corpo del santo.
È specificatamente affermato il ruolo dei santi e allo svilupparsi di nuovi culti parallelo alla ripresa di quelli tradizionali. Tra i nuovi canonizzati spiccano in modo particolare il cardinale Carlo Borromeo, e il fondatore degli Oratoriani Filippo Neri.
È specificatamente affermato il ruolo dei santi e allo svilupparsi di nuovi culti parallelo alla ripresa di quelli tradizionali. Tra i nuovi canonizzati spiccano in modo particolare il cardinale Carlo Borromeo, e il fondatore degli Oratoriani Filippo Neri.
L’iconografia borromaica è fissata da Il
digiuno di San Carlo commissionato a Daniele Crespi (1598 - 1630) dall’Ordine dei
Canonici Lateranensi.
In questo dipinto, olio su tela di 190 x 265 cm, datato intorno al 1625 e collocato nella Chiesa di Santa Maria della Passione a Milano, Crespi ritrae l’ascetica figura di San Carlo mentre è seduto in pensoso raccoglimento nella quasi completa solitudine degli esercizi spirituali che assorbivano ogni attimo del suo tempo libero.
In questo dipinto, olio su tela di 190 x 265 cm, datato intorno al 1625 e collocato nella Chiesa di Santa Maria della Passione a Milano, Crespi ritrae l’ascetica figura di San Carlo mentre è seduto in pensoso raccoglimento nella quasi completa solitudine degli esercizi spirituali che assorbivano ogni attimo del suo tempo libero.
L’immagine del santo vescovo emerge
dall’oscurità con la forza di una fiamma intensa. Un’ombra di barba incornicia
il suo volto pallido magro e affilato, la fronte aggrottata nell’intensità
della lettura e della meditazione. Il suo volto è segnato dalle astinenze e dai
digiuni, scavato dalle preoccupazioni per il suo gregge, solcato dalle lacrime suscitate
il lui dalla rimeditazione della Passione di Cristo. Il volto è emaciato, ma il
suo sguardo è vivo e diritto e la sua sofferenza si stempera in un timido
sorriso, segno dell’interiore felicità dell’estasi e dell’amore di un padre. Pur
essendo un principe della Chiesa, come evidenzia la porpora del suo abito, il
suo pasto consiste soltanto in un pezzo di pane e in un sorso d’acqua, perché
la testimonianza evangelica è vissuta giorno dopo giorno, nella solitudine
della propria stanza, perché la coerenza e il rigore iniziano prima di tutto
con sé e da se stessi. Il suo vero cibo, quotidiano e inesauribile, è in quel Crocifisso
che sta lì, di fronte a lui.
La composizione è spoglia e austera,
volutamente essenziale, in modo da suscitare la partecipazione immediata e
commossa dello spettatore. Il fondo della scena è scuro, illuminato solo da una
flebile luce notturna che sottolinea la povertà e la drammaticità del completo
abbandono di San Carlo a Cristo.
L’attenzione ai dettagli, come gli oggetti da natura morta sulla tavola, un pane, una bottiglia d’acqua e il bicchiere, avvicinano
questo personaggio al vissuto quotidiano dei fedeli. Quel pane sulla tavola
nuda di Carlo ricorda quello della mensa di Emmaus di caravaggesca memoria. L’acqua
limpida e cristallina racconta un’intima purezza dell’anima. Il cappello
cardinalizio è posato su un altro banco, ai piedi del Cristo in Croce e simboleggia
l’affidamento completo e senza riserve del ministero sacerdotale e pastorale di
Carlo. Tutto è sospeso nel silenzio: i due uomini sullo sfondo, che scrutano
dalla porta non osano entrare, per paura di disturbare, per timore di
distogliere il Santo dalla sua religiosa meditazione, e intanto osservano,
apprendono, capiscono.
Sulla tavola austera il cibo materiale quasi
si annulla, sostituito dal nutrimento della parola attinta dalle pagine del
libro che sta leggendo. Il crocifisso che fa da guardia su un altro tavolino in
disparte suggerisce che il tema della meditazione sia quello doloroso della
passione di Cristo, in effetti centrale nello stile di pietà in cui il Borromeo
amava immergersi.
La scena è tutta svolta con la massima
compostezza. La concentrazione spirituale coinvolge tanto San Carlo da muoverlo
al pianto e a mescolare le lacrime al pane.
Il messaggio è quello della rinuncia e dello
svuotamento di sé: imboccando la strada maestra della penitenza, nutrendosi della
parola di Dio, sotto lo sguardo del Cristo della croce, san Carlo si identifica
con il suo modello, ne condivide la sofferenza nelle sue stesse carni, con il
corpo consunto dalle mortificazioni, il volto magro e scavato. Ci troviamo
davanti a un martire della militanza, che vive la santità fino al sacrificio
supremo[6].
Carlo Borromeo morì, infatti, di consunzione, a soli 46 anni, dopo aver dato
tutto alla sua gente e alla sua Chiesa. Per questo forse è tale il ritratto più
intenso e più vero di san Carlo.
Daniele Crespi dipinse il quadro attorno al
1625, meno che trentenne. Eppure una profonda maturità ispira quest’opera. Crespi
era uno degli allievi più dotati, anche se forse non dei più assidui della
nuova Accademia Ambrosiana, voluta dal cardinale Federico Borromeo di cui Crespi
aveva fatto suoi il motto “quotidianità e decoro”, anche se con le varianti e
le innovazioni del genio. Daniele sembrava nato talentuoso. Quel prodigioso
talento guidava il suo pennello, lasciando stupiti colleghi e committenti, ma
il giovane Crespi sembrava bruciare le tappe, come se avesse intuito che la sua
vita sarebbe stata troppo breve. Visse, infatti, appena trentadue anni
stroncato anche lui dalla peste del 1630 raccontata da Manzoni. Era diventato
ben presto una figura artistica di spicco nella Milano seicentesca, dominata
dagli spagnoli e posta sotto la guida morale di Federico Borromeo. La sua arte,
caratterizzata da un profondo ascetismo morale e da una forte attenzione al
reale, lo portò a lavorare per gli importanti cantieri del Duomo e di Santa
Maria della Passione a Milano, e a quello della certosa di Pavia. Poi un
viaggio a Genova nel 1622 e l’incontro con Velázquez furono fondamentali e le committenze
dei grandi Ordini religiosi e la formazione di una scuola che ne proseguì i
dettami.
Sono soprattutto i particolari, in questa
tela a colpirci. Come sempre nella pittura di Daniele Crespi.
Crespi portò una ventata rivoluzionaria nella
pittura lombarda del primo Seicento, e questo dipinto ne è forse una delle più
alte testimonianze. Nulla di superficialmente devozionale vi è in quest’opera
che parla di un uomo che agiva come predicava, e come pensava, davvero qualcosa
di straordinario era accaduto, se si pensa che il suo predecessore era morto di
indigestione senza aver mai messo piede nella diocesi che gli era stata
assegnata.
La raffigurazione di San Filippo Neri è
invece legata alla maestria di Guido Reni. La commissione di realizzare
l’estasi di Filippo Neri gli fu affidata all’indomani della canonizzazione per
la Chiesa di Santa Maria in Vallicella.
Nel Ritratto di san Filippo, Guido ritrae il
santo della gioia non come egli era realmente da giovane, quando cadde in
estasi nelle catacombe di San Sebastiano e un globo di fuoco gli implose nel
petto, e non lo raffigura nemmeno come un povero tra i poveri, quando vestito
di semplice tonaca sdrucita girava per i luoghi malfamati e i bassifondi di
Roma, ma come un sacerdote nell’atto di celebrare la Messa, con i paramenti
sacri del rito tridentino, adornato di quell’oro e di quel damasco scarlatto
che Filippo aveva sempre rifiutato sempre. San Filippo, però è un martire della
Carità per questo è raffigurato in abito sacerdotale rosso, il colore dei
Martiri, ed è inginocchiato, con le braccia aperte in adorazione davanti alla
Madonna con il Bambino. In basso il giglio bianco, simbolo del Santo. Ma la sua
estasi, la Visione insostenibile di Dio è resa perfettamente. Filippo guarda di
là dal mondo, oltre la tela, oltre chi guarda il dipinto stesso. Questo modo di
raffigurazione di San Filippo Neri diventò quasi “ufficiale” anche grazie alla
diffusione delle stampe.
In conclusione il tema del rapporto tra fede,
Chiesa e arte da secoli dibattuto ancor oggi affascina ed emoziona, sebbene
spesso abbia causato aspre tensioni e dall’Illuminismo in poi abbia ricevuto fin
troppe critiche distruttive. Se il Concilio di Trento ha riaffermato il valore
dell’arte “per la venerazione e l’istruzione”, spesso con faciloneria e per superficiale
anticlericalismo il “Decreto XXV“ è ricordato solo per alcune infelici applicazioni,
come i risibili “braghettoni” della Cappella Sistina, e se ne nega o peggio se
ne ignora ogni aspetto realmente positivo.
Si è visto, attraverso alcune opere esemplari,
quanta ripercussione il Decreto abbia avuto sullo sviluppo dell’arte sacra, innanzitutto
smantellando le bizzarrie del Manierismo imperante. Il decreto ha suscitato un
dibattito con posizioni spesso contrastanti, aprendo e approfondendo
interrogativi e riflessioni utili per migliorare la conoscenza dell’arte, della
storia, della teologia, ma anche della vita religiosa in tutti i suoi aspetti
compresi quelli antropologici.
Il testo del decreto, di un equilibrio
politico ed estetico notevole, mirava in primo luogo a contenere l’ondata di
iconoclastia che aveva travolto i Paesi protestanti, trascinati dal conflitto
fra i principi, con la distruzione di crocifissi, di chiese e di secolari monasteri.
L’arte sacra in base ad esso doveva assolvere
ad alcune funzioni.
In primo luogo l’arte sacra doveva svolgere
una funzione contemplativa: attraverso forme ed espressioni sensibili l’arte doveva
predisporre il fedele a un dialogo di preghiera con Dio pertanto l’espressione
artistica guidava alla contemplazione. L’arte cristiana, infatti, da sempre rappresenta
l’adesione dell’umano al divino e, tramite essa il fedele, aiutato nella
contemplazione, può compiere il passaggio dal sensibile al sovrasensibile, dal
concreto all’astratto.
In secondo luogo l’arte doveva svolgere una funzione
commemorativa, infatti, nella storia cristiana c’è bisogno di tramandare le
verità di fede, mantenendole sempre vive nel cuore di ogni fedele attraverso la
raffigurazione della vita di Gesù, delle Sue sofferenze e dei Suoi miracoli. In
questo modo il fedele ricorda che Dio, il Verbo, si è fatto uomo e attraverso di
Lui è avvenuta la salvezza del mondo.
In terzo luogo l’arte deve svolgere una funzione
didascalica in base alla quale essa diventa uno strumento che consente all’uomo
di apprendere velocemente e subito i concetti cristiani. L’arte è un mezzo d’insegnamento
valido a tutti i livelli: da un primo stadio più semplice fino
all’apprendimento di temi teologici molto più complessi, che comportano una
preparazione più avanzata da parte del fedele. Chi era senza cultura, ed era la
maggior parte dell’umanità, se non poteva leggere sui libri, doveva avere la
possibilità di apprendere guardando le pareti. Le immagini servivano come libro
per gli illetterati per lo più poveri e in grande percentuale per una corrispondenza
immediata. Era stato questo il senso dei cicli musivi, pittorici e scultorei
realizzati nei vari secoli nelle chiese e nelle cattedrali. Infine l’arte
doveva avere una funzione decorativa, che comunque non era fine a se stessa, ma
era legata al principio che la bellezza proviene da Dio. Intorno alla figura
centrale di Gesù, nell’arte ruota una serie di raffigurazioni che contribuisce
a rivelare in varia misura, ma sempre la presenza di Dio. Lo stesso uso di
materiale pregiato serviva a manifestare, attraverso la ricchezza che esprime,
la presenza divina: per questo motivo l’arte liturgica è realizzata
prevalentemente con materiali preziosi perché, essendo essa al servizio del
culto divino e in ogni sua parte deve sottintendere un profondo significato
simbolico.
Infine, siccome verso l’inizio del
Cinquecento in Europa del nord era dilagata una nuova forma iconoclastica
protestante, anche la riforma cattolica, definita nel Concilio di Trento, si
occupò dell’arte cristiana: l’arte fu definita potente strumento utile a
diffondere e a mantenere viva la fede in tutti i popoli. Da quel momento in poi
vi fu una grande diffusione di quei temi cristiani che, essendo rifiutati dai
riformati, dovevano essere affermati dalla religione cattolica attraverso uno
stile molto coinvolgente, uno stile di arte riformata che maturò poi nel Barocco.
Ma questo sarà un altro
grande capitolo della Storia dell’arte e della bellezza.
[1] APPENDICE I «Il Santo Sinodo comanda a
tutti i vescovi e a quelli che hanno l’ufficio e l’incarico di insegnare, che -
conforme all’uso della Chiesa Cattolica e Apostolica, tramandato fin dai primi
tempi della religione cristiana, al consenso dei Santi Padri e ai decreti dei
Sacri Concili, - prima di tutto istruiscano diligentemente i fedeli
sull’intercessione dei santi, sulla loro invocazione, sull’onore dovuto alle
reliquie, e sull’uso legittimo delle immagini, insegnando che i Santi, regnando
con Cristo, offrono a Dio le loro orazioni per gli uomini; che è cosa buona ed
utile invocarli supplichevolmente e ricorrere alle loro orazioni, alla loro
potenza e al loro aiuto, per impetrare da Dio i benefici, per mezzo del suo
figlio Gesù Cristo, Nostro Signore, che è l’unico redentore e Salvatore nostro;
e che quelli, i quali affermano che i santi - che godono in cielo l’eterna
felicità - non devono invocarsi o che essi non pregano per gli uomini o che
l’invocarli, perché preghino anche per ciascuno di noi, debba dirsi idolatria,
o che ciò è in disaccordo con la parola di Dio e si oppone all’onore del solo
mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo; o che è sciocco rivolgere le
nostre suppliche con la voce o con la mente a quelli che regnano nel cielo, pensano
empiamente. [...]
Inoltre le immagini di
Cristo, della Vergine Madre di Dio e degli altri santi devono essere tenute e
conservate nelle chiese; ad esse si deve attribuire il dovuto onore e la
venerazione: non certo perché si crede che vi sia in esse una qualche divinità
o virtù, per cui debbano essere venerate; o perché si debba chiedere ad esse
qualche cosa, o riporre fiducia nelle immagini, come un tempo facevano i
pagani, che riponevano la loro speranza negli idoli, ma perché l’onore loro
attribuito si riferisce ai prototipi, che esse rappresentano. Attraverso le
immagini, dunque, che noi baciamo e dinanzi alle quali ci scopriamo e ci
prostriamo, noi adoriamo Cristo e veneriamo i santi, di cui esse mostrano la
somiglianza. Cosa già sancita dai decreti dei concili - specie da quelli del
secondo concilio di Nicea - contro gli avversari delle sacre immagini. Questo,
poi, cerchino di insegnare diligentemente i vescovi: che attraverso la storia
dei misteri della nostra redenzione, espressa con le pitture e con altre
immagini, il popolo viene istruito e confermato nel ricordare gli articoli di
fede e nella loro assidua meditazione. Ed inoltre, che da tutte le sacre
immagini si trae grande frutto, non solo perché vengono ricordati al popolo i
benefici e i doni che gli sono stati fatti da Cristo, ma anche perché nei santi
sono posti sotto gli occhi dei fedeli le meraviglie e gli esempi salutari di
Dio, così che ne ringrazino Dio, cerchino di regolare la loro vita e i loro
costumi secondo l’imitazione dei santi, siano spinti ad adorare ed amare Dio e
ad esercitare la pietà. Se qualcuno insegnerà o crederà il contrario di questi
decreti, sia anatema. Se poi, contro queste sante e salutari pratiche, fossero
invalsi degli abusi, il Santo Sinodo desidera ardentemente che essi siano
senz’altro tolti di mezzo. Pertanto non sia esposta nessuna immagine che
esprima false dottrine e sia per i semplici occasione di pericolosi errori. Se
avverrà che qualche volta debbano rappresentarsi e raffigurarsi le storie e i
racconti della Sacra Scrittura – questo infatti giova al popolo poco istruito –
si insegni ad esso che non per questo viene raffigurata la divinità, quasi che
essa possa esser vista con questi occhi corporei o possa esprimersi con colori
ed immagini. Nella invocazione dei santi, inoltre, nella venerazione delle
reliquie e nell’uso sacro delle immagini sia bandita ogni superstizione, sia
eliminata ogni turpe ricerca di denaro e sia evitata ogni licenza, in modo da
non dipingere o adornare le immagini con procace bellezza.
[...]
Da ultimo, in queste cose
sia usata dai vescovi tanta diligenza e tanta cura, che niente appaia
disordinato, niente fuori posto e rumoroso, niente profano, niente meno onesto:
alla casa di Dio, infatti, si addice la santità. E perché queste disposizioni
vengano osservate più fedelmente, questo santo sinodo stabilisce che non è
lecito a nessuno porre o far porre un’immagine inconsueta in un luogo o in una
chiesa, per quanto esente, se non è stata prima approvata dal vescovo; né
ammettere nuovi miracoli, o accogliere nuove reliquie, se non dopo il giudizio
e l’approvazione dello stesso vescovo. Questi, poi, non appena sia venuto a
sapere qualche cosa su qualcuno di questi fatti, consultati i teologi ed altre
pie persone, faccia quello che crederà conforme alla verità e alla pietà. Se
infine si presentasse qualche abuso dubbio o difficile da estirpare o se
sorgesse addirittura qualche questione di una certa gravità intorno a questi
problemi, il vescovo, prima di decidere aspetti l’opinione del metropolita e
dei vescovi della regione nel concilio provinciale. Comunque, le cose siano
fatte in modo tale, da non stabilire nulla di nuovo o di inconsueto nella
chiesa, senza aver prima consultato il santissimo pontefice romano».
[2]
Barocci fu
l’artista più originale nell’Italia centrale del suo tempo e i suoi lavori più
ambiziosi sono considerati "La deposizione della Croce", nel "Duomo"
di Perugia, "La Madonna del popolo" della "Galleria
degli Uffizi" e il "Martirio di san Vitale" della "Pinacoteca
di Brera", opera questa che influenzò notevolmente il "Martirio
di san Livinio" di Rubens.
[3] L’art
religieux après le Concile de Trente. Etude sur l’iconographie de la fin du
XVIe siècle, du XVIIe, du XVIIIe siècle. Italie, France, Espagne, Flandres,
[4] in Storia
dell’arte italiana. Parte Prima. Materiali e problemi, a cura di G.
Previtali, 4 voll., Torino 1979-1980, III, L’esperienza dell’antico,
dell’Europa, della religiosità, 1979, pp. 271-318
[5] (Teresa d'Avila, Autobiografia,
XXIX,13 )
[6] La sua, è una santità eroica, che si
riversa nella lotta: una lotta che educa in primo luogo a spogliarsi di sé, a
correggere le storture, a impegnarsi senza tregua contro la realtà negativa del
mondo che intralcia l’obbedienza alle richieste della fede e il rispetto senza
sconti della legge etica.